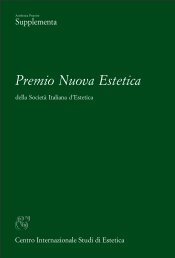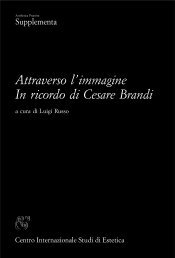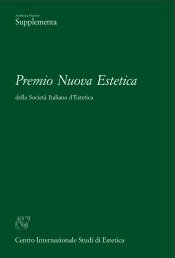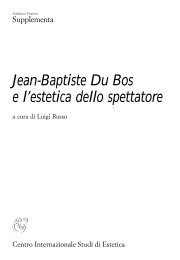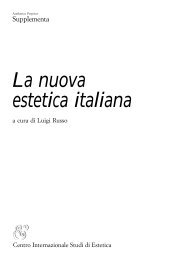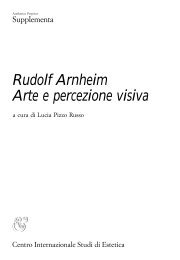espresso dall’effetto. Da un lato, tale strato sembra reperibile solo aposteriori, essendo per nulla definibile prima che si realizzi una figurad’effetto anche grazie all’orientamento cui presiedono le scelte <strong>del</strong> gusto.Dall’altro, la sua articolazione appare ineludibile, e dunque essopossiede un carattere vincolante che si avvicina alla obbligatorietà apodittica,fino ad assumere una sorta di forza analitica che tende a escludereesiti ed effetti alternativi. Si compone in tal modo anche all’interno<strong>del</strong>la teoresi estetica di <strong>Morpurgo</strong> quella paradossale entità <strong>del</strong>l’“analiticoa posteriori” che non sorprende chi si muove nei dintorni<strong>del</strong>la fenomenologia (andando da Stumpf a Paci, per indicare unospettro di posizioni che sia il più ampio possibile) e che caratterizzadinamiche di costituzione materiale passiva parzialmente note addiritturaal Kant <strong>del</strong>la terza Critica. E credo che in tale luogo stia il baricentro<strong>del</strong>lo scandaglio storiografico (attraverso la nozione di gusto) eteoretico (attraverso la nozione di giudizio) effettuato da <strong>Morpurgo</strong> perquel che concerne la fruizione estetica. Si legge quindi in Gusto e Giudizioche «è il risultato <strong>del</strong> gusto che guida la ricerca di un principiodi giudizio», poiché il criterio <strong>del</strong> gusto, la «categoria <strong>del</strong> preferibile»,«non può che risultare a posteriori» (ivi, p. 223) ed «è ciò che è statoapprezzato e preferito che determina quel che si deve apprezzare epreferire» (ivi, p. 221): «l’oggetto <strong>del</strong> gusto è preferibile e adeguatoperché scelto, non è scelto perché adeguato e preferibile» (ivi, p. 223).Non altrove sta il motivo <strong>del</strong>la paradigmaticità <strong>del</strong>l’oggetto artistico e<strong>del</strong>la corrispondente individualità <strong>del</strong> giudizio critico: «in questo casogusto e giudizio, due procedimenti eterogenei, uno intuitivo e l’altroriflessivo, l’uno ostensivo e l’altro classificatorio, hanno in comune unpunto in cui si congiungono il cogliere il risultato individuale <strong>del</strong>l’artee il farne, l’uno il motivo di una scelta, l’altro il criterio <strong>del</strong> giudiziosu una scelta. La regola, o finalità <strong>del</strong>la scelta di un’opera d’arte,è l’opera d’arte stessa» (ivi, p. 231).7. Se si considera il giudizio critico e, più in generale, l’esperienzaestetica dal punto di vista <strong>del</strong>la speculazione formale ispirata al canone<strong>del</strong>la purezza <strong>del</strong>la ragione, appare arduo cogliere il potenziale teoretico<strong>del</strong>l’intreccio tra idee e gesti, tra conoscenza e azione e tra noesise aisthesis di cui vive l’ambito materiale tematizzato dalla tradizione dipensiero di cui anche <strong>Morpurgo</strong> è erede. E, d’altro canto, solo a pattodi seguire <strong>Morpurgo</strong> su questo terreno risultano chiare le parole concui egli conclude il passaggio di Gusto e Giudizio su giudizi determinantie giudizi riflettenti, laddove si precisano i caratteri dei principiregolativi dei giudizi critici, che interessano «non la natura ma lo status<strong>del</strong>l’oggetto rispetto al soggetto, il suo richiedere una certa rispostapreferenziale, il suo rapporto con il nostro comportamento». Prosegue<strong>Morpurgo</strong>: «il valore che si attribuisce a un oggetto qui è la capacità71
che gli si riconosce di provocare questo comportamento» (ivi, p. 224).Dunque, l’oggetto assume senso nella misura in cui diviene paradigmadi potenziali atti di significazione che si configurano come comportamentie non come designazioni, azioni e non denotazioni, che si estrinsecanoin un fare e non meramente in un dire. L’affiorare dal seno<strong>del</strong>l’esperienza di principi di sensatezza, o di valore, esclude ovviamenteun procedimento deduttivo per la loro individuazione, ma si allontanaaltrettanto decisamente dal procedimento induttivo-empiristico ingrado, al più, di metter capo a classi determinanti. Si tratta piuttosto,scrive <strong>Morpurgo</strong>, di «ricorrere a un giudizio che non qualifichi un oggettoclassificandolo ma singolarizzandolo; ricorrere a una classe chenon definisca i suoi esemplari ma ne sia definita […]; paradossalmente,una classe a un solo esemplare» (ivi, p. 236). Lo slittamento dallavera e propria predicazione alla singolarizzazione che si rivela utile perfuturi gesti espressivi consente di tesaurizzare la curvatura pragmatisticaimpressa alla stessa nozione di senso-valore. I significati, anzichéconstatati, vengono qui agiti. Quando poi <strong>Morpurgo</strong> accentua l’inerenzadei giudizi critici allo «status» <strong>del</strong>l’oggetto contrapposto alla obiettivante«natura» di esso, egli sottolinea al tempo stesso come l’esperienzain questione possa considerarsi soggettuale (non già meramentesoggettiva) poiché costituita dai e nei comportamenti che cor-rispondonoalla espressività degli enti a cui ci si rapporta e che si realizzanocome «esplicitarsi riflessivo nel giudizio […] di quel “dover essere”, diquella obbligazione di cui siamo consapevoli nell’atto <strong>del</strong> gusto» (Fenomenologia<strong>del</strong> giudizio critico, p. 27).8. Da ultimo, si può quindi affermare che l’ancoraggio a uno stratocostitutivo che eccede la rete <strong>del</strong>la referenzialità obiettivante, e in cuisi salvaguarda la espressività quale radice stessa <strong>del</strong>la sensatezza – poiché«la rappresentazione artistica è un esibire valori, [e] non va confusacon il formulare valutazioni» (Fenomenologia <strong>del</strong> giudizio critico,p. 34), e dunque non si risolve in attualità esperienziali determinateconfigurandosi piuttosto come «apertura di possibilità» (cfr. ivi, p. 40),che «crea una regola, ma non funziona da regola» (ivi, p. 42) – fa sìche <strong>Morpurgo</strong> imposti il problema <strong>del</strong>la fruizione estetica come problema<strong>del</strong>l’articolazione <strong>del</strong>lo spettro “semantico”. Certo, ciò accadesulla base anche di una concezione spregiudicata <strong>del</strong>la dinamica <strong>del</strong>lasensatezza, in grado di misurarsi pionieristicamente, ad esempio,con la tradizione austiniana <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>la performatività, con laquale <strong>Morpurgo</strong> condivide almeno il riconoscimento <strong>del</strong>la pluralità evarietà <strong>del</strong>lo spettro <strong>del</strong>la significatività. Vedendo il problema <strong>del</strong> sensocome prioritario rispetto alla dinamica <strong>del</strong> riferimento e <strong>del</strong> segnoegli intende rovesciare il corso <strong>del</strong>la riflessione maggiormente seguitonell’ultimo secolo. Così, mentre «non di rado i trattatisti partono dal72
- Page 1 and 2:
Aesthetica PreprintGuido Morpurgo-T
- Page 4 and 5:
Guido Morpurgo-Tagliabuee l’estet
- Page 6 and 7:
Un marziano in esteticadi Luigi Rus
- Page 8 and 9:
sava candidamente - nel pianificare
- Page 10 and 11:
che onora la cultura italiana, si p
- Page 12 and 13:
grafia estetica era stato dominato
- Page 14 and 15:
sciuto di Morpurgo e che ha avuto f
- Page 16 and 17: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica in
- Page 18 and 19: e l’estetica idealista italiana m
- Page 20 and 21: queste due «novità fondamentali»
- Page 22 and 23: 4Pubblicati rispettivamente in “R
- Page 24 and 25: un’estetica piuttosto articolata
- Page 26 and 27: Non desidero limitarmi a rilevare l
- Page 28 and 29: imprecisione: le differenze indicat
- Page 30 and 31: ino»; e la seconda accusa, conclud
- Page 32 and 33: scinanti, perché rappresentano pi
- Page 34 and 35: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica de
- Page 36 and 37: pensava soprattutto al fatto che il
- Page 38 and 39: apprende l’armonia della musica.
- Page 40 and 41: dal punto di vista del fruire: […
- Page 42 and 43: Bodmer riportava larghi estratti de
- Page 44 and 45: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica it
- Page 46 and 47: de quella stagione determinata, dal
- Page 48 and 49: che «in pratica dal giudicio dell
- Page 50 and 51: che agguaglino la forza degli origi
- Page 52 and 53: Perfetta poesia, e cioè quando Mur
- Page 54 and 55: 28Ibid., p. 63.29G. B. Gravina, De
- Page 56 and 57: è l’incrocio Gravina-Vico operat
- Page 58 and 59: classe nell’individuo, il quale,
- Page 60 and 61: Siano qui sufficienti alcuni cenni:
- Page 62 and 63: Implicazioni del nessotra gusto e g
- Page 64 and 65: gusto abbia statuto catacretico e i
- Page 68 and 69: modello del significare segnico in
- Page 70 and 71: ne» 3 . Scrive Morpurgo-Tagliabue
- Page 72 and 73: mento che quest’ultima implica un
- Page 74 and 75: do Morpurgo-Tagliabue gusto e giudi
- Page 76 and 77: conseguenza possiamo identificare u
- Page 78 and 79: 1Guido Morpurgo-Tagliabue, Il conce
- Page 81 and 82: Guido Morpurgo-Tagliabue:le sublime
- Page 83 and 84: son assimilation ultime à l’él
- Page 85 and 86: pective, comparer à celle de Giamb
- Page 87 and 88: (3) Cet idéal de beauté féminine
- Page 89 and 90: hors de l’écheveau complexe du v
- Page 91 and 92: Prendre le parti d’un tableau pr
- Page 93 and 94: tion» sur laquelle insiste Wittgen
- Page 95 and 96: Mais le problème est de ne pas se
- Page 97 and 98: 33 Ricercari Nowau. Una forma di or