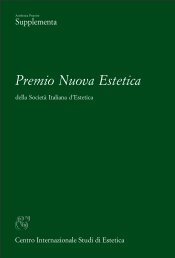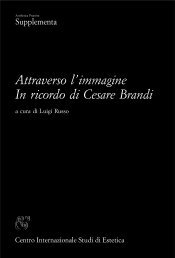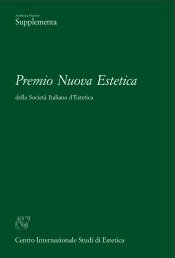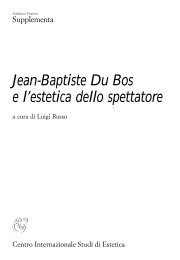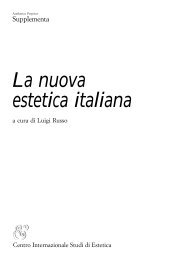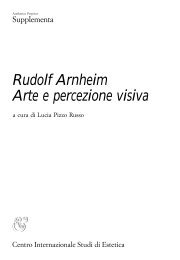do <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong> gusto e giudizio sono due atti separati: il primoè un «senso tacito», con in quale apprezziamo e preferiamo unoggetto, il secondo invece è un atto di riflessione critica; nello stessotempo sono due atti complementari: un atto immediato e una riflessionesu di esso. Inoltre entrambi hanno un punto in comune: se per ilgusto di tratta di «sentire qualche cosa non come è, ma come deve essere»,anche il giudizio «opera in base a un dover essere, stabilito daun criterio, da una regola» 30 .Nel giudizio è ciò che è stato apprezzato e preferito a determinarequel che si deve apprezzare e preferire; invece per il gusto il bellonon è ciò che deriva da un criterio precostituito di bellezza, ma ciòche attrae senza motivo e, imponendosi, diventa mo<strong>del</strong>lo. L’oggetto<strong>del</strong> gusto è preferibile e adeguato perché scelto; al contrario un oggettodi giudizio non è bello perché lo scelgo, ma lo scelgo perché è bello.Chi sceglie secondo il gusto, difficilmente può esporre i criteri dilegittimità <strong>del</strong>la sua scelta. Inoltre, se l’apprezzamento <strong>del</strong> gusto cogliel’oggetto nella sua individualità, invece il giudizio, in quanto classificatorio,coglie l’oggetto come membro di una classe, attraverso alcunitratti pertinenti che lo identificano in quanto tale. In definitiva, se ilgusto è individuale, il giudizio è classificatorio. Soltanto nel primo casol’oggetto è criterio a se stesso; nell’altro caso esso viene definito, ossiasussunto in una classe, mediante tratti pertinenti. Il gusto è un «sentire»l’individualità <strong>del</strong>l’oggetto in relazione a tutto ciò con cui quell’oggettopresenta «somiglianze di famiglia», nel senso <strong>del</strong> Wittgenstein<strong>del</strong>le Ricerche filosofiche, giacché è rispetto a tale “totalità” chequesta individualità si è venuta configurando. In questo senso <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>,riprendendo una tesi di Pareyson, afferma che la forma<strong>del</strong>l’oggetto artistico è il risultato <strong>del</strong> suo processo formativo. E, datoche tale processo non segue vie logiche, il risultato, ossia la forma,sempre provvisorio, si presenta come imprevedibile: di qui lo stupore,la meraviglia che genera in noi l’opera d’arte.A differenza <strong>del</strong> giudizio «rettorico» e <strong>del</strong> giudizio «estetico», iquali riferiscono un oggetto a una categoria normativa, la scelta <strong>del</strong>gusto è vicina a un’altra forma di giudizio, che non è l’inserzione di unindividuo in una classe, ma l’individuazione <strong>del</strong>la «ecceità» di un oggetto.Si tratta di un «giudizio individuale» e non classificatorio, voltoa rendere conto <strong>del</strong>l’interezza e individualità <strong>del</strong>l’opera, valutandolasecondo «la legge propria che regola quell’organismo singolare, e infunzione <strong>del</strong>la quale esso si è formato» 31 . Il che vuol dire giudicarel’opera come deve essere, in relazione alla sua regola interna. Ma vuoldire anche che l’opera d’arte, dal momento che è quella che è in basea un processo interno, implica una «lettura», che renda ragione <strong>del</strong>lasua formazione. Qui ritroviamo dunque la complementarità di gusto egiudizio, in quanto appunto giudizio individuale. Se il gusto «coglie di80
colpo», per dirla ancora con Wittgenstein, l’unità degli elementi checompongono l’opera, il giudizio «legge» il processo attraverso il qualequegli elementi si sono formati in unità. Scrive <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>a questo proposito: «La prerogativa <strong>del</strong> giudizio individuale sta appuntoin questo: che l’accento non cade sulla regola normativa di riuscita<strong>del</strong> processo formativo, e nemmeno sul processo <strong>del</strong>la riuscita elevatoa legge, ma sulla riuscita di quel processo, di quel risultato, ossiadi quella riuscita. In altri termini sta in quel processo come valore materialee non formale. Accontentarsi di un criterio formale di giudizio,vorrebbe dire perderne il carattere individuale: e ritornare a un giudizioo categoriale o classificatorio […] Il pericolo presente in ogni giudizioestetico è proprio di arrestarsi a un valore formale: alla soddisfazione<strong>del</strong> risultato raggiunto, <strong>del</strong>l’attesa-risposta; anziché cogliere unvalore materiale» 32 .Un tale giudizio individuale si istituisce dunque non in relazione auna classe ma a una «famiglia»: «Non esiste la regola o classe materiale<strong>del</strong> preferibile: sarebbe una classe senza “notae” […] Esiste la famiglia<strong>del</strong> preferibile a posteriori, ossia l’insieme <strong>del</strong>le cose preferite nelpresente con un senso di obbligazione» 33 . Un oggetto definito “bello”non è l’esemplare di una classe, ma qualcosa di unico, e tale unicità oindividualità si configura come il “precipitato” di una molteplicità disomiglianze e differenze, ossia di una rete di «somiglianze di famiglia».È questo che fa di un oggetto artistico qualcosa di «paradigmatico»,vale a dire un mo<strong>del</strong>lo senza esemplari. Una conseguenza di questorapporto tra «famiglia» e individuo (l’opera in quanto individualità) èche, se l’opera d’arte non è un’immagine mentale che si esprime in unoggetto materiale, ma è una “cosa”, ossia un oggetto concreto che sicostruisce materialmente, allora vengono rivalutati gli elementi formali,ovvero materiali <strong>del</strong>l’opera stessa.Vediamo meglio tale questione, anche in relazione alle riflessioni diun filosofo come Wittgestein che, seppure soltanto implicitamente, ètuttavia sicuramente presente in questo saggio, Gusto e giudizio; ne èun segnale la nozione di «famiglia»: non si tratta soltanto <strong>del</strong>l’uso diuna nozione, ma di una questione che è insieme estetica ed epistemologica.Nella conoscenza il principio di classificazione, in base al qualericonosciamo un oggetto o fenomeno in quanto appartenente a unaclasse, implica la nozione di «famiglia», nel senso che questa è la condizioneimplicita di quello. Prima – e qui “prima” è inteso non in sensocronologico bensì trascendentale, come “condizione” – di classificareun “universo” di oggetti o fenomeni, noi “cogliamo” una rete disomiglianze e differenze tra questo oggetto o fenomeno e un insiemedi oggetti o fenomeni, che hanno con quello appunto somiglianze difamiglia. È grazie a queste relazioni che si costituisce una classe e di81
- Page 1 and 2:
Aesthetica PreprintGuido Morpurgo-T
- Page 4 and 5:
Guido Morpurgo-Tagliabuee l’estet
- Page 6 and 7:
Un marziano in esteticadi Luigi Rus
- Page 8 and 9:
sava candidamente - nel pianificare
- Page 10 and 11:
che onora la cultura italiana, si p
- Page 12 and 13:
grafia estetica era stato dominato
- Page 14 and 15:
sciuto di Morpurgo e che ha avuto f
- Page 16 and 17:
Morpurgo-Tagliabuee l’estetica in
- Page 18 and 19:
e l’estetica idealista italiana m
- Page 20 and 21:
queste due «novità fondamentali»
- Page 22 and 23:
4Pubblicati rispettivamente in “R
- Page 24 and 25: un’estetica piuttosto articolata
- Page 26 and 27: Non desidero limitarmi a rilevare l
- Page 28 and 29: imprecisione: le differenze indicat
- Page 30 and 31: ino»; e la seconda accusa, conclud
- Page 32 and 33: scinanti, perché rappresentano pi
- Page 34 and 35: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica de
- Page 36 and 37: pensava soprattutto al fatto che il
- Page 38 and 39: apprende l’armonia della musica.
- Page 40 and 41: dal punto di vista del fruire: […
- Page 42 and 43: Bodmer riportava larghi estratti de
- Page 44 and 45: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica it
- Page 46 and 47: de quella stagione determinata, dal
- Page 48 and 49: che «in pratica dal giudicio dell
- Page 50 and 51: che agguaglino la forza degli origi
- Page 52 and 53: Perfetta poesia, e cioè quando Mur
- Page 54 and 55: 28Ibid., p. 63.29G. B. Gravina, De
- Page 56 and 57: è l’incrocio Gravina-Vico operat
- Page 58 and 59: classe nell’individuo, il quale,
- Page 60 and 61: Siano qui sufficienti alcuni cenni:
- Page 62 and 63: Implicazioni del nessotra gusto e g
- Page 64 and 65: gusto abbia statuto catacretico e i
- Page 66 and 67: espresso dall’effetto. Da un lato
- Page 68 and 69: modello del significare segnico in
- Page 70 and 71: ne» 3 . Scrive Morpurgo-Tagliabue
- Page 72 and 73: mento che quest’ultima implica un
- Page 76 and 77: conseguenza possiamo identificare u
- Page 78 and 79: 1Guido Morpurgo-Tagliabue, Il conce
- Page 81 and 82: Guido Morpurgo-Tagliabue:le sublime
- Page 83 and 84: son assimilation ultime à l’él
- Page 85 and 86: pective, comparer à celle de Giamb
- Page 87 and 88: (3) Cet idéal de beauté féminine
- Page 89 and 90: hors de l’écheveau complexe du v
- Page 91 and 92: Prendre le parti d’un tableau pr
- Page 93 and 94: tion» sur laquelle insiste Wittgen
- Page 95 and 96: Mais le problème est de ne pas se
- Page 97 and 98: 33 Ricercari Nowau. Una forma di or