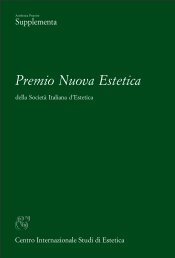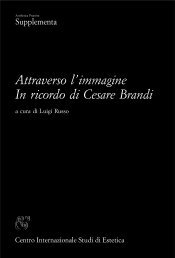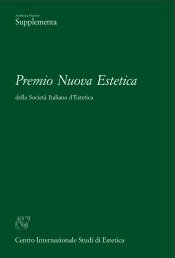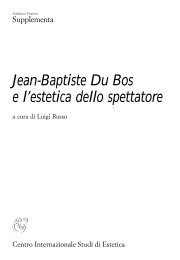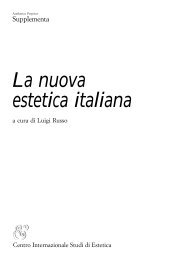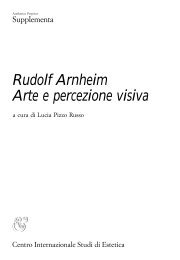che «in pratica dal giudicio <strong>del</strong>l’ascoltante», che riscontra nella destrezza<strong>del</strong>l’ingegno (sono ancora parole di Matteo Pellegrini) «un nonso che di vitale».Ecco allora una retorica che non si riduce, come per farla brevepotremmo dire avviene invece in Muratori, a “precettistica <strong>del</strong> convenevole”,ma elabora complessi nessi argomentativi che mirano a costruireelaborate strategie di sistema, tessendo insieme retorica e dialetticae indicando l’emergere <strong>del</strong> punto di vista e <strong>del</strong> luogo epistemico<strong>del</strong>l’estetico. Giusto dal punto di vista di una simile “sistematica <strong>del</strong>l’estetica”,al di là <strong>del</strong>l’impianto proposto da <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, sirivela allora la centralità strategica <strong>del</strong>la retorica per la costruzione<strong>del</strong>l’estetica moderna, e non è un caso che si possa oggi riscoprire lacentralità <strong>del</strong> pensiero retorico in Baumgarten, proprio nella sua originalissimariformulazione di questi stessi problemi.Possiamo subito tornare al primo <strong>Settecento</strong> italiano, a Muratori eGravina convincentemente indagati da <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong> in quantoesponenti di un barocco moderato ormai in ritardo, che non ha piùle stesse ragioni teoriche e la stessa funzione storica di quella stagione.Si potrà condividere buona parte <strong>del</strong>l’analisi di <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>,e in particolare a proposito <strong>del</strong> carattere tutto sommato sterile dimolte <strong>del</strong>le ricerche “estetiche” di Muratori, ancora attardato nellequestioni più tipiche <strong>del</strong> dibattito barocco, ma appunto senza quellaluce, senza quelle aperture, e con una più rigida impostazione precettistica.E basterà effettuare qualche verifica, quasi ad apertura di pagina,nel trattato Della perfetta poesia italiana 16 , opera in cui spessoritornano questioni e atteggiamenti teorici tipici <strong>del</strong>la trattatistica barocca,ma appunto senza quella ampiezza di vedute, senza quella retedi connessioni, infine senza la nettezza di quel progetto sistematico.Così Muratori riprende le considerazioni di Tesauro sui condizionamentifisiologici e sulla dotazione psicologica caratteristiche dei poeti(Libro III, 2), polemizza col padre Le Moyne, il rivale di Tesauro, epoi col Tesauro stesso, a proposito dei “sofismi ingegnosi” (Libro II,4); soprattutto, poi, come ha fatto giustamente notare <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>17 , la definizione di ingegno proposta da Muratori («L’ingegnosecondo la mia sentenza altro non è se non quella virtù, e forza attiva,con cui l’Intelletto raccoglie, unisce, e ritruova le simiglianze, le relazioni,e le ragioni <strong>del</strong>le cose» 18 ) si propone di fatto come una mera riproposizione<strong>del</strong>le definizioni correnti nel pensiero <strong>del</strong> Seicento.Effettivamente, quando, poche righe dopo aver letto questa definizione,leggiamo che in relazione a essa si danno un ingegno vasto euno penetrante, sembra proprio di leggere le considerazioni usuali daBacone a Tesauro, e in particolare proprio la distinzione, da quest’ultimoproposta, fra perspicacia e versabilità <strong>del</strong>l’ingegno 19 . C’è peròanche qui, rispetto alle teorizzazioni secentesche, una caratteristica51
chiusura degli orizzonti: è vero infatti che l’inquadramento <strong>del</strong>l’ingegnoall’interno <strong>del</strong>l’intelletto è usuale nel Seicento, ed esplicitamenteinteso dai nostri teorici concettisti, eppure esso non dà luogo automaticamentea una definizione razionalistica <strong>del</strong>l’ingegno; rimane per cosìdire uno spazio libero per l’attività <strong>del</strong>la fantasia e per forme di costruzionee condivisione di orizzonti immaginativi teorizzati dalla tradizioneretorica eppure non compatibili con le esigenze <strong>del</strong>l’intelletto speculativo.È quanto si potrebbe facilmente argomentare a proposito diTesauro a partire proprio dalla sottolineatura <strong>del</strong>la dote <strong>del</strong>la perspicacia,e dal raffronto subito proposto da Tesauro fra l’ingegno “retorico”e la prudenza.In Muratori, viceversa, la semplice aggiunta (nel passo poc’anzi citato)<strong>del</strong> riferimento alla capacità di ritrovare le ragioni <strong>del</strong>le cose valea imporre all’ingegno un rigido vincolo razionalistico; in questo modo,l’intero meccanismo <strong>del</strong>l’inganno prospettico barocco viene riproposto,ma assume la forma di un mero travestimento, di un “gioco a indovinello”,che mira a «insegnare alla nostra mente un qualche Vero, oVerisimile reale, travestito col Falso» 20 , come <strong>del</strong> resto si può facilmentescorgere quando Muratori riprende le giustificazioni a suo tempoavanzate dai teorici barocchi per spiegare il piacere connesso all’acutezza:«l’uditore ha l’obbligazione e il diletto d’intendere quelloche non si dice, e di comprendere da se stesso la significazione <strong>del</strong>Vero a bello studio alquanto celata, affinché gli altri abbiano il piacerdi trovarla […] saran sempre più belle queste Immagini, quanto piùda oggetti fra lor lontani, e nobili, e belli si prenderanno le simiglianze,e quanto più saranno queste nuove, e non aspettate, essendo lanovità madre <strong>del</strong>la maraviglia, e <strong>del</strong> diletto» 21 . E altrove leggiamo:«avvegnaché le Immagini Fantastiche non sieno vere a dirittura secondol’Intelletto, pure indirettamente servono ad esprimere, e rappresentarlo stesso Vero Intellettuale. Tutte le Metafore, le Iperboli, le Parabole,gli Apologi, e simili altri concetti <strong>del</strong>la Fantasia, sono un vestito,e un’ammanto sensibile di qualche Verità o Istorica, o Morale, o Naturale,o Astratta, o veramente avvenuta, o possibile ad avvenire» 22 .Questa banalizzazione davvero incredibile, benché dottamente sostenutada citazioni agostiniane, è la necessaria conseguenza <strong>del</strong> propositodi Muratori di sfuggire gli eccessi <strong>del</strong> Barocco, senza tuttavia uscirne,e senza riuscire a valorizzarne gli spunti di maggiore apertura.L’analisi di <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong> attribuisce giustamente il più grandespazio alla nozione di artificio/artificiale in Muratori, nozione tramitecui si evidenziano per un verso i legami persistenti col Barocco(l’artificio che supera la natura in direzione <strong>del</strong> meraviglioso, <strong>del</strong> “peregrino”;e poi la stilistica, cioè l’artificio stilistico, <strong>del</strong> meraviglioso),e per l’altro verso si aprono le questioni proprie <strong>del</strong>l’Arcadia («Il poeta“coll’Artifizio suo […] sa far sì vive, pellegrine e splendide le copie,52
- Page 1 and 2: Aesthetica PreprintGuido Morpurgo-T
- Page 4 and 5: Guido Morpurgo-Tagliabuee l’estet
- Page 6 and 7: Un marziano in esteticadi Luigi Rus
- Page 8 and 9: sava candidamente - nel pianificare
- Page 10 and 11: che onora la cultura italiana, si p
- Page 12 and 13: grafia estetica era stato dominato
- Page 14 and 15: sciuto di Morpurgo e che ha avuto f
- Page 16 and 17: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica in
- Page 18 and 19: e l’estetica idealista italiana m
- Page 20 and 21: queste due «novità fondamentali»
- Page 22 and 23: 4Pubblicati rispettivamente in “R
- Page 24 and 25: un’estetica piuttosto articolata
- Page 26 and 27: Non desidero limitarmi a rilevare l
- Page 28 and 29: imprecisione: le differenze indicat
- Page 30 and 31: ino»; e la seconda accusa, conclud
- Page 32 and 33: scinanti, perché rappresentano pi
- Page 34 and 35: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica de
- Page 36 and 37: pensava soprattutto al fatto che il
- Page 38 and 39: apprende l’armonia della musica.
- Page 40 and 41: dal punto di vista del fruire: […
- Page 42 and 43: Bodmer riportava larghi estratti de
- Page 44 and 45: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica it
- Page 46 and 47: de quella stagione determinata, dal
- Page 50 and 51: che agguaglino la forza degli origi
- Page 52 and 53: Perfetta poesia, e cioè quando Mur
- Page 54 and 55: 28Ibid., p. 63.29G. B. Gravina, De
- Page 56 and 57: è l’incrocio Gravina-Vico operat
- Page 58 and 59: classe nell’individuo, il quale,
- Page 60 and 61: Siano qui sufficienti alcuni cenni:
- Page 62 and 63: Implicazioni del nessotra gusto e g
- Page 64 and 65: gusto abbia statuto catacretico e i
- Page 66 and 67: espresso dall’effetto. Da un lato
- Page 68 and 69: modello del significare segnico in
- Page 70 and 71: ne» 3 . Scrive Morpurgo-Tagliabue
- Page 72 and 73: mento che quest’ultima implica un
- Page 74 and 75: do Morpurgo-Tagliabue gusto e giudi
- Page 76 and 77: conseguenza possiamo identificare u
- Page 78 and 79: 1Guido Morpurgo-Tagliabue, Il conce
- Page 81 and 82: Guido Morpurgo-Tagliabue:le sublime
- Page 83 and 84: son assimilation ultime à l’él
- Page 85 and 86: pective, comparer à celle de Giamb
- Page 87 and 88: (3) Cet idéal de beauté féminine
- Page 89 and 90: hors de l’écheveau complexe du v
- Page 91 and 92: Prendre le parti d’un tableau pr
- Page 93 and 94: tion» sur laquelle insiste Wittgen
- Page 95 and 96: Mais le problème est de ne pas se
- Page 97 and 98: 33 Ricercari Nowau. Una forma di or