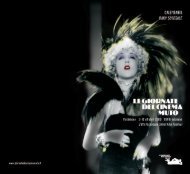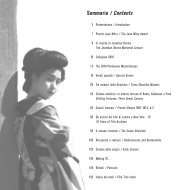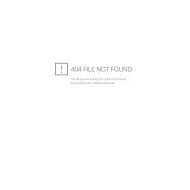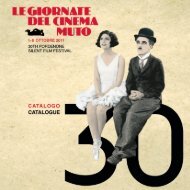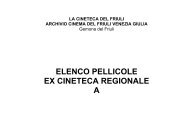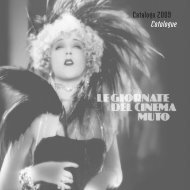Catalogo Giornate del Cinema Muto 2012 - La Cineteca del Friuli
Catalogo Giornate del Cinema Muto 2012 - La Cineteca del Friuli
Catalogo Giornate del Cinema Muto 2012 - La Cineteca del Friuli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
JENSEITS DER STRAßE (Harbor Drift) [Dall’altra parte <strong>del</strong>la strada]<br />
(Prometheus-Film Verleih- und Vertriebs-GmbH, Berlin, DE 1929)<br />
Regia/dir: Leo Mittler, [Albrecht Viktor Blum (non accreditato/<br />
uncredited)]; prod: Willi Münzenberg; scen: Jan Fethke; f./ph: Friedl<br />
Behn-Grund; scg./des: Robert Scharfenberg, Carl P. Haacker; eff. sp./<br />
spec. eff: Eugen Schüfftan (trucchi/trick process), Fritz Maurischat<br />
(disegni per procedimento Schüfftan/design for Schüfftan process);<br />
consulente artistico/artistic adviser: Willy Döll; aiuto regia/asst. dir:<br />
Julius Oblatt; dir. prod./prod. mgr: Dimitri Roschanski; cast: Lissy<br />
Arna (prostituta/prostitute), Paul Rehkopf (mendicante/beggar),<br />
Fritz Genschow (disoccupato/unemployed man), Siegfried Arno<br />
(ricettatore/dealer in stolen goods), Friedrich Gnaß (marinaio/sailor),<br />
Margarete Kupfer (ostessa/proprietress), Dietrich Henckels; riprese/<br />
filmed: 6-7.1929 (Jofa-Ateliers Berlin-Johannisthal; Rotterdam; Berlin);<br />
data v.c./censor date: 20.09.1929, B.23519, Jv. (2015 m.; 2028 m.<br />
prima <strong>del</strong>la censura/before censorship); première: 10.10.1929, Berlin<br />
(Atrium); 35mm, 1939 m., 93' (18 fps); fonte copia/print source:<br />
Bundesarchiv-Filmarchiv, Berlin.<br />
Didascalie in tedesco / German intertitles.<br />
Insolitamente anticipatore <strong>del</strong>le conseguenze <strong>del</strong>la crisi economica,<br />
Jenseits der Straße uscì a Berlino il 10 ottobre 1929, solo due<br />
settimane prima <strong>del</strong> crollo <strong>del</strong>la borsa di Wall Street. Il titolo inglese<br />
Harbor Drift (Detriti <strong>del</strong> porto) è particolarmente azzeccato perché<br />
mantiene il senso <strong>del</strong> titolo di lavorazione, Bettler, Dirne und<br />
Matrose (Mendicante, prostituta e marinaio). Ambientato in una<br />
città portuale tedesca, il film narra di esseri umani alla deriva – cruda<br />
metafora di quello che Marx e Engels chiamavano lumpenproletariat,<br />
un sottoproletariato fatto di mendicanti, prostitute, truffatori e “altri<br />
relitti <strong>del</strong>la società” privi di coscienza di classe e pertanto estranei alla<br />
lotta organizzata. Pur inserendosi nel popolare filone weimariano dei<br />
“film di strada” (esemplificato da titoli come Die Straße o Asphalt),<br />
più che sul pericoloso richiamo <strong>del</strong>la strada Jenseits der Straße si<br />
concentra sull’estrema povertà degli strati inferiori <strong>del</strong> proletariato. Al<br />
contrario di Mutter Krausens Fahrt ins Glük di Phil Jutzi, che uscì due<br />
mesi dopo, Jenseits der Straße non vede la possibilità di un’alternativa<br />
proletario-rivoluzionaria; i suoi miseri personaggi vivono al di fuori<br />
<strong>del</strong>la sfera sociale. Quest’assenza di zelo missionario è abbastanza<br />
curiosa, dato che il film era stato prodotto dalla Prometheus-Film<br />
di Willi Münzenberg, il cui scopo specifico era proprio quello di<br />
promuovere il cinema progressista proletario. Fondata nel 1925, la<br />
società si dedicò principalmente all’importazione dei film rivoluzionari<br />
sovietici (ad esempio, Bronenosec Potëmkin di Eisenstein e Mat’ di<br />
Pudovkin, entrambi <strong>del</strong> 1926), ma produsse anche alcuni lungometraggi<br />
in proprio, tra cui Jenseits der Straße, Mutter Krause e Kühle Wampe<br />
(Slatan Dudow, 1932). Alla fine, la visione alternativa, proletaria di<br />
Münzenberg non poté competere con l’opulento e potente impero<br />
<strong>del</strong>l’Ufa di Hugenberg. Il budget per Mutter Krause dovette essere<br />
drasticamente ridotto perché la produzione di Jenseits der Straße<br />
aveva sforato sui tempi, e nel 1932, durante la lavorazione di Kühle<br />
Wampe, la Prometheus-Film dichiarò bancarotta.<br />
152<br />
<strong>La</strong> trama di Jenseits der Straße è incentrata sulla ricerca di una<br />
scintillante collana di perle che simboleggia un diverso tipo di vita –<br />
una vita fatta di soldi, lussi ed eccessi. <strong>La</strong> vicenda inizia quando una<br />
prostituta vede un mendicante raccogliere per strada una collana<br />
e induce un amico disoccupato a sottrargliela. <strong>La</strong> sordida vicenda<br />
di miseria e cupidigia si conclude con il mendicante braccato che si<br />
annega accidentalmente, stringendo ancora tra le dita la sua collana –<br />
un’imitazione senza alcun valore, come si scoprirà.<br />
Il film si astiene da qualsiasi analisi psicologica e i suoi personaggi sono<br />
usati come “tipi” senza nome: “il mendicante”, “la prostituta”, ecc.<br />
Vi sono anche incluse riprese di paesaggi industriali per collocare gli<br />
individui nel loro milieu sociale e al contempo allargare il discorso<br />
sull’imponente e corrosivo potere <strong>del</strong> capitalismo. Parte di queste<br />
sequenze, nello stile costruttivista di Dziga Vertov, sono attribuite<br />
a Albrecht Viktor Blum, che era stato incaricato di dirigere Jenseits<br />
der Straße prima di essere rimpiazzato (per motivi di salute) da Leo<br />
Mittler, sconosciuto regista teatrale austriaco. Blum si era trovato al<br />
centro di una controversia quando in un suo film di compilazione <strong>del</strong><br />
1928, Im Schatten der Maschinen, aveva incorporato interi passaggi<br />
di un documentario di Vertov <strong>del</strong> 1928, Odinadcatyj (L’undicesimo<br />
anno). Paradossalmente, fu Vertov a doversi difendere dalle accuse di<br />
plagio quando nel 1929 andò a Berlino.<br />
<strong>La</strong> vicenda criminosa che vede coinvolti il mendicante e la prostituta<br />
è racchiusa in una cornice narrativa pure imperniata sulla prostituta.<br />
Seduta da sola in un caffè all’aperto, la donna viene introdotta<br />
attraverso una soggettiva ravvicinata dei suoi stivali, alti fino al<br />
ginocchio, strettamente allacciati e dal tacco alto. Lì accanto,<br />
un corpulento borghese con un sigaro – una caricatura uscita<br />
direttamente dalle pagine di George Grosz – sbircia feticisticamente<br />
le sue gambe fingendo di leggere il giornale. Simili scene di commercio<br />
sessuale facevano parte <strong>del</strong> contesto urbano <strong>del</strong>la Germania di<br />
Weimar, dove la prostituzione per strada era molto diffusa. Nel<br />
1927, una nuova legge per combattere le malattie veneree aveva<br />
depenalizzato la prostituzione, e nella sola Berlino si ritenevano attive<br />
non meno di centomila passeggiatrici. A mo’ di beffa nei confronti<br />
<strong>del</strong>lo spettatore, il film distoglie l’attenzione dall’incontro tra la<br />
prostituta e il potenziale cliente, per panoramicare sul giornale che<br />
l’uomo tiene sollevato per schermare le sue occhiate lascive. Dopo<br />
aver esplorato molte pagine e fotografie, la cinepresa si ferma su un<br />
trafiletto di cronaca, una misteriosa vicenda su un vecchio ripescato<br />
dalle acque, probabilmente vittima di un omicidio. <strong>La</strong> prima didascalia<br />
si chiede: “Milioni di copie di giornali ogni giorno. Centinaia di migliaia<br />
di notizie… ogni giorno. Centinaia di migliaia di destini… Chi vi<br />
presta la minima attenzione tra un sigaro e un caffè?” Il film risponde<br />
alla domanda staccando dal giornale su una strada molto animata,<br />
con la casa <strong>del</strong> vecchio, un mendicante, la cui morte ha ispirato<br />
l’articolo di cronaca. Investigando sul suo destino, il film presenta<br />
la vita <strong>del</strong>l’uomo come una storia che fa già parte <strong>del</strong> passato. <strong>La</strong><br />
fine è rivelata all’inizio – una tecnica narrativa che rafforza il senso<br />
di immutabilità e predestinazione, ma che è anche un espediente<br />
retorico teso a incoraggiare una lettura critica socio-analitica da parte<br />
<strong>del</strong>lo spettatore.<br />
Alla fine <strong>del</strong> lungo flash-back, il film ritorna sulla scena iniziale <strong>del</strong> caffè<br />
sulla strada come se il tempo non fosse trascorso. L’uomo col sigaro<br />
ripone il giornale e finalmente incontra lo sguardo <strong>del</strong>la prostituta (che<br />
noi conosciamo dalla vicenda criminale). I due lasciano il caffè senza aver<br />
scambiato una sola parola. Una sequenza girata da una prospettiva che<br />
fa sparire il corpo snello <strong>del</strong>la ragazza dietro l’addome grottescamente<br />
protuberante <strong>del</strong>l’uomo conclude il film – con la prostituta e il cliente<br />
che escono semplicemente dal fotogramma. Un’ultima inquadratura<br />
mostra la sporcizia che si ammucchia in una strada deserta. Nessun<br />
suicidio o redenzione melodrammatica: il film rifiuta una conclusione.<br />
<strong>La</strong> prostituta resta una prostituta, e la vita continua. Il film registra<br />
come un mero dato di fatto che le forze <strong>del</strong> mercato capitalista sono<br />
più forti di qualsiasi desiderio di cambiamento perché i desideri stessi<br />
sono dettati dal capitalismo. I critici <strong>del</strong> giornale comunista Die Rote<br />
Fahne si chiesero giustamente perché il film non desse qualche barlume<br />
di speranza, almeno all’operaio senza lavoro, di trovare solidarietà in<br />
una lotta di classe organizzata. Al contrario di Mutter Krause, Jenseits<br />
der Straße non mostra marce collettive verso un nuovo futuro.<br />
Uno degli atout <strong>del</strong> film è l’innovativa fotografia <strong>del</strong> cameraman Friedl<br />
Behn-Grund, che si appropria <strong>del</strong>le tecniche <strong>del</strong> cinema astratto e<br />
sperimentale inventando nuovi modi espressionisti di manipolare<br />
la luce. Le ombre scure chiazzate di luce e l’illuminazione spettrale<br />
degli alberi agitati dal vento su uno sfondo nero tendono a creare<br />
un’atmosfera da incubo, spaventosa e densa di premonizioni. Una<br />
macchina da presa spesso instabile cerca angolazioni insolite che<br />
propongano prospettive distorte; i primi piani sfocati suscitano un<br />
senso di panico. (Sul piano stilistico, Jenseits der Straße presenta<br />
molte similitudini con il cortometraggio sperimentale di Ernö Metzner,<br />
Polizeibericht Überfall, che era uscito nell’aprile 1929.) Il montaggio<br />
rapido <strong>del</strong>le sequenze segue le regole che la scuola russa aveva reso<br />
abituali in tutto il cinema proletario fin dalla “prima” berlinese di<br />
Bronenosec Potëmkin nel 1926.<br />
Jenseits der Straße usa il sesso e il crimine per attirare l’attenzione<br />
sui costi umani <strong>del</strong> capitalismo ma, in linea con i dettami <strong>del</strong>la Nuova<br />
Oggettività, rigetta ogni speranza romantica di una rivoluzione sociale.<br />
Il suo sguardo disilluso e duro anticipa l’universo cupo e privo di<br />
romanticismo <strong>del</strong> film noir americano degli anni ’40, che non a caso<br />
diverrà il naturale approdo per i cineasti di Weimar in esilio.<br />
ANTON KAES<br />
Uncommonly prescient about the social consequences of economic<br />
distress, Leo Mittler’s Jenseits der Straße (literally, “Beyond the<br />
Street”) opened in Berlin on 10 October 1929, just two weeks before<br />
the Wall Street stock market crash. The film’s English title, Harbor<br />
Drift, is well chosen because it retains a sense of the film’s working<br />
title, Bettler, Dirne und Matrose (Beggar, Prostitute, and Sailor). Set<br />
in a German harbor town, the story deals with human drift, a harsh<br />
metaphor for what Marx and Engels called the lumpenproletariat (rag-<br />
or rogue-proletariat), whose members – beggars, prostitutes, crooks,<br />
153<br />
and “other flotsam of society” – lack class consciousness and are<br />
therefore lost to organized struggle. Although Harbor Drift follows<br />
Weimar’s popular “street film” genre (as exemplified by The Street or<br />
Asphalt), it focuses less on the dangerous lure of the street than on<br />
the crushing poverty of the lowest layers of the proletariat. In contrast<br />
to Phil Jutzi’s Mother Krause’s Journey to Happiness, which premiered<br />
two months later, Harbor Drift does not hold out the possibility of a<br />
proletarian-revolutionary alternative; its poverty-stricken characters<br />
are shown to live outside the political sphere.<br />
This absence of missionary zeal is curious, because the film was<br />
produced by Willi Münzenberg’s Prometheus-Film, whose express<br />
purpose was to promote progressive proletarian cinema. Founded<br />
in 1925, the company focused on importing revolutionary Soviet<br />
films (e.g., Eisenstein’s Battleship Potemkin and Pudovkin’s Mother,<br />
both 1926), but also produced a few feature films on its own, such<br />
as Harbor Drift, Mother Krause, and Kuhle Wampe (Dudow, 1932).<br />
In the end, Münzenberg’s alternative proletarian vision could not<br />
compete with Hugenberg’s plush and powerful Ufa empire. The<br />
budget for Mother Krause had to be cut because of Harbor Drift’s<br />
production overruns, and in 1932, in the midst of the production of<br />
Kuhle Wampe, Prometheus-Film declared bankruptcy.<br />
Harbor Drift’s narrative centers around the quest for a glitzy pearl<br />
necklace that symbolizes a different kind of life – one of money,<br />
luxury, and extravagance. The story begins when a beggar finds the<br />
necklace and is seen stealing it by a prostitute. She demands that her<br />
unemployed friend steal it back from the beggar. The sordid tale of<br />
poverty and greed ends when the beggar is chased and accidentally<br />
drowns, still clutching his pearl necklace – a worthless imitation, as it<br />
turns out. The film refrains from psychologizing its characters, whom<br />
it uses as types without names (“the beggar”, “the prostitute”, etc.).<br />
Harbor Drift also includes shots of industrial landscapes to place the<br />
individuals in their social milieu and to suggest a larger story about<br />
capitalism’s imposing, albeit corrosive, power. Some of this footage,<br />
in the style of Dziga Vertov’s constructivism, is attributed to Albrecht<br />
Viktor Blum, who had been designated to direct Harbor Drift before<br />
he was replaced (because of illness) by Leo Mittler, an unknown<br />
Austrian theatre director. Blum had been the center of controversy<br />
when his 1928 compilation film Im Schatten der Maschinen (In the<br />
Shadow of Machines) incorporated whole passages from Vertov’s<br />
1928 documentary The Eleventh Year. (Ironically, during a visit to<br />
Berlin in 1929, it was Vertov who had to defend himself against<br />
charges of plagiarism.)<br />
The crime story involving the beggar and prostitute is embedded in<br />
a framing story that also features the prostitute. Sitting by herself at<br />
an outdoor café, silently soliciting, she is introduced through pointof-view<br />
close-ups of her knee-high, tightly laced, high-heeled boots.<br />
Nearby, a corpulent bourgeois with a cigar – a caricature straight from<br />
the pages of George Grosz – ogles her fetishized legs while pretending<br />
to read the paper. Such scenes of sexual commerce were part of urban<br />
life in Weimar Germany, where open prostitution was common. A<br />
R & R