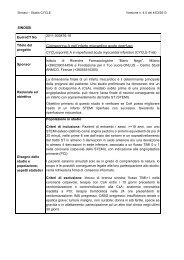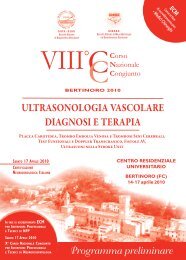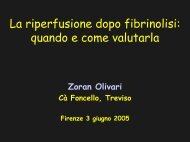Cardiologia negli Ospedali n° 154 Novembre/Dicembre 2006 - Anmco
Cardiologia negli Ospedali n° 154 Novembre/Dicembre 2006 - Anmco
Cardiologia negli Ospedali n° 154 Novembre/Dicembre 2006 - Anmco
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
V I A G G I O I N T O R N O A L C U O R E<br />
“chiedere”, ma per ottenere qualcosa e non per sapere<br />
qualcosa (che i latini indicavano con quaerere).<br />
Tutto questo induce ad una seria riflessione sul ruolo e l’importanza<br />
di chi traduce testi, specialmente letterari e filosofici<br />
(per quelli scientifici si può almeno contare su una<br />
rigida specificità lessicale), da una lingua all’altra e sulle enormi<br />
difficoltà che questo lavoro comporta. Quanto stiamo<br />
per dire si riferisce alla lingua scritta, per quella parlata gli<br />
interpreti si trovano di fronte ad altre difficoltà, ma certamente<br />
l’ambiente circostante, la modulazione della voce, i<br />
movimenti delle mani, in altre parole il linguaggio corporeo<br />
di chi parla, forniscono informazioni fondamentali.<br />
Ma allora come si deve tradurre e secondo quali regole<br />
La “querelle” ci porta lontano nel tempo. Potremmo affermare<br />
che non solo il come, ma soprattutto le implicazioni<br />
che tale compito impone sono antiche tanto quanto la traduzione<br />
stessa.<br />
Forse l’etimo stesso del verbo tradurre contiene in sé il<br />
germe di questa ambiguità: tale parola derivata dal latino<br />
trans-ducere,“portare al di là”, era nata inizialmente con un<br />
significato concreto, quello di trasferire qualcosa da un<br />
luogo ad un altro; la certezza che questo termine esprime<br />
nella sua immediatezza, cioè quello di poter tranquillamente<br />
prendere un testo e portarlo pari pari in un’altra lingua,<br />
che è anche un’altra dimensione sociale, temporale e culturale,<br />
comunica l’illusoria convinzione (ulteriormente confermata<br />
anche dalla scuola dove molte volte si insegna a<br />
tradurre senza riflettere su questi argomenti) che sia possibile<br />
un’operazione di questo genere, semplice ed indolore.<br />
Solo nella tarda latinità, il verbo ha acquisito il significato<br />
figurato di “trasportare” un testo da una lingua all’altra; il<br />
latino classico per definire questa operazione, preferiva<br />
altre forme come convertere, exprimere, interpretari, recidere,<br />
e Graeco in Latinum convertere diceva Cicerone, offrendo<br />
con questa vasta gamma di termini un quadro forse più<br />
articolato e realistico sulla difficoltà del “tradurre”.<br />
Va però anche ricordato che il concetto di traduzione nel<br />
mondo latino coincideva spesso con quello di imitatio: tutti<br />
i romani colti sapevano infatti leggere i testi originali in<br />
greco e al traduttore interessava soprattutto dar prova<br />
della sua capacità creativa attraverso l’emulazione dei grandi<br />
del passato, più che riportare nella propria lingua l’originale.<br />
È tuttavia proprio Cicerone a dare l’avvio all’eterno<br />
dibattito tra sostenitori della resa letterale e della libera<br />
interpretazione. Gli stessi umanisti, che per primi ricercarono<br />
una resa filologicamente aderente all’originale, ebbero<br />
ben chiara la difficoltà dell’operazione: Leonardo Bruni,<br />
avvertiva che il “traduttore deve percepire tutti, per così<br />
dire, i pregi di uno scritto e ugualmente riprodurli nella lingua<br />
in cui traduce. E poiché due sono i generi di ornamenti<br />
– uno quello con cui si dà colore alle parole, l’altro quello<br />
con cui si dà colore al pensiero – l’uno e l’altro implicano<br />
difficoltà per il traduttore”; e in un’epistola del 5 settembre<br />
1404 indirizzata a Niccolò Niccoli, il Bruni spiegava<br />
il proprio atteggiamento davanti a un dialogo di Platone che<br />
si apprestava a tradurre dal greco in latino:<br />
In primo luogo, dunque, conservo tutti i pensieri in modo che<br />
non mi allontano da essi nemmeno per la più piccola parte.<br />
Poi se una parola si può rendere con una parola corrispondente<br />
senza alcuna sconvenienza e assurdità, ben volentieri fo’<br />
così. Se invece non è possibile non sono tanto preoccupato da<br />
pensare di cadere in un crimine di lesa maestà se, conservato<br />
il pensiero, mi allontano un po’ dalle parole. E questo me lo<br />
comanda di fare lo stesso Platone, il quale essendo di ‘elegantissima<br />
bocca’ presso i Greci, non vuole certamente sembrare<br />
incapace presso i Latini.<br />
John Dryden, nel diciassettesimo secolo, ripropose una<br />
interessante riflessione sul tema indicando, nella prefazione<br />
alla traduzione delle Epistole di Ovidio, tre possibili tipologie<br />
di trasposizione: la metafrasi, quando il testo è riproposto<br />
parola per parola, la parafrasi, quando lo si ripropone<br />
secondo il senso, l’imitazione, quando il traduttore si allontana<br />
dall’originale. Tuttavia, egli suggerisce il criterio della<br />
moderazione, della via di mezzo, e dice di essersi attenuto<br />
tra i due estremi, ovvero tra la metafrasi e la parafrasi, pur<br />
cercando di modernizzare la lingua di partenza.<br />
Di avviso diverso gli studiosi dell’epoca romantica, essi la<br />
considerarono un’attività autonoma e creativa, tanto che<br />
anche il traduttore, nella sua libertà interpretativa, doveva<br />
avere una sensibilità pari a quella dei poeti.<br />
Dunque la traduzione è un procedimento meccanico o<br />
creativo E quali devono essere le qualità richieste a un traduttore<br />
Dai primi decenni del Novecento, e fino ad oggi, il rinnovato<br />
fervore per gli studi linguistici e antropologici ha spinto<br />
verso il tentativo di fondare una vera e propria scienza della<br />
traduzione.<br />
A questo proposito merita ricordare la cosiddetta ipotesi<br />
Sapir-Whorf, secondo la quale la struttura di una lingua<br />
influenza il modo di pensare del parlante, quindi la sua cultura.<br />
I due antropologi della Yale University, il primo allievo<br />
del secondo, nella prima metà del secolo scorso, elaborarono<br />
una teoria, conosciuta anche come relativismo linguistico,<br />
secondo la quale ogni lingua rappresenta una visione<br />
unica del mondo, incompatibile con ogni altro modo di percepire<br />
la realtà e chi la parla non può liberarsi dalle categorie<br />
che la lingua stessa impone sulle percezioni e sul pensiero.<br />
È comunque dallo strutturalismo che giunge una speranza<br />
di venire a capo del problema: Roman Jakobson, tra i fon-<br />
80