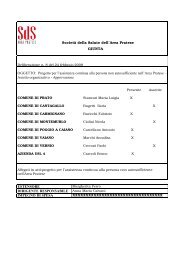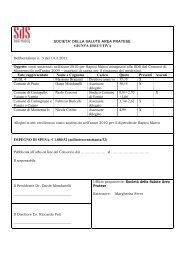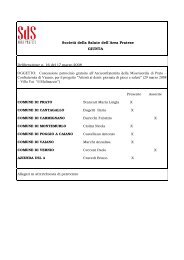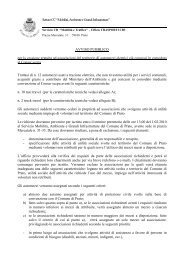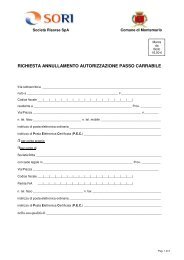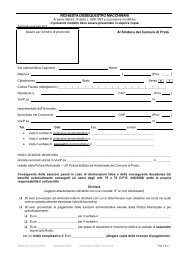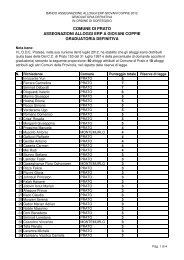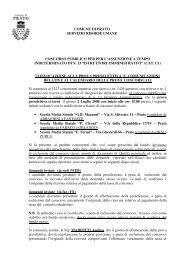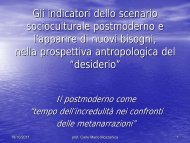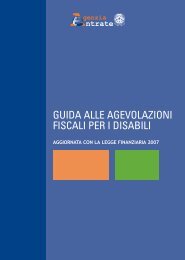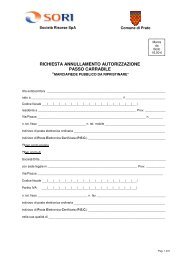Bollettino Roncioniano - PO-Net Rete Civica di Prato
Bollettino Roncioniano - PO-Net Rete Civica di Prato
Bollettino Roncioniano - PO-Net Rete Civica di Prato
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
58 Sergio Nannicini<br />
impressione contro lo sfondo nero, mentre il fiotto del giorno la ferisce<br />
da destra. Le vesti così ricche, il velo tirato in<strong>di</strong>etro dalla fronte tersa <strong>di</strong><br />
Caterina d’Alessandria ritratta ai pie<strong>di</strong> della croce, le bocche stupite, tutto<br />
fa ritenere che vi sia un influsso del maestro <strong>di</strong> Michele, Ridolfo del<br />
Ghirlandaio, che del resto aveva ricavato dall’arte nor<strong>di</strong>ca sottili espe<strong>di</strong>enti<br />
per fingere la sericità dei panni, come anche il patetico accento dei<br />
volti 3 .<br />
Forse il profilo più in<strong>di</strong>viduato è quello della Maddalena sulla sinistra,<br />
che sembra inginocchiarsi in quel momento, raccogliendo il manto<br />
<strong>di</strong> un rosso densissimo; l’altra figura inginocchiata, Santa Caterina d’Alessandria,<br />
è <strong>di</strong>un’abilità stupefacente, con un variar <strong>di</strong> sete che sembra <strong>di</strong><br />
sentir crosciare, e la pupilla che si inumi<strong>di</strong>sce. Ma la de<strong>di</strong>zione della Maddalena<br />
porta davvero in alto, appartenendo a un’adolescenza che per la<br />
prima volta aspetta il pianto serio, un lutto dell’esistenza (certo doveva<br />
3 Sui prospetti del primo cortile del monastero emergono delle finestre su mensole a voluta;<br />
ma questo scarno ritmo si trova ancora sotto il loggiato e lungo l’ala del convento affacciata<br />
sull’orto. Insieme alla cerchia me<strong>di</strong>oevale in prossimità della Porta pistoiese, si tratta <strong>di</strong> uno dei<br />
confini che abbracciano il convento, rimarcandone la fondazione cinquecentesca entro la fortezza<br />
<strong>di</strong> <strong>Prato</strong>. Un’altra caratteristica è data dalle travi a capriate dei loggiati, o dalla copertura, su<br />
appropriate mensole, dell’ariosa sala del Guardaroba (1540). Qui è custo<strong>di</strong>to lo stendardo che<br />
per la prima volta fu <strong>di</strong>spiegato sotto la volta a botte <strong>di</strong> San Pietro per la canonizzazione della<br />
Santa (il 29 giugno 1746).<br />
Converrà conoscerne sia l’origine che il concetto. L’autore, Salvatore Monosilio <strong>di</strong> origine<br />
messinese, ma <strong>di</strong> formazione romana, voleva ottenere un gusto <strong>di</strong> miniatura preziosa, fingendo<br />
delle cortine che si aprano in quel preciso istante delle parole papali, per far ammirare le due<br />
immagini <strong>di</strong> S. Caterina: il suo colloquio turbato con il Crocifisso che si <strong>di</strong>stacca e si protende<br />
verso <strong>di</strong> lei, e la sua figura in gloria, tra nubi ed angeli. Ma che cos’è quell’impronta sfarzosa, e<br />
tuttavia can<strong>di</strong>da, che ci fa piacere un sobbalzo fra cielo e terra altrimenti stucchevole?<br />
Certamente il pittore ripensò auna fonte prossima, a una “Estasi <strong>di</strong> Santa Caterina de’<br />
Ricci” <strong>di</strong>pinta dal romano Agostino Masucci alcuni anni prima, ed ora esposta nella Galleria<br />
Nazionale <strong>di</strong> Roma; questa gli impose un equilibrio arioso e scultoreo, anche nell’intento <strong>di</strong><br />
guidare i sensi tra la penombra della basilica romana. Ma nella chiesa <strong>di</strong> San Vincenzo, dov’è stato<br />
issato anche recentemente, lo stendardo sembra del tutto originale; il suo acerbo tono <strong>di</strong> entusiasmo,<br />
e infine il candore fulmineo della santa sbigottita, ottengono un’acutezza <strong>di</strong> memoria<br />
che altre pale presenti nella chiesa non riescono a infondere appieno.<br />
Per esempio, i quadretti eseguiti da Giovan Domenico Ferretti per il sacello della Beata<br />
Caterina <strong>di</strong>etro l’altar maggiore, sono stranamente tarpati rispetto alla fantasia corrusca solita a<br />
quel pittore, e senz’altro inferiori allo stendardo del Monosilio. La storia <strong>di</strong> “S. Caterina de’<br />
Ricci che riceve Gesù Bambino dalla Vergine”, intanto ha abolito la presenza del padre Gerolamo,<br />
che aiutò Caterina a drizzarsi in pie<strong>di</strong> e la rincuorò, tale fu il suo spavento (era «nimia<br />
consternatione perculsa», altro che smancerie imbambolate!). Inoltre, la semplicità <strong>di</strong>quel contesto<br />
<strong>di</strong>alogico o teatrale, probabilmente <strong>di</strong> ascendenza emiliana, non è dovuta, come alcuni<br />
autori sostengono (cfr. Il Settecento a <strong>Prato</strong>, 1999) ad un gusto narrativo alieno «da connotazioni<br />
auliche». Non sono forse aulici quei santi o testimoni che nulla hanno in comune con l’episo<strong>di</strong>o,<br />
oltretutto oberati da svolazzi d’abito, che un soffio cortese e inopinato aiuta a prendere<br />
aspetto celestiale? Si tratta <strong>di</strong> retorica suasoria; a cui si preferisce lo stendardo del pittore messinese,<br />
con l’energia e il riverbero delle cortine che allegramente colgono l’intimazione ad<br />
aprirsi.