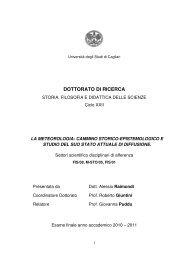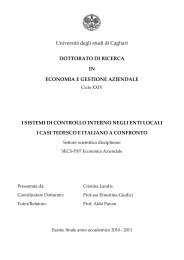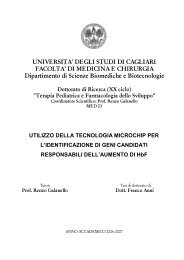- Page 1:
GuineanA 12 Flora vascolare del Sul
- Page 4 and 5:
Gianluigi Bacchetta 4
- Page 6 and 7:
Gianluigi Bacchetta messo in eviden
- Page 8 and 9:
Gianluigi Bacchetta geolithologic,
- Page 10 and 11: Gianluigi Bacchetta 10
- Page 12 and 13: Gianluigi Bacchetta Figura 1. Carta
- Page 14 and 15: Gianluigi Bacchetta 3. INQUADRAMENT
- Page 16 and 17: Gianluigi Bacchetta Mediterraneo. L
- Page 18 and 19: Gianluigi Bacchetta Caratteristica
- Page 20 and 21: Gianluigi Bacchetta questi rilievi,
- Page 22 and 23: Gianluigi Bacchetta Nei promontori
- Page 24 and 25: Gianluigi Bacchetta 4. ANALISI CLIM
- Page 26 and 27: Gianluigi Bacchetta 4.1.3. Temperat
- Page 28 and 29: Gianluigi Bacchetta Tabella 3. Nume
- Page 30 and 31: Gianluigi Bacchetta regione ma si p
- Page 32 and 33: Gianluigi Bacchetta Per quanto rigu
- Page 34 and 35: Gianluigi Bacchetta Dopo gli studi
- Page 36 and 37: Gianluigi Bacchetta 36
- Page 38 and 39: Gianluigi Bacchetta 38
- Page 40 and 41: Gianluigi Bacchetta 40
- Page 42 and 43: Gianluigi Bacchetta 42
- Page 44 and 45: Gianluigi Bacchetta 44
- Page 46 and 47: Gianluigi Bacchetta 46
- Page 48 and 49: Gianluigi Bacchetta 48
- Page 50 and 51: Gianluigi Bacchetta 50
- Page 52 and 53: Gianluigi Bacchetta Tabella 11. Dat
- Page 54 and 55: Gianluigi Bacchetta 5.2. MATERIALI
- Page 56 and 57: Gianluigi Bacchetta 6. FLORA 6.1. E
- Page 58 and 59: Gianluigi Bacchetta esplorazioni de
- Page 62 and 63: Gianluigi Bacchetta Dopo questi lav
- Page 64 and 65: Gianluigi Bacchetta 250 anni di sto
- Page 66 and 67: Gianluigi Bacchetta comune, pc = po
- Page 68 and 69: Gianluigi Bacchetta Selaginellaceae
- Page 70 and 71: Gianluigi Bacchetta Isola di Tuarre
- Page 72 and 73: Gianluigi Bacchetta 1996); S.ta Luc
- Page 74 and 75: Gianluigi Bacchetta Marsileaceae Ma
- Page 76 and 77: Gianluigi Bacchetta (CAG); Schina L
- Page 78 and 79: Gianluigi Bacchetta Pinaceae Pinus
- Page 80 and 81: Gianluigi Bacchetta Amaranthus defl
- Page 82 and 83: Gianluigi Bacchetta Apiaceae (Umbel
- Page 84 and 85: Gianluigi Bacchetta (Bocchieri, 198
- Page 86 and 87: Gianluigi Bacchetta Masainas (Atzei
- Page 88 and 89: Gianluigi Bacchetta Seseli praecox
- Page 90 and 91: Gianluigi Bacchetta Aristolochia pa
- Page 92 and 93: Gianluigi Bacchetta 1964) sub A. ar
- Page 94 and 95: Gianluigi Bacchetta Bacchetta (J.B.
- Page 96 and 97: Gianluigi Bacchetta Centaurea solst
- Page 98 and 99: Gianluigi Bacchetta (Spreng.) Hiero
- Page 100 and 101: Gianluigi Bacchetta Erigeron canade
- Page 102 and 103: Gianluigi Bacchetta Gutturu Mannu (
- Page 104 and 105: Gianluigi Bacchetta (CAG); Teulada,
- Page 106 and 107: Gianluigi Bacchetta Otanthus mariti
- Page 108 and 109: Gianluigi Bacchetta (CAG); Isola Ca
- Page 110 and 111:
Gianluigi Bacchetta Silybum marianu
- Page 112 and 113:
Gianluigi Bacchetta Castello di Acq
- Page 114 and 115:
Gianluigi Bacchetta (L.); Nuxis, Sa
- Page 116 and 117:
Gianluigi Bacchetta Arabis collina
- Page 118 and 119:
Gianluigi Bacchetta Medic. var. rub
- Page 120 and 121:
Gianluigi Bacchetta Iiriti, 2000);
- Page 122 and 123:
Gianluigi Bacchetta (Bocchieri, 198
- Page 124 and 125:
Gianluigi Bacchetta Legousia falcat
- Page 126 and 127:
Gianluigi Bacchetta Cerastium brach
- Page 128 and 129:
Gianluigi Bacchetta Minuartia hybri
- Page 130 and 131:
Gianluigi Bacchetta Arcosu (Mossa e
- Page 132 and 133:
Gianluigi Bacchetta Silene nummica
- Page 134 and 135:
Gianluigi Bacchetta Atriplex halimu
- Page 136 and 137:
Gianluigi Bacchetta Campu Matta, Pu
- Page 138 and 139:
Gianluigi Bacchetta Helianthemum ae
- Page 140 and 141:
Gianluigi Bacchetta Teulada, 10.X.1
- Page 142 and 143:
Gianluigi Bacchetta Sedum rupestre
- Page 144 and 145:
Gianluigi Bacchetta Sixalis atropur
- Page 146 and 147:
Gianluigi Bacchetta G. Bacchetta et
- Page 148 and 149:
Gianluigi Bacchetta 07.V.1989, E. B
- Page 150 and 151:
Gianluigi Bacchetta Anthyllis vulne
- Page 152 and 153:
Gianluigi Bacchetta Coronilla scorp
- Page 154 and 155:
Gianluigi Bacchetta Genista valsecc
- Page 156 and 157:
Gianluigi Bacchetta Lathyrus latifo
- Page 158 and 159:
Gianluigi Bacchetta Lupinus angusti
- Page 160 and 161:
Gianluigi Bacchetta Medicago orbicu
- Page 162 and 163:
Gianluigi Bacchetta Arcosu - (Camar
- Page 164 and 165:
Gianluigi Bacchetta Trifolium arven
- Page 166 and 167:
Gianluigi Bacchetta Trifolium resup
- Page 168 and 169:
Gianluigi Bacchetta Vicia disperma
- Page 170 and 171:
Gianluigi Bacchetta Vicia villosa R
- Page 172 and 173:
Gianluigi Bacchetta (CAG); M.te Tam
- Page 174 and 175:
Gianluigi Bacchetta Erodium lacinia
- Page 176 and 177:
Gianluigi Bacchetta Guttiferae Hype
- Page 178 and 179:
Gianluigi Bacchetta Rio Mannu, Domu
- Page 180 and 181:
Gianluigi Bacchetta Sarroch: Medau
- Page 182 and 183:
Gianluigi Bacchetta Salvia sclarea
- Page 184 and 185:
Gianluigi Bacchetta drosocalix Mus,
- Page 186 and 187:
Gianluigi Bacchetta Lythrum junceum
- Page 188 and 189:
Gianluigi Bacchetta (Ballero et al.
- Page 190 and 191:
Gianluigi Bacchetta Ligustrum vulga
- Page 192 and 193:
Gianluigi Bacchetta Epilobium monta
- Page 194 and 195:
Gianluigi Bacchetta Oxalidaceae Oxa
- Page 196 and 197:
Gianluigi Bacchetta P.ta Maxia (Cam
- Page 198 and 199:
Gianluigi Bacchetta Plantago major
- Page 200 and 201:
Gianluigi Bacchetta Limonium insula
- Page 202 and 203:
Gianluigi Bacchetta 2004) sub Polyg
- Page 204 and 205:
Gianluigi Bacchetta Rumex pulcher L
- Page 206 and 207:
Gianluigi Bacchetta probabilmente e
- Page 208 and 209:
Gianluigi Bacchetta Clematis cirrho
- Page 210 and 211:
Gianluigi Bacchetta Ranunculus cord
- Page 212 and 213:
Gianluigi Bacchetta Ranunculus reve
- Page 214 and 215:
Gianluigi Bacchetta Gutturu Mannu -
- Page 216 and 217:
Gianluigi Bacchetta Arcosu (Mossa e
- Page 218 and 219:
Gianluigi Bacchetta - (Camarda et a
- Page 220 and 221:
Gianluigi Bacchetta Capoterra: Is O
- Page 222 and 223:
Gianluigi Bacchetta (Bocchieri et I
- Page 224 and 225:
Gianluigi Bacchetta Pula, CA, 10.VI
- Page 226 and 227:
Gianluigi Bacchetta Parentucellia v
- Page 228 and 229:
Gianluigi Bacchetta Pantaleo - Gutt
- Page 230 and 231:
Gianluigi Bacchetta Nicotiana glauc
- Page 232 and 233:
Gianluigi Bacchetta Sotgiu Cocco, d
- Page 234 and 235:
Gianluigi Bacchetta Ex Sardinia, su
- Page 236 and 237:
Gianluigi Bacchetta Valerianella mi
- Page 238 and 239:
Gianluigi Bacchetta Phormium tenax
- Page 240 and 241:
Gianluigi Bacchetta (Mossa et Bacch
- Page 242 and 243:
Gianluigi Bacchetta Carex divisa Hu
- Page 244 and 245:
Gianluigi Bacchetta Tamara (Ballero
- Page 246 and 247:
Gianluigi Bacchetta Scirpus maritim
- Page 248 and 249:
Gianluigi Bacchetta Iris xiphium L.
- Page 250 and 251:
Gianluigi Bacchetta 1993); M.te Tam
- Page 252 and 253:
Gianluigi Bacchetta 1985); C. Teula
- Page 254 and 255:
Gianluigi Bacchetta Allium sativum
- Page 256 and 257:
Gianluigi Bacchetta Asparagus aphyl
- Page 258 and 259:
Gianluigi Bacchetta Gagea granatell
- Page 260 and 261:
Gianluigi Bacchetta 1942); Isola Ro
- Page 262 and 263:
Gianluigi Bacchetta Arcosu (Mossa e
- Page 264 and 265:
Gianluigi Bacchetta Orchis longicor
- Page 266 and 267:
Gianluigi Bacchetta Barbara (615 m)
- Page 268 and 269:
Gianluigi Bacchetta velata (Barbey,
- Page 270 and 271:
Gianluigi Bacchetta Arundo donax L.
- Page 272 and 273:
Gianluigi Bacchetta subsp. rigidus;
- Page 274 and 275:
Gianluigi Bacchetta Boiss. et Reut.
- Page 276 and 277:
Gianluigi Bacchetta P.to Pino (Bram
- Page 278 and 279:
Gianluigi Bacchetta Hordeum vulgare
- Page 280 and 281:
Gianluigi Bacchetta Gilla, zona per
- Page 282 and 283:
Gianluigi Bacchetta Phalaris caerul
- Page 284 and 285:
Gianluigi Bacchetta Poa sylvicola G
- Page 286 and 287:
Gianluigi Bacchetta pungens (Schreb
- Page 288 and 289:
Gianluigi Bacchetta Vulpia myuros (
- Page 290 and 291:
Gianluigi Bacchetta 290
- Page 292 and 293:
Gianluigi Bacchetta Figura 5. Spett
- Page 294 and 295:
Gianluigi Bacchetta All’interno d
- Page 296 and 297:
Gianluigi Bacchetta 296
- Page 298 and 299:
Gianluigi Bacchetta 298
- Page 300 and 301:
Gianluigi Bacchetta Dall’elenco f
- Page 302 and 303:
Gianluigi Bacchetta L’analisi del
- Page 304 and 305:
Gianluigi Bacchetta Figura 11. Unit
- Page 306 and 307:
Gianluigi Bacchetta e ciò conferma
- Page 308 and 309:
Gianluigi Bacchetta Tabella 20. Ele
- Page 310 and 311:
Gianluigi Bacchetta 7.3. FITOTOPONI
- Page 312 and 313:
Gianluigi Bacchetta 312
- Page 314 and 315:
Gianluigi Bacchetta 314
- Page 316 and 317:
Gianluigi Bacchetta 316
- Page 318 and 319:
Gianluigi Bacchetta 318
- Page 320 and 321:
Gianluigi Bacchetta In Figura 14 ve
- Page 322 and 323:
Gianluigi Bacchetta Tabella 22. Num
- Page 324 and 325:
Gianluigi Bacchetta del sito. Con l
- Page 326 and 327:
Gianluigi Bacchetta Figura 17. Dist
- Page 328 and 329:
Gianluigi Bacchetta Bioclima: Medit
- Page 330 and 331:
Gianluigi Bacchetta 5. Ceratonia si
- Page 332 and 333:
Gianluigi Bacchetta 8. Ceratonia si
- Page 334 and 335:
Gianluigi Bacchetta Substrato geoli
- Page 336 and 337:
Gianluigi Bacchetta Carta IGM: Capo
- Page 338 and 339:
Gianluigi Bacchetta indicazioni su
- Page 340 and 341:
Gianluigi Bacchetta 20. Juniperus o
- Page 342 and 343:
Gianluigi Bacchetta 23. Pinus pinea
- Page 344 and 345:
Gianluigi Bacchetta 26. Pistacia le
- Page 346 and 347:
Gianluigi Bacchetta amputazioni. No
- Page 348 and 349:
Gianluigi Bacchetta 32. Quercus ile
- Page 350 and 351:
Gianluigi Bacchetta 35. Salix purpu
- Page 352 and 353:
Gianluigi Bacchetta 8. CONCLUSIONI
- Page 354 and 355:
Gianluigi Bacchetta 9. BIBLIOGRAFIA
- Page 356 and 357:
Gianluigi Bacchetta Karibu Editions
- Page 358 and 359:
Gianluigi Bacchetta 395-402. BOCCHI
- Page 360 and 361:
Gianluigi Bacchetta dello Stato, Ro
- Page 362 and 363:
Gianluigi Bacchetta 144-154. FIORI
- Page 364 and 365:
Gianluigi Bacchetta Informático pa
- Page 366 and 367:
Gianluigi Bacchetta et documents) 1
- Page 368 and 369:
Gianluigi Bacchetta VALSECCHI F. 19