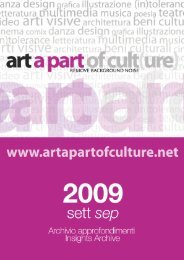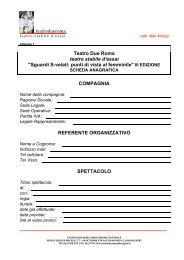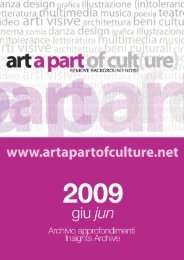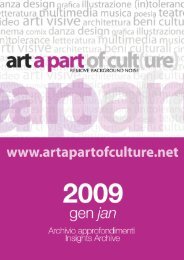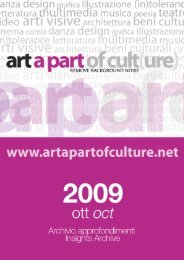Scarica | Download - art a part of cult(ure)
Scarica | Download - art a part of cult(ure)
Scarica | Download - art a part of cult(ure)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
visivamente a suo corollario: Genio Futurista.<br />
Le vicende della p<strong>art</strong>ecipazione futurista<br />
all’esposizione parigina che mise in scena l’Art Déco<br />
internazionale sono state messe in luce in un<br />
prezioso <strong>art</strong>icolo di Federica Pirani del 1999 .<br />
Tuttavia vale la pena di ripercorrerle brevemente<br />
per contestualizzare l’opera in un momento cruciale<br />
per la diffusione del futurismo in campo europeo, e<br />
parimenti per dar conto delle incomprensioni che<br />
contemporaneamente il movimento riscuoteva in<br />
Italia. Nonostante la sempre accesa presenza di<br />
Marinetti nel contesto organizzativo italiano e gli<br />
appoggi che gli derivavano dal capo del governo<br />
Mussolini anche grazie al precoce sostegno dato al<br />
fascismo (il quale dal canto suo non lesinava<br />
apprezzamenti positivi al futurismo, ma per una<br />
precisa scelta politico-<strong>cult</strong>urale aveva lucidamente<br />
optato per una posizione personalmente defilata<br />
nelle decisioni <strong>art</strong>istiche nazionali, anche se talvolta<br />
– fu proprio il caso di Parigi 1925 – derogò da<br />
questa posizione per motivi legati a rapporti<br />
personali, di ordine eccezionale), il futurismo non<br />
aveva mai trovato un ampio palcoscenico critico in<br />
Italia. Le scelte corporative degli <strong>art</strong>isti e dei critici si orientavano piuttosto sul sostegno a<br />
un ritorno all’ordine classico, in ordine a un gusto nazionale decisamente preponderante in<br />
questo senso. Il futurismo aveva guadagnato una sua nicchia rispettata ma sempre messa<br />
in scacco dalle decisioni delle organizzazioni ufficiali, che occorreva di volta in volta<br />
controbattere per ottenere uno spazio di visibilità pubblica nelle varie manifestazioni<br />
collettive (Biennali veneziane e romane, Biennali e Triennali di Monza e poi Milano, ecc.). Il<br />
caso dell’Esposizione parigina non fece eccezione, con il suo comitato formato da burocrati<br />
come Te<strong>of</strong>ilo Rossi di Montelera, Ambasciatore a Parigi e Commissario Generale del<br />
Comitato per l’Esposizione, Guido Colla, funzionario della Camera di Commercio di Torino,<br />
Pietro Donvito, Prefetto di Torino, e i commissari tecnici Arduino Colasanti, Direttore<br />
Generale delle Antichità e Belle Arti di Roma, Annibale Galateri, s<strong>cult</strong>ore torinese,<br />
Armando Brasini, architetto eclettico e autore del Padiglione italiano: un p<strong>art</strong>erre<br />
decisamente rétro nell’orientamento, cui faceva parziale eccezione il pittore Ardengo<br />
S<strong>of</strong>fici, già futurista ma allora ormai orientato su un’interpretazione severa della<br />
tradizione pittorica italiana. Ugo Ojetti, di cui inizialmente si parlava come possibile<br />
Commissario, critico nettamente conservatore, fu subito silurato da Marinetti con un<br />
<strong>art</strong>icolo sull’ “Ambrosiano” nel 1923, ma Te<strong>of</strong>ilo Rossi, che gli subentrò, non era certo più<br />
illuminato. I futuristi non furono infatti inizialmente considerati negli inviti, e solo dopo<br />
infinite trattative, portate avanti da Marinetti e Prampolini, il gruppo fu ammesso a<br />
p<strong>art</strong>ecipare, però al di fuori del padiglione italiano (esposero al Grand Palais) e con<br />
grande ritardo: solo nel gennaio 1925 essi ottennero la sospirata adesione, dopo un lungo<br />
e pachidermico osteggiamento da p<strong>art</strong>e di Colasanti, e grazie all’intervento diretto di<br />
Mussolini, che riuscì a sbloccare la situazione e anche a sostenerli economicamente con un<br />
cospicuo contributo economico.<br />
La p<strong>art</strong>ecipazione futurista vide dunque Balla, Prampolini e Depero dividersi uno spazio<br />
forse non felicissimo, “appena decoroso” (una zona semiellittica nell’ambito del Grand<br />
Palais, come s’è detto), ma molto più ampio di quanto gli veniva inizialmente concesso e<br />
prospettato nell’ambito del padiglione neoclassico e pomposo di Brasini. Depero<br />
presentava arazzi, cuscini, giocattoli, disegni per scialli, progetti architettonici e tutta la<br />
produzione della sua <strong>of</strong>ficina di Rovereto; Prampolini progetti teatrali e decorativi. Lo<br />
spazio dedicato a Balla era più ristretto, quasi un introibo alle sale dei più giovani colleghi,<br />
collocato in uno spazio in cima ad una scala da cui si accedeva agli spazi dedicati a Depero<br />
e Prampolini: l’<strong>art</strong>ista vi espose quattro arazzi, o meglio quattro dipinti su tela d’arazzo,<br />
Genio futurista, Mare vele vento (citato anche come Mare velivolato), entrambi di<br />
9