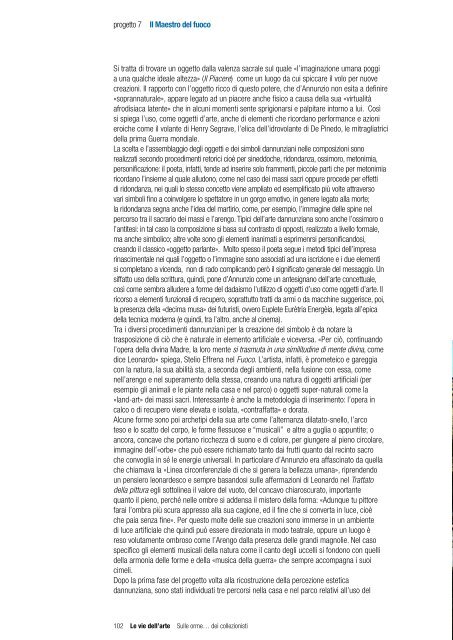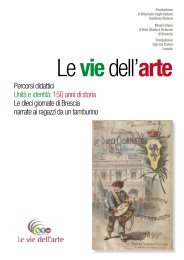Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
progetto 7 Il Maestro del fuoco progetto 7 Il Maestro del fuoco<br />
Si tratta di trovare un oggetto dalla valenza sacrale sul quale «l’imaginazione umana poggi<br />
a una qualche ideale altezza» (Il Piacere) come un luogo da cui spiccare il volo per nuove<br />
creazioni. Il rapporto con l’oggetto ricco di questo potere, che d’Annunzio non esita a definire<br />
«soprannaturale», appare legato ad un piacere anche fisico a causa della sua «virtualità<br />
afrodisiaca latente» che in alcuni momenti sente sprigionarsi e palpitare intorno a lui. Così<br />
si spiega l’uso, come oggetti d’arte, anche di elementi che ricordano performance e azioni<br />
eroiche come il volante di Henry Segrave, l’elica dell’idrovolante di De Pinedo, le mitragliatrici<br />
della prima Guerra mondiale.<br />
La scelta e l’assemblaggio degli oggetti e <strong>dei</strong> simboli dannunziani nelle composizioni sono<br />
realizzati secondo procedimenti retorici cioè per sineddoche, ridondanza, ossimoro, metonimia,<br />
personificazione: il poeta, infatti, tende ad inserire solo frammenti, piccole parti che per metonimia<br />
ricordano l’insieme al quale alludono, come nel caso <strong>dei</strong> massi sacri oppure procede per effetti<br />
di ridondanza, nei quali lo stesso concetto viene ampliato ed esemplificato più volte attraverso<br />
vari simboli fino a coinvolgere lo spettatore in un gorgo emotivo, in genere legato alla morte;<br />
la ridondanza segna anche l’idea del martirio, come, per esempio, l’immagine delle spine nel<br />
percorso tra il sacrario <strong>dei</strong> massi e l’arengo. Tipici dell’arte dannunziana sono anche l’ossimoro o<br />
l’antitesi: in tal caso la composizione si basa sul contrasto di opposti, realizzato a livello formale,<br />
ma anche simbolico; altre volte sono gli elementi inanimati a esprimenrsi personificandosi,<br />
creando il classico «oggetto parlante». Molto spesso il poeta segue i metodi tipici dell’impresa<br />
rinascimentale nei quali l’oggetto o l’immagine sono associati ad una iscrizione e i due elementi<br />
si completano a vicenda, non di rado complicando però il significato generale del messaggio. Un<br />
siffatto uso della scrittura, quindi, pone d’Annunzio come un antesignano dell’arte concettuale,<br />
così come sembra alludere a forme del dadaismo l’utilizzo di oggetti d’uso come oggetti d’arte. Il<br />
ricorso a elementi funzionali di recupero, soprattutto tratti da armi o da macchine suggerisce, poi,<br />
la presenza della «decima musa» <strong>dei</strong> futuristi, ovvero Euplete Eurètria Energèia, legata all’epica<br />
della tecnica moderna (e quindi, tra l’altro, anche al cinema).<br />
Tra i diversi procedimenti dannunziani per la creazione del simbolo è da notare la<br />
trasposizione di ciò che è naturale in elemento artificiale e viceversa. «Per ciò, continuando<br />
l’opera della divina Madre, la loro mente si trasmuta in una similitudine di mente divina, come<br />
dice Leonardo» spiega, Stelio Effrena nel Fuoco. L’artista, infatti, è prometeico e gareggia<br />
con la natura, la sua abilità sta, a seconda degli ambienti, nella fusione con essa, come<br />
nell’arengo e nel superamento della stessa, creando una natura di oggetti artificiali (per<br />
esempio gli animali e le piante nella casa e nel parco) o oggetti super-naturali come la<br />
«land-art» <strong>dei</strong> massi sacri. Interessante è anche la metodologia di inserimento: l’opera in<br />
calco o di recupero viene elevata e isolata, «contraffatta» e dorata.<br />
Alcune forme sono poi archetipi della sua arte come l’alternanza dilatato-snello, l’arco<br />
teso e lo scatto del corpo, le forme flessuose e “musicali” e altre a guglia o appuntite; o<br />
ancora, concave che portano ricchezza di suono e di colore, per giungere al pieno circolare,<br />
immagine dell’«orbe» che può essere richiamato tanto dai frutti quanto dal recinto sacro<br />
che convoglia in sé le energie universali. In particolare d’Annunzio era affascinato da quella<br />
che chiamava la «Linea circonferenziale di che si genera la bellezza umana», riprendendo<br />
un pensiero leonardesco e sempre basandosi sulle affermazioni di Leonardo nel Trattato<br />
della pittura egli sottolinea il valore del vuoto, del concavo chiaroscurato, importante<br />
quanto il pieno, perché nelle ombre si addensa il mistero della forma: «Adunque tu pittore<br />
farai l’ombra più scura appresso alla sua cagione, ed il fine che si converta in luce, cioè<br />
che paia senza fine». Per questo molte delle sue creazioni sono immerse in un ambiente<br />
di luce artificiale che quindi può essere direzionata in modo teatrale, oppure un luogo è<br />
reso volutamente ombroso come l’Arengo dalla presenza delle grandi magnolie. Nel caso<br />
specifico gli elementi musicali della natura come il canto degli uccelli si fondono con quelli<br />
della armonia delle forme e della «musica della guerra» che sempre accompagna i suoi<br />
cimeli.<br />
Dopo la prima fase del progetto volta alla ricostruzione della percezione estetica<br />
dannunziana, sono stati individuati tre percorsi nella casa e nel parco relativi all’uso del<br />
102 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong> 103 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong><br />
ready made, ai riferimenti rinascimentali, e alla statua legata al teatro. Ogni ambiente è stato<br />
commentato dagli alunni con iscrizioni in latino di loro invenzione, ispirate all’uso <strong>dei</strong> motti<br />
dannunziani, e con citazioni tratte dalle opere del Vate volte ad approfondirne i molteplici<br />
significati. In quest’ambito proponiamo un percorso esterno che presenta l’ingresso della<br />
Cittadella e i luoghi del parco dove si celebrano i «riti della patria».<br />
Rossana Cerretti<br />
LA FORTEZZA DEI RITI DELLA PATRIA<br />
Il percorso si articola partendo dall’ingresso del Vittoriale per giungere alla facciata della<br />
villa che già ci introduce al rapporto di d’Annunzio con il Rinascimento e il tardo Medioevo<br />
attraverso gli stemmi delle antiche città e famiglie italiche fino all’evocazione di san<br />
Francesco; approda poi, al Sacrario <strong>dei</strong> massi dove sono rievocate le principali battaglie della<br />
prima guerra mondiale attraverso una installazione simbolica. Da qui si passa all’Arengo<br />
luogo <strong>dei</strong> legionari fiumani e tempio del martirio per la patria dove sono issate come reliquie<br />
grandi ogive di proiettili. Così l’eroe Tommaso Gulli è celebrato dalla prua della sua stessa<br />
nave confitta sulla collina nell’atto di navigare verso la Dalmazia. Ma eroica è anche la<br />
fedeltà <strong>dei</strong> levrieri, simboli di bellezza, valore ed eroismo ineguagliabili nel mondo animale,<br />
celebrati qui dalle sepolture vegliate solennemente da un boschetto di cipressi. Il percorso<br />
culmina con l’immagine dell’hortus conclusus della Canefora nel quale lo spirito umano degli<br />
eroi potrà morire e rinascere.