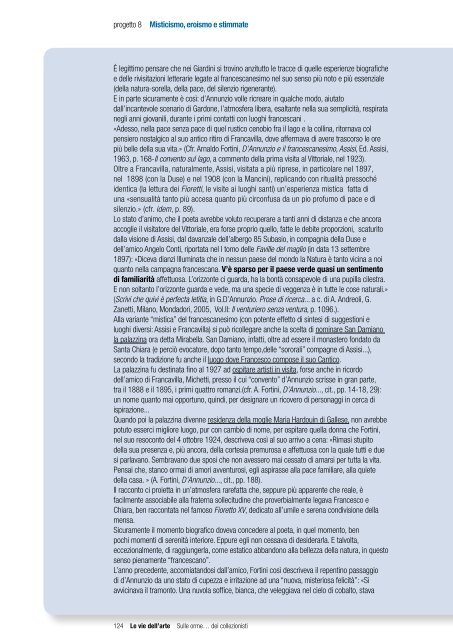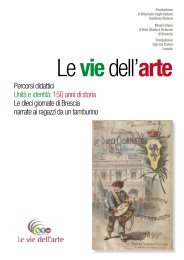Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
progetto 8 Misticismo, eroismo e stimmate<br />
È legittimo pensare che nei Giardini si trovino anzitutto le tracce di quelle esperienze biografiche<br />
e delle rivisitazioni letterarie legate al francescanesimo nel suo senso più noto e più essenziale<br />
(della natura-sorella, della pace, del silenzio rigenerante).<br />
E in parte sicuramente è così: d’Annunzio volle ricreare in qualche modo, aiutato<br />
dall’incantevole scenario di Gardone, l’atmosfera libera, esaltante nella sua semplicità, respirata<br />
negli anni giovanili, durante i primi contatti con luoghi francescani .<br />
«Adesso, nella pace senza pace di quel rustico cenobio fra il lago e la collina, ritornava col<br />
pensiero nostalgico al suo antico ritiro di Francavilla, dove affermava di avere trascorso le ore<br />
più belle della sua vita.» (Cfr. Arnaldo Fortini, D’Annunzio e il francescanesimo, Assisi, Ed. Assisi,<br />
1963, p. 168-Il convento sul lago, a commento della prima visita al Vittoriale, nel 1923).<br />
Oltre a Francavilla, naturalmente, Assisi, visitata a più riprese, in particolare nel 1897,<br />
nel 1898 (con la Duse) e nel 1908 (con la Mancini), replicando con ritualità pressoché<br />
identica (la lettura <strong>dei</strong> Fioretti, le visite ai luoghi santi) un’esperienza mistica fatta di<br />
una «sensualità tanto più accesa quanto più circonfusa da un pio profumo di pace e di<br />
silenzio.» (cfr. idem, p. 89).<br />
Lo stato d’animo, che il poeta avrebbe voluto recuperare a tanti anni di distanza e che ancora<br />
accoglie il visitatore del Vittoriale, era forse proprio quello, fatte le debite proporzioni, scaturito<br />
dalla visione di Assisi, dal davanzale dell’albergo 85 Subasio, in compagnia della Duse e<br />
dell’amico Angelo Conti, riportata nel I tomo delle Faville del maglio (in data 13 settembre<br />
1897): «Diceva dianzi Illuminata che in nessun paese del mondo la Natura è tanto vicina a noi<br />
quanto nella campagna francescana. V’è sparso per il paese verde quasi un sentimento<br />
di familiarità affettuosa. L’orizzonte ci guarda, ha la bontà consapevole di una pupilla cilestra.<br />
E non soltanto l’orizzonte guarda e vede, ma una specie di veggenza è in tutte le cose naturali.»<br />
(Scrivi che quivi è perfecta letitia, in G.D’Annunzio. Prose di ricerca... a c. di A. Andreoli, G.<br />
Zanetti, Milano, Mondadori, 2005, Vol.II: Il venturiero senza ventura, p. 1096.).<br />
Alla variante “mistica” del francescanesimo (con potente effetto di sintesi di suggestioni e<br />
luoghi diversi: Assisi e Francavilla) si può ricollegare anche la scelta di nominare San Damiano<br />
la palazzina ora detta Mirabella. San Damiano, infatti, oltre ad essere il monastero fondato da<br />
Santa Chiara (e perciò evocatore, dopo tanto tempo,delle “sororali” compagne di Assisi...),<br />
secondo la tradizione fu anche il luogo dove Francesco compose il suo Cantico.<br />
La palazzina fu destinata fino al 1927 ad ospitare artisti in visita, forse anche in ricordo<br />
dell’amico di Francavilla, Michetti, presso il cui “convento” d’Annunzio scrisse in gran parte,<br />
tra il 1888 e il 1895, i primi quattro romanzi.(cfr. A. Fortini, D’Annunzio..., cit., pp. 14-18, 29):<br />
un nome quanto mai opportuno, quindi, per designare un ricovero di personaggi in cerca di<br />
ispirazione...<br />
Quando poi la palazzina divenne residenza della moglie Maria Hardouin di Gallese, non avrebbe<br />
potuto esserci migliore luogo, pur con cambio di nome, per ospitare quella donna che Fortini,<br />
nel suo resoconto del 4 ottobre 1924, descriveva così al suo arrivo a cena: «Rimasi stupito<br />
della sua presenza e, più ancora, della cortesia premurosa e affettuosa con la quale tutti e due<br />
si parlavano. Sembravano due sposi che non avessero mai cessato di amarsi per tutta la vita.<br />
Pensai che, stanco ormai di amori avventurosi, egli aspirasse alla pace familiare, alla quiete<br />
della casa. » (A. Fortini, D’Annunzio..., cit., pp. 188).<br />
Il racconto ci proietta in un’atmosfera rarefatta che, seppure più apparente che reale, è<br />
facilmente associabile alla fraterna sollecitudine che proverbialmente legava Francesco e<br />
Chiara, ben raccontata nel famoso Fioretto XV, dedicato all’umile e serena condivisione della<br />
mensa.<br />
Sicuramente il momento biografico doveva concedere al poeta, in quel momento, ben<br />
pochi momenti di serenità interiore. Eppure egli non cessava di desiderarla. E talvolta,<br />
eccezionalmente, di raggiungerla, come estatico abbandono alla bellezza della natura, in questo<br />
senso pienamente “francescano”.<br />
L’anno precedente, accomiatandosi dall’amico, Fortini così descriveva il repentino passaggio<br />
di d’Annunzio da uno stato di cupezza e irritazione ad una “nuova, misteriosa felicità”: «Si<br />
avvicinava il tramonto. Una nuvola soffice, bianca, che veleggiava nel cielo di cobalto, stava<br />
progetto 8 Misticismo, eroismo e stimmate<br />
124 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong> 125 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong><br />
sospesa sulla cima del colle, con le orlature che si accendevano, sempre più intensamente, di<br />
porpora. Ed egli la contemplava, rapito. – Guarda quella nuvola – disse. Era tornato veramente,<br />
sinceramente, poeta. E io pensai e sperai che la poesia, grazie al prodigio e alla santità di<br />
Francesco d’Assisi, avesse potuto ricondurlo alla vita, alla vera vita. » (A. Fortini, D’Annunzio...,<br />
cit., pp.187).<br />
È lo stesso poeta, d’altronde, a suggerirci la particolare sfumatura di alcune zone all’aperto:<br />
«Nel giardino, sotto il faggio di porpora, [...] è un lembo di prato, quasi frammento di vasta<br />
prateria: ché l’erba v’è folta e vivida e libera come nelle piane solitudini. Tra queste pietre di<br />
memoria [...] è uno spazio angusto ove il vento nel piegar l’erba sembra recare l’alito di una<br />
vastità remota, di una smisurata libertà. Mi vince la subita voglia di stendermi, di affondarmi, di<br />
abbandonarmi al sonno senza compagna...<br />
Nel riadagiare il capo sul mio braccio sinistro piegato come quel del Prigione di Michelangelo,<br />
intravedo per entro il verde fitto pochi fiori lievi.» (Cento e cento e cento pagine del libro segreto<br />
di Gabriele d’Annunzio tentato di morire, a c. di P. Gibellini, Mi, 1995, p. 210.)<br />
Questa la forte connotazione del settore del giardino già prima della sistemazione del<br />
’25, quando d’Annunzio volle collocare sotto il faggio la statua del Santo, potenziandone<br />
ulteriormente la valenza.<br />
Ma tale pace aveva preteso in passato, e pretendeva ancora, il prezzo di una lotta interiore:<br />
il poeta dopo tanti anni tornava a rivivere, forse, anche la sera di quel lontano pomeriggio del<br />
1897, quando i due innamorati si erano recati al Roseto di S. Maria degli Angeli, e un fraticello<br />
aveva ricordato loro la tentazione fisica vinta dal Santo: «Per domare il malvagio desiderio, il<br />
figlio di Pietro Bernardone si getta ignudo nel roseto, si rotola sui duri aculei, li insanguina di<br />
sé. Le rose devastate lo blandiscono, quand’egli le preme [...] Come la candela accesa scorre<br />
lungo la grata, scorgiamo al limite del roseto certi grandi e pesanti fiori rossi che contrastano<br />
per la lor sensualità vistosa con que’ tenui gambi senza spine.»<br />
Terminata la visita, i due erano tornati alla campagna notturna, con un’eco di inquietudine: «La<br />
valle si colma di lento sonno; lavato dalla pioggia, il cielo si sgombra. Ma ancora biancheggia<br />
il letto del Tescio tortuoso; che è l’imagine dell’implacabile desiderio, dell’inestinguibile sete,<br />
a contrasto con le linee consolatrici della terra francescana. Questo fiumicello serpeggiante,<br />
disseccato, taciturno, tutto di selci bianche e lisce, attrae di continuo il mio sguardo e il mio<br />
spirito. È un aspetto di tormento, è il segno dell’anima agitata e avida [...].<br />
Non v’è forse corrispondenza tra il perfido ardore di questo fiume e il turbamento che traeva<br />
Francesco a castigare il suo corpo su le spine del roseto? Anche Francesco aveva in sé il suo<br />
Tescio, come questa campagna placida, felice e pia». (“Scrivi che quivi è perfecta letitia”, cit.,<br />
pp. 1097-1099).<br />
Nel ricordo di quella stagione giovanile di ardore e turbamento, durante la sistemazione del<br />
giardino, d’Annunzio volle dunque riproporre a se stesso, probabilmente, la prima complessa<br />
immagine “mistica” di Francesco: colui che poteva concedere temporanea innocenza e<br />
contemplazione, avendo vissuto e vinto nella propria carne, oltre che nell’anima, le stesse<br />
tentazioni di Gabriele.<br />
Rileggiamo ancora una volta, quindi, e tentiamo di organizzare alla luce di queste<br />
considerazioni, i diversi segnali presenti nel giardino: allusione erotica contenuta nella Venere<br />
Anadyomene e nel motto sul RECTO dell’’iscrizione; statua di Francesco (orante, ma anche<br />
“buon pastore” salvifico, replicato, in origine, da una statuetta in scala, a duplice protezione del<br />
gruppo di pecore ancora visibile); collocazione originaria della statua sotto un faggio rosso e a<br />
brevissima distanza dal ruscelletto (Rivotorto) che si getta nella Valletta dell’Acqua Pazza...<br />
Non possiamo non sentire riaffiorare nel giardino, fresco e vitale, solitario e amico, la prima<br />
stagione della “devozione”dannunziana, i giorni di desiderata pace, il ricordo del giovanile<br />
bisogno (vero o presunto tale...) di uno stato d’animo rasserenato, in fuga da una’arsura<br />
e da un’ansia principalmente sensuali. “Dare da bere agli assetati” l’opera di misericordia<br />
con cui Francesco, con sollecitudine, viene in soccorso al poeta, evocato esplicitamente dal<br />
“Sitientibus” posto ai piedi del Santo, sul masso.