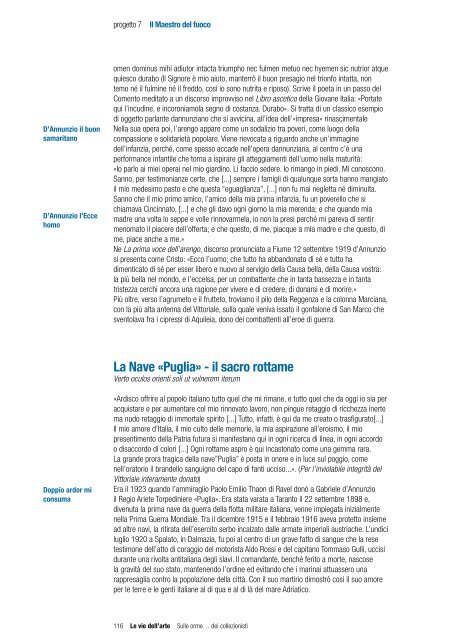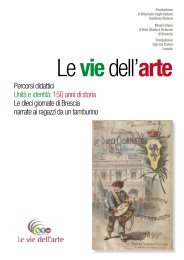Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
D’Annunzio il buon<br />
samaritano<br />
D’Annunzio l’Ecce<br />
homo<br />
Doppio ardor mi<br />
consuma<br />
progetto 7 Il Maestro del fuoco progetto 7 Il Maestro del fuoco<br />
omen dominus mihi adiutor intacta triumpho nec fulmen metuo nec hyemen sic nutrior atque<br />
quiesco durabo (Il Signore è mio aiuto, manterrò il buon presagio nel trionfo intatta, non<br />
temo né il fulmine né il freddo, così io sono nutrita e riposo). Scrive il poeta in un passo del<br />
Comento meditato a un discorso improvviso nel Libro ascetico della Giovane Italia: «Portate<br />
qui l’incudine, e incoroniamola segno di costanza. Durabo». Si tratta di un classico esempio<br />
di oggetto parlante dannunziano che si avvicina, all’idea dell’«impresa» rinascimentale<br />
Nella sua opera poi, l’arengo appare come un sodalizio tra poveri, come luogo della<br />
compassione e solidarietà popolare. <strong>Vie</strong>ne rievocata a riguardo anche un’immagine<br />
dell’infanzia, perché, come spesso accade nell’opera dannunziana, al centro c’è una<br />
performance infantile che torna a ispirare gli atteggiamenti dell’uomo nella maturità:<br />
«Io parlo ai miei operai nel mio giardino. Li faccio sedere. Io rimango in piedi. Mi conoscono.<br />
Sanno, per testimonianze certe, che [...] sempre i famigli di qualunque sorta hanno mangiato<br />
il mio medesimo pasto e che questa “eguaglianza”, [...] non fu mai negletta né diminuita.<br />
Sanno che il mio primo amico, l’amico della mia prima infanzia, fu un poverello che si<br />
chiamava Cincinnato, [...] e che gli davo ogni giorno la mia merenda; e che quando mia<br />
madre una volta lo seppe e volle rinnovarmela, io non la presi perché mi pareva di sentir<br />
menomato il piacere dell’offerta; e che questo, di me, piacque a mia madre e che questo, di<br />
me, piace anche a me.»<br />
Ne La prima voce dell’arengo, discorso pronunciato a Fiume 12 settembre 1919 d’Annunzio<br />
si presenta come Cristo: «Ecco l’uomo; che tutto ha abbandonato di sé e tutto ha<br />
dimenticato di sé per esser libero e nuovo al servigio della Causa bella, della Causa vostra:<br />
la più bella nel mondo, e l’eccelsa, per un combattente che in tanta bassezza e in tanta<br />
tristezza cerchi ancora una ragione per vivere e di credere, di donarsi e di morire.»<br />
Più oltre, verso l’agrumeto e il frutteto, troviamo il pilo della Reggenza e la colonna Marciana,<br />
con la più alta antenna del Vittoriale, sulla quale veniva issato il gonfalone di San Marco che<br />
sventolava fra i cipressi di Aquileia, dono <strong>dei</strong> combattenti all’eroe di guerra.<br />
La Nave «Puglia» - il sacro rottame<br />
Verto oculos orienti soli ut vulnerem iterum<br />
«Ardisco offrire al popolo italiano tutto quel che mi rimane, e tutto quel che da oggi io sia per<br />
acquistare e per aumentare col mio rinnovato lavoro, non pingue retaggio di ricchezza inerte<br />
ma nudo retaggio di immortale spirito [...] Tutto, infatti, è qui da me creato o trasfigurato[...]<br />
Il mio amore d’Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspirazione all’eroismo, il mio<br />
presentimento della Patria futura si manifestano qui in ogni ricerca di linea, in ogni accordo<br />
o disaccordo di colori [...] Ogni rottame aspro è qui incastonato come una gemma rara.<br />
La grande prora tragica della nave”Puglia” è posta in onore e in luce sul poggio, come<br />
nell’oratorio il brandello sanguigno del capo di fanti ucciso...». (Per l’inviolabile integrità del<br />
Vittoriale interamente donato)<br />
Era il 1923 quando l’ammiraglio Paolo Emilio Thaon di Ravel donò a Gabriele d’Annunzio<br />
il Regio Ariete Torpediniere «Puglia». Era stata varata a Taranto il 22 settembre 1898 e,<br />
divenuta la prima nave da guerra della flotta militare italiana, venne impiegata inizialmente<br />
nella Prima Guerra Mondiale. Tra il dicembre 1915 e il febbraio 1916 aveva protetto insieme<br />
ad altre navi, la ritirata dell’esercito serbo incalzato dalle armate imperiali austriache. L’undici<br />
luglio 1920 a Spalato, in Dalmazia, fu poi al centro di un grave fatto di sangue che la rese<br />
testimone dell’atto di coraggio del motorista Aldo Rossi e del capitano Tommaso Gulli, uccisi<br />
durante una rivolta antitaliana degli slavi. Il comandante, benché ferito a morte, nascose<br />
la gravità del suo stato, mantenendo l’ordine ed evitando che i marinai attuassero una<br />
rappresaglia contro la popolazione della città. Con il suo martirio dimostrò così il suo amore<br />
per le terre e le genti italiane al di qua e al di là del mare Adriatico.<br />
116 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong> 117 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong><br />
La motivazione della medaglia d’oro assegnatagli spiega:<br />
«Ascoltando l’impulso generoso della sua anima fiera di<br />
soldato italiano, era accorso inerme, sapendo in pericolo<br />
quasi mortale ed inermi essi pure i suoi marinai in mezzo alla<br />
steppa selvaggia e sfrenata di Spalato; moriva serenamente,<br />
come gli antichi eroi della stirpe, il marinaio generoso,<br />
consacrando del suo sangue gentile anche una volta questa,<br />
zolla sacrata da tanto secolare martirio, e rinsaldava di tutto<br />
lo spasimo del nostro tormento, di tutta la grandezza del suo<br />
sacrificio, il patto d’amore indissolubile, inviolabile, da fratelli<br />
a fratelli, fra le due sponde congiunte e non mai divise del<br />
mare ch’è nostro ».<br />
L’atteggiamento che più affascinò d’Annunzio fu l’estremo<br />
atto di coraggio di cui il Gulli fu protagonista in ospedale,<br />
quando, ormai agonizzante, nonostante il pericolo di morire<br />
dissanguato, volle strapparsi le bende per vedere le ferite.<br />
Così doveva fare l’Italia - disse il poeta - non nascondere,<br />
ma guardare le proprie ferite.<br />
La nave, destinata a essere demolita nel 1923, fu accettata<br />
di buon grado da d’Annunzio che immediatamente ne<br />
predispose il montaggio e la messa a nuovo: la prua rimase<br />
quella originale mentre la poppa, aggiunta nel 1933, fu<br />
riedificata in muratura; venne poi posizionato l’albero di<br />
poppa. La sua posizione verso est doveva accompagnare<br />
nell’immaginario del poeta il profilo”grifagno” di Manerba nel quale egli si figurava da<br />
sempre l’effigie di Dante irato e ammonitore per le terre d’Italia ancora irredente al di là del<br />
“mare nostro”, cioè l’Adriatico.<br />
Infine, sulla prua, come polena, fu posta la Vittoria angolare, scultura bronzea realizzata da<br />
Renato Brozzi.<br />
Questa statua, simbolo delle numerose ed eroiche vittorie, regge un serto di foglie e poggia<br />
su un fascio di frecce dorate, che simulano la presenza di un rostro, accompagnata dal<br />
motto «Così ferisco», presente anche nel soffitto della Stanza del Lebbroso. Tale frase fa<br />
riferimento alla funzione della nave Puglia, nave da guerra con cui il Vate aveva attaccato e<br />
“ferito” i nemici occupanti della Dalmazia. Altro evidente riferimento alle terre dalmate, è la<br />
direzione della prua, che punta verso le coste dell’Adriatico, come se fosse sempre pronta a<br />
salpare verso nuove battaglie per la rivendicazione delle terre irredente.<br />
Il concetto di «partenza» non è legato solamente a eventi militari, ma ha anche significato<br />
religioso: più precisamente fa riferimento al culto vichingo. Alla morte di un capo infatti, le<br />
sue spoglie, poste su una nave da guerra, si allontanavano seguendo le correnti dell’oceano;<br />
anche il Vate era un comandante e come tale avrebbe solcato le impetuose acque nella<br />
sua ultima impresa, nell’ultimo viaggio verso l’eterno sonno. Del resto questa metafora è<br />
presente anche nella Sala <strong>dei</strong> Calchi dove il soffitto è simile a quello delle navi passeggeri<br />
dell’epoca. Inoltre a rimarcare il significato sacrale e funerario, la nave Puglia è circondata<br />
da cipressi, alberi che hanno assunto fin dall’antichità una funzione legata ai riti della morte.<br />
Il nome, infatti, deriva dalla triste leggenda del giovane Ciparisso, che per sbaglio uccise un<br />
cerbiatto che aveva allevato amorosamente. Per il dolore si tolse la vita e Apollo, commosso<br />
per la sua tragica fine, lo trasformò nell’albero di cipresso.<br />
L’intera opera, la nave, la sua collocazione, ogni dettaglio in questo ambiente è un esempio<br />
di ready-made: ogni oggetto se estraniato dal proprio contesto e posto su un “piedistallo”<br />
viene valorizzato, ne sono esaltati la bellezza, ma, soprattutto, il significato che viene<br />
sacralizzato, diventa un frammento di storia, un ricordo, un reperto. Così la nave Puglia<br />
non è in mare, ma nel mezzo di un bosco che è pelagus immaginario della vita. Navigatrice<br />
dell’aria, è sollevata sul promontorio «La Fida», si libra tra il cielo e le lontane acque del lago,<br />
La vittoria polena<br />
La traghettatrice di<br />
anime d’eroi<br />
La nave volante