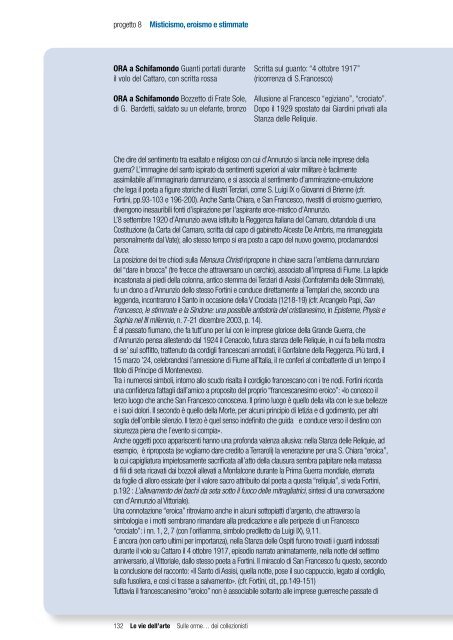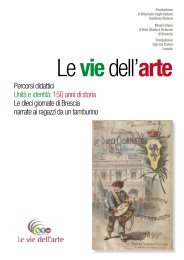Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Percorsi didattici Sulle orme… dei collezionisti - Vie dell'Arte
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
progetto 8 Misticismo, eroismo e stimmate<br />
ORA a Schifamondo Guanti portati durante<br />
il volo del Cattaro, con scritta rossa<br />
ORA a Schifamondo Bozzetto di Frate Sole,<br />
di G. Bardetti, saldato su un elefante, bronzo<br />
Scritta sul guanto: “4 ottobre 1917”<br />
(ricorrenza di S.Francesco)<br />
Allusione al Francesco “egiziano”, “crociato”.<br />
Dopo il 1929 spostato dai Giardini privati alla<br />
Stanza delle Reliquie.<br />
Che dire del sentimento tra esaltato e religioso con cui d’Annunzio si lancia nelle imprese della<br />
guerra? L’immagine del santo ispirato da sentimenti superiori al valor militare è facilmente<br />
assimilabile all’immaginario dannunziano, e si associa al sentimento d’ammirazione-emulazione<br />
che lega il poeta a figure storiche di illustri Terziari, come S. Luigi IX o Giovanni di Brienne (cfr.<br />
Fortini, pp.93-103 e 196-200). Anche Santa Chiara, e San Francesco, rivestiti di eroismo guerriero,<br />
divengono inesauribili fonti d’ispirazione per l’aspirante eroe-mistico d’Annunzio.<br />
L’8 settembre 1920 d’Annunzio aveva istituito la Reggenza Italiana del Carnaro, dotandola di una<br />
Costituzione (la Carta del Carnaro, scritta dal capo di gabinetto Alceste De Ambris, ma rimaneggiata<br />
personalmente dal Vate); allo stesso tempo si era posto a capo del nuovo governo, proclamandosi<br />
Duce.<br />
La posizione <strong>dei</strong> tre chiodi sulla Mensura Christi ripropone in chiave sacra l’emblema dannunziano<br />
del “dare in brocca” (tre frecce che attraversano un cerchio), associato all’impresa di Fiume. La lapide<br />
incastonata ai piedi della colonna, antico stemma <strong>dei</strong> Terziari di Assisi (Confraternita delle Stimmate),<br />
fu un dono a d’Annunzio dello stesso Fortini e conduce direttamente ai Templari che, secondo una<br />
leggenda, incontrarono il Santo in occasione della V Crociata (1218-19) (cfr. Arcangelo Papi, San<br />
Francesco, le stimmate e la Sindone: una possibile antistoria del cristianesimo, in Episteme, Physis e<br />
Sophia nel III millennio, n. 7-21 dicembre 2003, p. 14).<br />
È al passato fiumano, che fa tutt’uno per lui con le imprese gloriose della Grande Guerra, che<br />
d’Annunzio pensa allestendo dal 1924 il Cenacolo, futura stanza delle Reliquie, in cui fa bella mostra<br />
di se’ sul soffitto, trattenuto da cordigli francescani annodati, il Gonfalone della Reggenza. Più tardi, il<br />
15 marzo ’24, celebrandosi l’annessione di Fiume all’Italia, il re conferì al combattente di un tempo il<br />
titolo di Principe di Montenevoso.<br />
Tra i numerosi simboli, intorno allo scudo risalta il cordiglio francescano con i tre nodi. Fortini ricorda<br />
una confidenza fattagli dall’amico a proposito del proprio “francescanesimo eroico”: «Io conosco il<br />
terzo luogo che anche San Francesco conosceva. Il primo luogo è quello della vita con le sue bellezze<br />
e i suoi dolori. Il secondo è quello della Morte, per alcuni principio di letizia e di godimento, per altri<br />
soglia dell’orribile silenzio. Il terzo è quel senso indefinito che guida e conduce verso il destino con<br />
sicurezza piena che l’evento si compia».<br />
Anche oggetti poco appariscenti hanno una profonda valenza allusiva: nella Stanza delle Reliquie, ad<br />
esempio, è riproposta (se vogliamo dare credito a Terraroli) la venerazione per una S. Chiara “eroica”,<br />
la cui capigliatura impietosamente sacrificata all’atto della clausura sembra palpitare nella matassa<br />
di fili di seta ricavati dai bozzoli allevati a Monfalcone durante la Prima Guerra mondiale, eternata<br />
da foglie di alloro essicate (per il valore sacro attribuito dal poeta a questa “reliquia”, si veda Fortini,<br />
p.192 : L’allevamento <strong>dei</strong> bachi da seta sotto il fuoco delle mitragliatrici, sintesi di una conversazione<br />
con d’Annunzio al Vittoriale).<br />
Una connotazione “eroica” ritroviamo anche in alcuni sottopiatti d’argento, che attraverso la<br />
simbologia e i motti sembrano rimandare alla predicazione e alle peripezie di un Francesco<br />
“crociato”: i nn. 1, 2, 7 (con l’orifiamma, simbolo prediletto da Luigi IX), 9,11.<br />
E ancora (non certo ultimi per importanza), nella Stanza delle Ospiti furono trovati i guanti indossati<br />
durante il volo su Cattaro il 4 ottobre 1917, episodio narrato animatamente, nella notte del settimo<br />
anniversario, al Vittoriale, dallo stesso poeta a Fortini. Il miracolo di San Francesco fu questo, secondo<br />
la conclusione del racconto: «Il Santo di Assisi, quella notte, pose il suo cappuccio, legato al cordiglio,<br />
sulla fusoliera, e così ci trasse a salvamento». (cfr. Fortini, cit., pp.149-151)<br />
Tuttavia il francescanesimo “eroico” non è associabile soltanto alle imprese guerresche passate di<br />
progetto 8 Misticismo, eroismo e stimmate<br />
132 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong> 133 Le vie dell’arte <strong>Sulle</strong> <strong>orme…</strong> <strong>dei</strong> <strong>collezionisti</strong><br />
cui d’Annunzio fu protagonista. Un’interpretazione corretta del motto “Malum et pax” ci conduce dalla<br />
facciata della Prioria alle soglie alla Stanza del Lebbroso, segnalando un passaggio successivo della<br />
concezione di “eroismo” nel Nostro.<br />
Si tratta di una disposizione battagliera nell’apparente assurdo: opporre “Silentium” e “Clausura” a<br />
chi ha offeso, a chi ha misconosciuto, ai possibili sodali di una nuova “eroica impresa” trasformati in<br />
oppositori e traditori, a chi ha risposto con il malum alla pax, ai tentativi di riconciliazione alla vigilia<br />
della guerra civile.<br />
Il progetto del Patto marino (destinato nei desideri di d’Annunzio a ripresentare all’Italia un se stesso<br />
politicamente propopositivo dopo il fallimento del sogno fiumano) si arenò per l’opposizione degli<br />
stessi possibili alleati, tra l’agosto del ’22 (tragicamente segnato dal “volo dell’arcangelo “ dalla<br />
finestra della Stanza della Musica) e il settembre del ’23.<br />
Gli armatori della Federazione Italiana <strong>dei</strong> Lavoratori del mare non vollero riconoscere d’Annunzio<br />
come “alto capo spirituale”, come stabilito da un accordo firmato con Mussolini e il capitano Giulietti,<br />
e l’autoproclamazione del poeta in qualità di unica guida della Federazione non ottenne altro che<br />
l’opposizione decisa di Ciano e Mussolini, e il fallimento del Patto stesso.<br />
Fortini, commentando lo stato d’animo dell’amico durante la sua visita al Vittoriale del 1923, ricorda<br />
una lettera di d’Annunzio a Mussolini del 1° dicembre 1922, in cui il possibile accordo era da lui<br />
definito “il nostro primo patto di fraterna pacificazione”.<br />
Osserva Fortini: “Dopo Fiume la minaccia della guerra civile che incombeva sull’Italia lo aveva indotto<br />
a svolgere un’azione di riconciliazione tra le forze avverse, in nome della bontà che avrebbe dovuto<br />
regolare la vita di ognuno e di tutti. Il 3 agosto di quello stesso anno, dopo l’occupazione di Palazzo<br />
Marino a Milano, da parte <strong>dei</strong> fascisti, d’Annunzio venne chiamato a parlare al balcone, Queste le<br />
parole rivolte alla folla: “Mentre la passione di parte tuttavia arde, mentre tuttavia fumano le arsioni<br />
e sanguinano le ferite, mentre il volto della Patria è tuttavia velatoinvochiamo la pace e onoriamo<br />
la bontà” (Fortini, cit, p.173). La chiara contrapposizione tra il bene comune e le ragioni di parte si<br />
accompagna al concetto di forza della pace, ribadendone le prospettive energetiche e rivoluzionarie:<br />
“Non sono undici i portatori della Parola / Sono legioni. Sono miriadi. La bontà ha le sue faviiamo<br />
invocazioni alla pace e alla bontà, e tutte le faville secondano la fiamma grande. Vedo in voi sfavillare<br />
la bontà efficace e militante, la bontà affermatrice e creatrice, la bontà <strong>dei</strong> lottatori e <strong>dei</strong> costruttori: la<br />
bontà vittoriosa” (G.d’A. Il libro ascetico della giovane Italia, 1926).<br />
Proporre la conciliazione delle parti, fondere in una sola fiamma tutte le fedi e tutte le energie: questo<br />
leggeva in Francesco, in quei frangenti, l’ardito di Fiume, identificandosi con l’impavido crociato che<br />
discute con il Soldano un’alternativa all’infruttuosa guerra di Damietta. È il Francesco-templare che<br />
d’Annunzio rintracciava nel Paradiso dantesco, insieme a quello mistico e allo stimmatizzato (cfr. D.<br />
Alighieri, Par. XI, in part. vv.100-102)