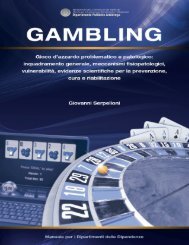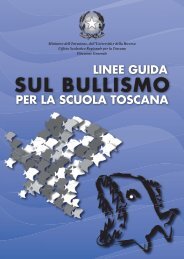Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
124 - E<strong>le</strong>menti di NEUROSCIENZE E DIPENDENZE<br />
stato infatti definito il “centro di ricompensa” del sistema<br />
nervoso (Anton et al, 2001; Koob, 1992).<br />
Secondo la teoria della “gratificazione a cascata” ideata<br />
da Blum e Coll (2000), questi stimoli determinerebbero il<br />
rilascio di serotonina a livello ipotalamico; ta<strong>le</strong> neurotrasmettitore<br />
causa un’attivazione indiretta dei recettori degli<br />
oppioidi determinando il rilascio del<strong>le</strong> encefaline nella<br />
regione tegmenta<strong>le</strong> ventra<strong>le</strong> A10 che proietta terminazioni<br />
dopaminergiche al sistema limbico (nuc<strong>le</strong>o accumbens,<br />
amigdala, tubercolo olfattorio), all’ippocampo, alla corteccia<br />
prefronta<strong>le</strong> (Blum et al, 2000). Le encefaline inibiscono<br />
il rilascio di acido Gamma-amino-butirrico<br />
(GABA) da parte della “substantia nigra”. La riduzione<br />
della concentrazione di GABA e della sua interazione con<br />
i recettori <strong>per</strong> il GABA (in particolare GABA B ) determina<br />
una variazione dei livelli di dopamina, che, attraverso il recettore<br />
D2, svolge un ruolo chiave nel meccanismo della<br />
gratificazione. I neurotrasmettitori coinvolti in ta<strong>le</strong> sistema<br />
comprendono: serotonina, noradrenalina, GABA, encefaline<br />
ed i loro recettori nonché gli enzimi di regolazione;<br />
sono inoltre coinvolti altri agenti non ancora bene identificati.<br />
Secondo la teoria “della gratificazione a cascata”, gli<br />
stimoli fisiologici prima citati, determinano il rilascio di<br />
serotonina a livello ipotalamico; ta<strong>le</strong> neuromediatore causa<br />
un’attivazione indiretta dei recettori degli oppiodi, situati<br />
in gran parte nell’ipotalamo, determinando il rilascio del<strong>le</strong><br />
encefaline nella regione tegmenta<strong>le</strong> ventra<strong>le</strong> A10. Le encefaline<br />
inibiscono il rilascio di GABA da parte della “substantia<br />
nigra”. Il GABA agisce normalmente attraverso 2<br />
tipi diversi di recettori, A e B. La stimolazione del recettore<br />
B determina l’inibizione del rilascio di dopamina a livello<br />
della regione tegmenta<strong>le</strong> ventra<strong>le</strong> <strong>per</strong> azione sul nuc<strong>le</strong>o<br />
accumbens; quindi l’inibizione del rilascio di GABA<br />
da parte del<strong>le</strong> encefaline si traduce in un aumento del rilascio<br />
di dopamina. La dopamina, a sua volta, si <strong>le</strong>ga a 2<br />
diversi recettori (D1 e D2); il <strong>le</strong>game della dopamina con<br />
il recettore D2 rappresenta un punto chiave nel meccanismo<br />
della gratificazione ed è stato dimostrato che basse<br />
dosi di etanolo, riducendo la produzione di GABA, determinano<br />
un aumento della disponibilità di dopamina a livello<br />
di tali aree cerebrali (Mereu & Gessa, 1985). Una via<br />
alternativa coinvolge la stimolazione del recettore A, a livello<br />
dell’ippocampo, altra area primaria della gratificazione;<br />
ta<strong>le</strong> “attivazione” riduce il “desiderio eccessivo” <strong>per</strong><br />
l’alcol tramite il rilascio di noradrenalina a livello della regione<br />
A6 del “locus ceru<strong>le</strong>us” da cui si dipartono fibre dirette<br />
ad un gruppo di cellu<strong>le</strong> denominate CAx e coinvolte<br />
verosimilmente nei meccanismi della gratificazione<br />
(Daoust et al, 1987a, Daoust et al, 1987b). Fra gli agenti<br />
in grado di inibire il GABA a questo livello, di particolare<br />
importanza appaiono <strong>le</strong> tetraidroisochinoline (TIQ), soprattutto<br />
<strong>le</strong> beta-carboline (Trachtenberg & Blum, 1987);<br />
si tratta di sostanze che derivano dall’acetaldeide e che, se<br />
iniettate nell’ippocampo di ratto, sono in grado di aumentare<br />
significativamente il consumo alcolico; altra sostanza<br />
GABA-inibitrice è un neuropeptide che agisce sui recettori<br />
<strong>per</strong> <strong>le</strong> benzodiazepine, chiamato “inibitore del <strong>le</strong>game<br />
del diazepam” (DBI). Se queste due sostanze sono presenti<br />
in concentrazione e<strong>le</strong>vata a livello dell’ippocampo, si riducono<br />
i livelli di noradrenalina <strong>per</strong> inibizione del GABA e<br />
aumenta il desiderio di assumere alcol. Al contrario, se aumentano<br />
i livelli di GABA, possono essere stimolati i recettori<br />
<strong>per</strong> <strong>le</strong> benzodiazepine (anti-ansia), determinando<br />
una riduzione del consumo alcolico. Nella teoria di Blum<br />
et al., in definitiva, questo meccanismo “a cascata”, genera<br />
una sensazione di benessere, come effetto specifico a livello<br />
del<strong>le</strong> aree cerebrali della gratificazione; se un deficit o uno<br />
squilibrio interrompe o distorce ta<strong>le</strong> sistema, il risultato fina<strong>le</strong><br />
è rappresentato dalla trasformazione di ta<strong>le</strong> sensazione<br />
in una <strong>per</strong>cezione di ansia o angoscia e in uno smodato<br />
desiderio di assumere una sostanza in grado di al<strong>le</strong>viare tali<br />
spiacevoli sensazioni.<br />
Korpi e collaboratori, ad esempio, utilizzando linee<br />
genetiche se<strong>le</strong>zionate di ratti incrociati, hanno messo in<br />
evidenza che il numero dei recettori D2 della dopamina<br />
era significativamente minore nei ratti alcol-preferenti rispetto<br />
ai controlli (Korpi et al, 1987). Utilizzando DNA<br />
proveniente da cervelli autoptici di soggetti alcolisti e di<br />
soggetti non alcolisti, in “cieco”, Blum e collaboratori<br />
hanno evidenziato, nel 72% dei primi, la presenza di una<br />
banda 6.6 KB, definita al<strong>le</strong><strong>le</strong> A1, e un dimorfismo della<br />
banda 3.7 KB, definita al<strong>le</strong><strong>le</strong> A2, del gene dei recettori<br />
D2 della dopamina; inoltre, gli Autori hanno evidenziato<br />
che i soggetti che esprimono l’al<strong>le</strong><strong>le</strong> A1 hanno circa il<br />
30% in meno dei recettori D2 della dopamina (Blum, et<br />
al, 1990). Ciò potrebbe suggerire che soggetti nati con<br />
un difetto di tali recettori non sono in grado di rispondere<br />
normalmente al rilascio di dopamina e potrebbero<br />
essere inclini a cercare di aumentarne l’attività assumendo<br />
sostanze, ad esempio alcol, che ne stimolano il rilascio.<br />
Ta<strong>le</strong> ipotesi potrebbe spiegare, almeno in parte,<br />
l’alcolismo “genetico-familiare” osservato in studi effettuati<br />
a partire dalla metà degli anni ‘70, su figli di madri o padri<br />
alcolisti e adottati da genitori non alcolisti; in tali soggetti<br />
si evidenziava un rischio rispettivamente 2 o 3 volte<br />
maggiore di sviluppare l’alcolismo rispetto a figli di genitori<br />
non alcolisti (Goodwin, 1985). Tali studi hanno condotto<br />
all’inquadramento di almeno 2 distinti tipi di predisposizione<br />
genetica all’alcolismo: tipo I o alcolismo limitato<br />
all’ambiente (il più comune, si manifesta sia nei<br />
maschi che nel<strong>le</strong> donne <strong>per</strong> effetto sia di fattori genetici<br />
che di influenze ambientali) e tipo II o alcolismo limitato<br />
al sesso maschi<strong>le</strong> (forma più grave, determinata geneticamente,<br />
si manifesta solo nei maschi, con una frequenza 9<br />
volte maggiore nei figli di genitori alcolisti, indipendentemente<br />
dal tipo di ambiente esistente dopo la loro adozione)<br />
(Irwin et al, 1990). In definitiva quindi, in alcuni<br />
soggetti, a rischio di sviluppare una dipendenza da sostanze<br />
psicotrope, il sistema “a ricompensa” potrebbe non<br />
essere comp<strong>le</strong>tamente attivo, o <strong>per</strong> anomalie genetiche o<br />
a seguito di condizioni patologiche (stress emotivi, psicopatologie,<br />
ecc.). In tali soggetti, il craving deriverebbe da