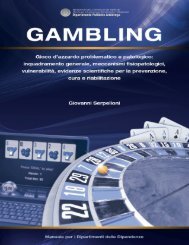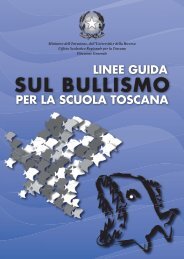Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
32 - E<strong>le</strong>menti di NEUROSCIENZE E DIPENDENZE<br />
creta, come ad esempio, il bisogno di nutrirsi quando si<br />
ha lo stomaco vuoto.<br />
Nella teoria del<strong>le</strong> basi biologiche della motivazione il<br />
“bisogno” viene considerato come la deviazione dall’equilibrio<br />
omeostatico soggettivo. La <strong>per</strong>cezione di necessità<br />
di omeostasi/coerenza attiva meccanismi di riequilibrio<br />
di vario tipo. Un bisogno determina quindi una pulsione<br />
verso il riassestamento della deviazione e la<br />
pulsione è ciò che determina la forza motivaziona<strong>le</strong> che<br />
può arrivare a motivare un’azione.<br />
I motivi che sembrano essere innati e connessi direttamente<br />
ai bisogni biologici fondamentali sono detti<br />
“motivi primari”, mentre i motivi che sono connessi solo<br />
indirettamente ai bisogni biologici, e che sembrano essere<br />
il prodotto di processi di condizionamento o apprendimento,<br />
vengono chiamati motivi secondari. Questa<br />
distinzione non è sempre chiara. Certe cose sono associate<br />
con un numero tanto grande di scopi differenti<br />
che il desiderio di esse diventa un motivo funzionalmente<br />
autonomo: è come se queste cose diventassero oggetto<br />
di una pulsione indipendente da qualunque altro<br />
scopo (Dar<strong>le</strong>y et al. 1993).<br />
Il decision making, ovvero la capacità di prendere decisioni,<br />
è certamente uno dei temi maggiormente indagati<br />
dai ricercatori vista la sua importanza in diversi ambiti<br />
della vita quotidiana (Dunn et al. 2006).<br />
Uno dei contributi più ri<strong>le</strong>vanti sull’argomento è<br />
stato dato da Bechara e col<strong>le</strong>ghi (2005) con la loro “Somatic<br />
marker hypotesis” e con il famoso “Iowa Gambling<br />
Task” un testo costruito allo scopo di valutare il decadimento<br />
del<strong>le</strong> capacità decisionali. Sono stati condotti anche<br />
studi di neuroimaging che mostrano come l’insula e<br />
i gangli della base giocano un ruolo ri<strong>le</strong>vante nel guidare<br />
<strong>le</strong> decisioni a lungo termine. Il lobo parieta<strong>le</strong> inferiore<br />
sembra coinvolto nella valutazione del<strong>le</strong> conseguenze<br />
del<strong>le</strong> decisioni e la corteccia fronta<strong>le</strong> sembra essere implicata<br />
nella correzione degli errori (Lin et al. 2008).<br />
IL COMPORTAMENTO ORIENTATO A UNO<br />
SCOPO: IL MODELLO DI SHALLICE E NORMAN<br />
Le azioni del<strong>le</strong> <strong>per</strong>sone non sono casuali e nemmeno dettate<br />
dagli eventi o dagli stimoli immediatamente presenti.<br />
Noi scegliamo come agire <strong>per</strong>ché desideriamo raggiungere<br />
particolari obiettivi (Denes & Pizzamiglio<br />
1996).<br />
Si può pensare alla motivazione come ad una forza<br />
che guida il comportamento. La probabilità e la direzione<br />
di un comportamento variano con il livello della<br />
forza che spinge a mettere in atto quel comportamento.<br />
Inoltre, mentre la motivazione può essere necessaria <strong>per</strong><br />
un certo comportamento, essa non garantisce che ta<strong>le</strong><br />
comportamento abbia luogo. Una parte fondamenta<strong>le</strong><br />
del controllo del comportamento è il controllo appropriato<br />
dell’espressione di differenti azioni motivate che<br />
hanno scopi in conflitto tra loro (ad esempio, uscire a divertirsi<br />
e stare a casa a studiare) (Bear 2003).<br />
Tim Shallice e Donald Norman (1988), <strong>per</strong> spiegare<br />
il comportamento orientato a uno scopo, hanno sviluppato<br />
un modello neuropsicologico di se<strong>le</strong>zione della risposta.<br />
Questo modello postula che la se<strong>le</strong>zione dell’azione<br />
sia un processo competitivo. Il nuc<strong>le</strong>o di ta<strong>le</strong> modello<br />
è la nozione di unità di controllo di schemi<br />
(schema control units) o rappresentazioni di risposte (representations<br />
of responses). Questi schemi possono corrispondere<br />
a movimenti espliciti o all’attivazione di rappresentazioni<br />
di lunga durata che conducono a comportamenti<br />
finalizzati.<br />
Esistono schemi comportamentali preprogrammati<br />
che hanno origine nell’apprendimento (ad esempio, <strong>per</strong>correre<br />
ogni mattina la stessa strada <strong>per</strong> andare al lavoro)<br />
o sono geneticamente determinati. Sono azioni non <strong>per</strong><br />
forza <strong>le</strong>gate alla motricità. Una volta che una di queste<br />
azioni è se<strong>le</strong>zionata, viene eseguita nel modo programmato,<br />
senza bisogno di ulteriore controllo, a meno che<br />
non sopraggiungano prob<strong>le</strong>mi. Normalmente gli schemi<br />
preprogrammati competono tra di loro attraverso il meccanismo<br />
della se<strong>le</strong>zione competitiva (contention scheduling).<br />
Ogni schema tende ad inibire gli altri, in maniera<br />
tanto più forte quanto maggiore è il suo livello di attivazione.<br />
Il livello di attivazione di ogni schema dipende<br />
dal<strong>le</strong> condizioni di stimolazione ambienta<strong>le</strong> (interna o<br />
esterna). Gli input ambientali sono i bisogni e <strong>le</strong> <strong>per</strong>cezioni.<br />
Sulla base di tali input si raggiunge un certo livello<br />
di attivazione che è correlato alla capacità di inibizione<br />
dei competitori.<br />
Le unità di controllo di schemi ricevono input da<br />
molte fonti. Gli input <strong>per</strong>cettivi e i loro col<strong>le</strong>gamenti a<br />
queste unità di controllo sono particolarmente importanti.<br />
La forza del<strong>le</strong> connessioni, tuttavia rif<strong>le</strong>tte gli effetti<br />
dell’apprendimento (se abbiamo già fatto es<strong>per</strong>ienza<br />
di una determinata situazione, quando ci ritroviamo in<br />
un contesto simi<strong>le</strong> si attiveranno i comportamenti associati<br />
alla situazione).<br />
Gli input esterni possono essere sufficienti <strong>per</strong> innescare<br />
<strong>le</strong> unità di controllo di schemi. Per esempio, è diffici<strong>le</strong><br />
non mettersi a seguire con lo sguardo un oggetto in<br />
movimento. Ma nella maggior parte dei casi <strong>le</strong> nostre<br />
azioni non sono dettate solamente dall’input; poiché molte<br />
unità di controllo di schemi si possono attivare simultaneamente,<br />
deve intervenire un processo di controllo su<strong>per</strong>iore<br />
a garantire la se<strong>le</strong>zione solo del<strong>le</strong> unità appropriate. Norman<br />
e Shallice hanno proposto che esistano due tipi di se<strong>le</strong>zione.<br />
Un tipo, alquanto automatico, è quello che essi<br />
chiamano contention scheduling (se<strong>le</strong>zione competitiva o<br />
conflitto regolato). Gli schemi non solo sono guidati dagli<br />
input <strong>per</strong>cettivi ma competono tra loro, soprattutto<br />
quando due unità di controllo sono mutuamente esclusive.<br />
Poiché fra gli schemi vi sono connessioni inibitorie, il modello<br />
spiega <strong>per</strong>ché il nostro comportamento risulta coerente.<br />
Solo uno schema (o un numero limitato di schemi