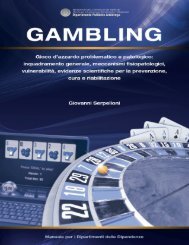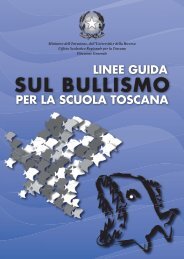Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
Neuroscienze e dipendenze - Dipartimento per le politiche antidroga
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IL CRAVING NELL’ALCOL-DIPENDENZA: MECCANISMI FISIOPATOLOGICI E TRATTAMENTO - 127<br />
et al, 2000). Il craving (“urge to drink”) viene visto come<br />
uno stato emotivo-motivaziona<strong>le</strong> in cui una <strong>per</strong>sona è<br />
motivata a cercare e ad assumere una sostanza. Pertanto<br />
secondo ta<strong>le</strong> punto di vista il craving avrebbe uno scarso<br />
o comunque discutibi<strong>le</strong> significato come parametro di valutazione<br />
nel rischio di ricaduta. Inoltre Meyer (2000) ha<br />
evidenziato in studi su uomini che la cue-reactivity in assenza<br />
dell’opportunità di bere alcol è meno intensa della<br />
cue-reactivity in cui c’è la possibilità di bere.<br />
Il modello della cue-reactivity ha rafforzato l’utilizzo<br />
della terapia psicologica; in particolar modo il trattamento<br />
degli stimoli condizionanti ha lo scopo di ridurre<br />
la propensione alla ricaduta alterando tali stimoli o la<br />
<strong>per</strong>cezione di essi. Ta<strong>le</strong> approccio terapeutico abbraccia<br />
non solo <strong>le</strong> teorie di condizionamento ma anche <strong>le</strong> teorie<br />
cognitive. Infatti sempre secondo Drummond e coll.<br />
(1995) i fattori condizionanti e quelli cognitivi della ricaduta<br />
sono livelli differenti e non in contraddizione.<br />
Teorie cognitive<br />
Nell’abito del<strong>le</strong> teorie cognitive si distinguono a loro<br />
volta vari modelli. Marlatt & Gordon (1985) hanno elaborato<br />
la “cognitive social <strong>le</strong>arning theory” (CSLT) o teoria<br />
dell’“outcome expectancy” in cui si ritiene che in situazioni<br />
ad alto rischio, in cui cioè il soggetto alcolista, astinente<br />
in quel momento, è posto nella condizione di<br />
scegliere se bere o meno, la probabilità di ricaduta dipenderà<br />
dalla fiducia dell’individuo nella sua capacità di resistere<br />
alla tentazione di bere. Le opinioni dell’individuo<br />
sul<strong>le</strong> conseguenze del bere o meno determineranno l’obbiettivo<br />
fina<strong>le</strong>, che sarà dato dall’interazione fra fattori<br />
positivi (raggiungimento del piacere, riduzione del dolore)<br />
e fattori negativi (ma<strong>le</strong>ssere, <strong>per</strong>dita del lavoro) e<br />
quindi dal preva<strong>le</strong>re degli uni o degli altri. Nell’ambito<br />
di questa teoria, il craving è definito comunque in termini<br />
di condizionamento come un “desiderio verso gli<br />
effetti positivi della sostanza”, <strong>per</strong> cui il craving sarebbe<br />
una risposta condizionata indotta da stimoli associati ad<br />
una precedente gratificazione (Marlatt & Gordon,<br />
1985). Riprendendo la teoria di Marlatt & Gordon,<br />
Wright e collaboratori (1993) ha descritto 4 tipi di craving:<br />
1) craving in risposta a sintomi astinenziali; 2) craving<br />
in risposta alla <strong>per</strong>dita del piacere; 3) craving come<br />
risposta condizionata a “cues” verso sostanza 4) craving<br />
in risposta a desideri edonistici (<strong>per</strong> esempio in combinazione<br />
con l’attività sessua<strong>le</strong>).<br />
Nel “cognitive labeling model”, basato sul<strong>le</strong> teorie cognitive<br />
di Schachter & Singer (1962), secondo cui lo<br />
stato cognitivo-emoziona<strong>le</strong> è soggetto a influenze esterne<br />
e al contesto individua<strong>le</strong>, si ritiene che se da una parte il<br />
craving durante l’astinenza può essere differente rispetto<br />
a quello in risposta allo stimolo dato dall’alcol, dall’altra<br />
parte può essere interpretato allo stesso modo dal punto<br />
di vista cognitivo, va<strong>le</strong> a dire come espressione dell’ “addicitive<br />
behaviour” (Drummond, 2001).<br />
Nel “dual-affect model”, proposto da Baker, Morse &<br />
Sherman (1987), il craving può essere indotto da stimoli<br />
positivi (cues) o da stimoli negativi (astinenza) e in ta<strong>le</strong><br />
teoria si ipotizza la presenza di due sistemi, il sistema affettivo<br />
positivo e quello negativo, che si inibiscono reciprocamente<br />
tra di loro.<br />
Un altro modello, il “dynamic regulatory model”, è<br />
stato proposto da Niaura e coll. (1988). Secondo ta<strong>le</strong><br />
modello il craving si sviluppa dalla combinazione di alterazioni<br />
del tono dell’umore e risposte condizionate a<br />
stimoli positivi e negativi. L’assunzione di alcol e i fenomeni<br />
di ricaduta sono mediati dalla capacità di reazione<br />
allo stimolo e dall’autocontrollo; tuttavia entrambi tali<br />
fattori sono influenzati dal craving che, <strong>per</strong>tanto, gioca<br />
un ruolo molto importante nell’incrementare il rischio<br />
di ricaduta. Inoltre l’inizia<strong>le</strong> assunzione della sostanza induce<br />
il <strong>per</strong>petuarsi dell’assunzione della stessa attraverso<br />
l’effetto di rinforzo positivo sul tono dell’umore, con circuito<br />
a feed-back positivo. Recentemente lo stesso<br />
Niaura (2000) ha rivisto ta<strong>le</strong> teoria e ha evidenziato che<br />
il craving in risposta a stimoli condizionanti è un parametro<br />
significativo, ma la sua importanza si riduce enormemente<br />
se l’autocontrollo, la capacità di reazione allo<br />
stimolo e l’ansia sono ben controllati.<br />
Tra <strong>le</strong> teorie cognitive, comunque va citato il “cognitive<br />
processing model” elaborato da Tiffany (1990). Secondo<br />
ta<strong>le</strong> modello, l’abuso di sostanze è regolato da processi<br />
cognitivi automatici, mentre il craving rappresenta<br />
l’attivazione di processi cognitivi non automatici. Il craving,<br />
secondo il modello di Tiffany, è un processo non automatico<br />
che richiede uno sforzo menta<strong>le</strong> ed è limitato<br />
dalla capacità cognitiva della <strong>per</strong>sona. In altre paro<strong>le</strong>, il<br />
craving è visto come una “costellazione di risposte verbali,<br />
somatoviscerali e comportamentali attraverso processi cognitivi<br />
non automatici” (Tiffany, 1990). Questo modello<br />
inoltre implica la possibilità che vi sia l’assunzione di alcol<br />
e il comportamento di ricerca dell’alcol anche in assenza<br />
di craving, così che il craving <strong>per</strong>de, in questo modello, il<br />
potere predittivo di ricaduta. Inoltre, a differenza di altre<br />
teorie, il craving non avrebbe né un ruolo centra<strong>le</strong> né margina<strong>le</strong><br />
nei meccanismi alla base dell’assunzione di alcol e<br />
del comportamento di ricerca dell’alcol, ma sarebbe piuttosto<br />
un marker di processi cognitivi e solo in alcuni casi<br />
associato alla ricerca e all’assunzione di alcol.<br />
In accordo con <strong>le</strong> teorie di Tiffany, Breiner e collaboratori<br />
sostengono che il craving è solamente una componente<br />
dei processi mentali che influenzano il comportamento<br />
di ricerca della sostanza (Breiner et al, 1999). Gli<br />
stimoli correlati all’alcol (ARCs-Alcohol-related Cues)<br />
possono attivare una competizione tra l’inclinazione a<br />
bere e quella a non farlo. Ta<strong>le</strong> atteggiamento conflittua<strong>le</strong><br />
e ambiva<strong>le</strong>nte è un e<strong>le</strong>mento fondamenta<strong>le</strong> di un modello<br />
decisiona<strong>le</strong> di cui il craving fa parte.<br />
Carter e Tiffany (1999) hanno condotto una metaanalisi<br />
sulla applicazione del “cue-reactivity paradigm”<br />
nella dipendenza da alcol, nicotina, eroina e cocaina, ana-