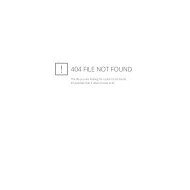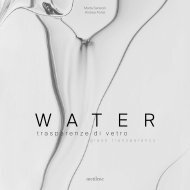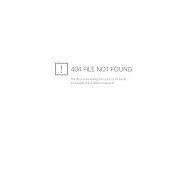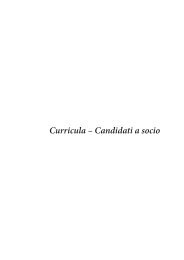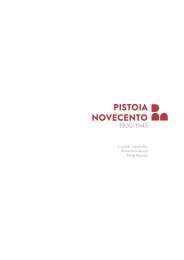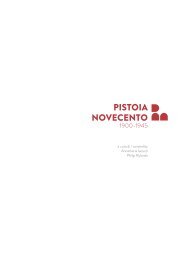Palazzo de'Rossi. Una storia pistoiese
a cura di Roberto Cadonici fotografie di Aurelio Amendola
a cura di Roberto Cadonici
fotografie di Aurelio Amendola
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
del titolare. Cfr. anche E. Spalletti, R. Viale, Tommaso Puccini,<br />
cit., pp. 127-131.<br />
204. <strong>Palazzo</strong> dei Rossi, p. 90; BCF, Rossi, 21, cc. 4v, 5r. Laura<br />
Sozzifanti, nata il 19 marzo 1780, aveva allora ventun anni<br />
ed era più giovane di diciotto anni rispetto al marito: cfr.<br />
BCF, Rossi, 28, c. 32r (=94r).<br />
205. È la stanza attualmente destinata a ufficio del Presidente<br />
della Fondazione. Sulla costruzione e sull’allestimento di<br />
questi ambienti cfr. le note 134, 183. La figurazione, che si<br />
raccoglie al centro della volta, lasciando intorno un ampio<br />
spazio libero, consiste in una composizione triangolare che<br />
comprende in basso a sinistra la figura apollinea dell’Amore<br />
assiso sulle nubi, coronato da un serto di fiori, che tiene nella<br />
destra una face accesa e dà la sinistra al sovrastante Cupido;<br />
quest’ultimo completa l’amoroso legame tenendo con<br />
la sinistra la mano della Fedeltà biancovestita, seduta dalla<br />
parte opposta all’Amore e accompagnata dal fido cagnolino<br />
bianco di casa, che si affaccia, da una nuvola, sul lato destro.<br />
Al di sopra dei due personaggi allegorici si libra in volo la<br />
gentile figura femminile dell’Unione matrimoniale, dal cuore<br />
radiante e in atto di tenere con la destra una corona d’alloro<br />
e di additare con la sinistra un luminoso ed evanescente<br />
Tempio che compare in alto nel cielo, simbolo della Chiesa e<br />
della sua plurisecolare Sapienza ispirata da Dio. <strong>Una</strong> simile<br />
immagine di Tempio, in prospettiva dal sotto in su, compariva<br />
peraltro nell’Allegoria della Fama e della Sapienza dipinta<br />
nel 1787 da Luigi Catani sulla volta della Sala delle Colonne<br />
nel Conservatorio di San Niccolò a Prato: cfr. C. Morandi,<br />
Luigi Catani, cit., pp. 27-29. Né pare un caso che l’architettura<br />
a pianta centrale di quel Tempio rimandi ad evidentiam<br />
al celebre tempietto bramantesco di San Pietro in Montorio<br />
e, in senso lato, alla capitale della Cristianità e della cultura<br />
classica. L’allegoria della Concordia, dell’Amore e della Fedeltà<br />
coniugale che rendono duraturo il matrimonio consacrato<br />
è completata dalla balza ornamentale di rigiro intorno alla<br />
base della volta stessa. La decorazione è organizzata col ripetersi<br />
dei motivi della corona d’alloro, della face accesa e<br />
della faretra contenente frecce, alternati a mazzi di steli e<br />
foglie con triplice infiorescenza a bacche di papavero, alludenti<br />
al Sonno: con evidente riferimento alle funzioni cui<br />
era adibita quella camera matrimoniale. Le caratteristiche<br />
stilistiche, chiaramente analoghe a quelle proprie a Luigi<br />
Catani nel decennio precedente al 1800, si riferiscono anche<br />
a sue particolarità illustrative sia nelle figure che nelle<br />
nubi: queste ultime dal tipico aspetto soffice, ma compatto<br />
e quasi quadrato, piane nella parte superiore come a far da<br />
sedile per le figure dell’Amore e della Fedeltà coniugale. Sulla<br />
pittura di Catani cfr. anche le successive note 211-216.<br />
206. <strong>Palazzo</strong> dei Rossi, p. 90 nota 251 e pp. 99-100 nota 266.<br />
207. Prima di quello di Francesco dei Rossi si era registrato<br />
solo il matrimonio di suo padre Vincenzo, avvenuto il 22<br />
ottobre 1749: <strong>Palazzo</strong> dei Rossi, p. 17 nota 35.<br />
208. Sulla precedente situazione della camera con annessa<br />
toilette e stanzetta per la cameriera cfr. le note 134, 182, 183.<br />
Si deve sicuramente al riassetto, verso il 1799-1800, delle<br />
prime due in occasione del prossimo matrimonio di Francesco,<br />
oltre che l’affresco sulla volta della camera nuziale,<br />
anche l’ornato à trompe-l’oeil che abbellisce il piccolo vano<br />
dell’attigua toilette, fatto dipingere con un finto rivestimento<br />
architettonico ‘alla classica’, recuperato nell’ultimo restauro.<br />
209. Soltanto Chiara d’Afflitto si era soffermata, fino a qualche<br />
tempo fa, a considerare con una certa attenzione i dipinti<br />
al primo piano del palazzo de’ Rossi: cfr. C. d’Afflitto,<br />
Le arti figurative dal periodo neoclassico, cit., pp. 299, 309. La<br />
studiosa menzionava come autori degli affreschi dei primi<br />
decenni dell’Ottocento Bartolomeo Valiani, Nicola Monti<br />
e Giuseppe Bezzuoli (per le opere firmate e datate), attribuendo<br />
la decorazione “alla raffaella” della “galleria nuova”<br />
a Ferdinando Marini (che l’avrebbe dipinta nel 1830) e le<br />
pitture con la Musica e la Notte a Bartolomeo Valiani. In quel<br />
sintetico profilo non era cenno alle altre pitture esistenti<br />
nel palazzo, neppure all’allegoria della Fedeltà coniugale.<br />
210. Né ad un riscontro diretto, né dalla documentazione<br />
fotografica disponibile sul restauro dei dipinti della Fedeltà<br />
coniugale e de La Notte risultano firme o date o iscrizioni di<br />
alcun genere.<br />
211. Cfr. C. Morandi, Luigi Catani, cit., pp. 32-36. A conclusione<br />
dell’attività giovanile il pittore poté giovarsi di<br />
importanti commissioni facenti capo al vescovo di Pistoia<br />
Scipione de’ Ricci e all’ambiente ecclesiastico in contatto<br />
con lui: la decorazione del soffitto della sala di lettura della<br />
Biblioteca Roncioniana di Prato (dove nel 1789 riprodusse,<br />
nell’allegoria di Pallade che strappa l’Adolescenza agli ozi di Venere,<br />
l’analoga scena dipinta da Pietro da Cortona nel 1641<br />
nella Sala di Venere in <strong>Palazzo</strong> Pitti); gli affreschi nel nuovo<br />
<strong>Palazzo</strong> vescovile di Pistoia fra 1789 e 1790, ed in particolare<br />
il Trionfo della Religione con i ritratti degli Asburgo-Lorena<br />
nella grande sala dell’Udienza, compiuto nel 1790 (su cui cfr.<br />
anche la seguente nota 216); ancora un Trionfo della Chiesa,<br />
eseguito fra 1790 e 1792, sul soffitto della Sala del Capitolo<br />
della cattedrale pratese di S. Stefano. Questa pittura aggiornata<br />
sul gusto della corte granducale, dove Catani avrebbe<br />
a lungo lavorato per Ferdinando III, ebbe in Pistoia imitatori<br />
e seguaci, come già osservato. Allora soprattutto il<br />
colto Tommaso Puccini, in qualità di direttore degli Uffizi<br />
e di fine conoscitore d’arte, avrebbe fatto da tramite fra gli<br />
orientamenti artistici della capitale del Granducato e la sua<br />
città natale.<br />
212. Ibidem, pp. 85-92.<br />
213. Ibidem, pp. 86-89.<br />
214. Ibidem, pp. 90-92. Dalla fine del Settecento fino alla<br />
Restaurazione lo stile di Luigi Catani si sarebbe maturato in<br />
senso neoclassico, spiritualizzando ed alleggerendo figure<br />
e colorismi, sotto l’influenza della contemporanea pittura<br />
francese; ma si sarebbe anche ulteriormente arricchito<br />
guardando alle coeve rielaborazioni dei rilievi e della statuaria<br />
romana antica e agli esempi della pittura raffaellesca.<br />
Sul repertorio ornamentale di Luigi Catani cfr., in questo<br />
studio, la nota 167. Sulla sua impresa decorativa e pittorica<br />
nella villa di Scornio, coadiuvato da Luigi Cheli ed altri<br />
collaboratori fra 1805 e 1810 (fino al 1807 direttamente) cfr.<br />
L. Dominici, Gli affreschi del Villone di Scornio dal primo Settecento<br />
al 1842, in La villa e il parco Puccini di Scornio (“Quaderni<br />
pistoiesi di <strong>storia</strong> dell’arte”, 10), Pistoia, Cassa di Risparmio<br />
di Pistoia e Pescia, 1992, pp. 9-54, tavv. I-XVI: 39-42; Eadem,<br />
La villa Puccini di Scornio, cit., pp. 97-118: 116.<br />
215. Cfr. L. Gai, Teatro dell’Accademia dei Risvegliati, cit., p.<br />
358. Un testimone coevo, l’abbastanza malevolo architetto<br />
Giuliano Gatteschi, aveva a riferire che nel rinnovamento<br />
del 1796 nel sipario del Teatro era stata dipinta “l’Aurora di<br />
Guido [Reni] dal Catani pittor fiorentino, che dipinse anche<br />
il Parnasso delle Muse all’Accademia dei Cittadini di Pistoia,<br />
donde escano gl’attori a recitare”: si trattava dell’Aurora<br />
di Guido Reni dipinta nel 1613 nel Casino dell’Aurora<br />
di <strong>Palazzo</strong> Rospigliosi a Roma e del celebre affresco del<br />
neoclassico Anton Raphael Mengs (1728-1779) raffigurante<br />
il Parnaso dipinto fra il 1760 e il 1761 sulla volta della Galleria<br />
di Villa Albani a Roma. Spesso con la sua abilità tecnica<br />
Luigi Catani veniva incontro ai desiderata dei committenti,<br />
che ambivano avere una riproduzione di opere celebri nelle<br />
loro dimore. Sulla copia di Ferdinando Marini dell’Aurora<br />
desunta da Catani da un dipinto di Guido Reni, cfr. la nota<br />
287.<br />
216. Sull’attività di Luigi Catani nel nuovo <strong>Palazzo</strong> vescovile<br />
di Pistoia, cfr. R. Roani Villani, La decorazione del Seminario<br />
e del <strong>Palazzo</strong> Vescovile, in Scipione de’ Ricci, cit. pp. 179-184:<br />
182-184 (dove l’autrice non manca di rilevare le “suggestioni<br />
neo-seicentesche” del vasto dipinto con il Trionfo della Religione<br />
nella Sala dell’Udienza, realizzato da Catani nel 1790,<br />
e specialmente “nel gruppo dell’Eresia in cui la donna è direttamente<br />
esemplata su una delle Parche dipinte da Giovanni<br />
da San Giovanni sul soffitto del Salone degli Argenti<br />
in <strong>Palazzo</strong> Pitti”, ivi, p. 183); C. d’Afflitto, Le arti figurative<br />
dal periodo neoclassico, cit., p. 291; E. Guscelli, Il nuovo palazzo<br />
vescovile, cit., p. 94, 103; G.C. Romby, <strong>Palazzo</strong> vescovile nuovo,<br />
cit., pp. 341-343; C. Morandi, Luigi Catani, cit., pp. 32-35<br />
(dove però la studiosa colloca la Sala dell’Udienza non –<br />
come sarebbe stato corretto – nel nuovo palazzo episcopale<br />
<strong>pistoiese</strong>, ma nel “vasto complesso del Seminario Vescovile”).<br />
217. Cfr. la nota 214.<br />
218. Nella prima sistemazione critica sull’argomento avevo<br />
attribuito ad un “pittore della Fedeltà coniugale” l’omonimo<br />
dipinto ed a Nicola Monti la più tarda raffigurazione de La<br />
Notte: cfr. <strong>Palazzo</strong> dei Rossi, pp. 96-97, 111-112; collocando comunque<br />
le due opere in relazione con i primi tempi della<br />
vita matrimoniale di Francesco dei Rossi, dato che esse risultavano<br />
confacenti a quanto è stato possibile conoscere<br />
sul carattere di questo personaggio, ardito e impulsivo, sagace<br />
e anticonformista. Né potrebbe in alcun modo adattarsi<br />
alla diversa indole del figlio di Francesco, Girolamo,<br />
la committenza di un’immagine così sensuale come quella<br />
de La Notte, suggestiva evocatrice dei riti pagani dell’eros<br />
bacchico collegati al mito di Arianna e, insieme, della favola<br />
antica di Amore e Psiche. Sulla <strong>storia</strong> del modello servito per<br />
l’elaborazione dell’immagine, la scultura ellenistica un tempo<br />
ritenuta Cleopatra, poi dal 1805 correttamente identificata<br />
con Arianna, e sulla sua trasformazione ideata da Bénigne<br />
Gagneraux, cfr. le seguenti note 227-233.<br />
219. Cfr., fra la tuttora non molto ampia saggistica su Nicola<br />
Monti, C. Sisi, Niccola Monti, in Cultura dell’Ottocento<br />
a Pistoia. La collezione Puccini, Catalogo del Museo Civico, a<br />
cura di C. Mazzi, C. Sisi, Firenze, La Nuova Italia Editrice,<br />
1977, pp. 99-101: 100; più di recente R. Giovannelli, Piccolo<br />
viaggio al centro della Toscana, 3, in Piccolo viaggio al centro della<br />
Toscana. Da Montecatini per luoghi d’incanto, tra arte, <strong>storia</strong>,<br />
architettura, paesaggio e tradizioni popolari, a cura di R. Giovannelli,<br />
Pistoia, Gli Ori / Fondazione Cassa di Risparmio<br />
di Pistoia e Pescia, 2004, pp. 119-136; Idem, Memorie di un<br />
convalescente pittore di provincia. Appunti autobiografici di Niccola<br />
Monti, pittore pistojese, scritti dal 1839 al 1841, Firenze, Edizioni<br />
Polistampa, 2016, con profilo biografico del pittore e<br />
relativa bibliografia.<br />
220. C. Sisi, Niccola Monti, cit., p. 100. Si veda anche, dello<br />
stesso autore, il contributo edito nel presente volume.<br />
221. Effettivamente l’ordine superiore di festeggiare anche a<br />
Pistoia le nozze dell’imperatore Napoleone con Maria Luisa<br />
d’Austria era stato impartito con un volantino stampato il<br />
18 aprile 1810, a firma del maire Francesco Tolomei: le celebrazioni<br />
erano state indette per il seguente 22 dello stesso<br />
mese: cfr. L’età rivoluzionaria e napoleonica, cit., p. 88 nota 3.<br />
Sulla distruzione del quadro di Napoleone cfr. C. Sisi, Niccola<br />
Monti, cit., p. 100. Cfr. anche A. Zucchi O.P., <strong>Una</strong> lettera<br />
inedita del pittore Niccola Monti, in BSP, XXXII, 1930, pp.<br />
94-96: nota 2 pp. 95-96. Secondo l’abate Pietro Contrucci,<br />
testimone coevo, durante la sollevazione anti-francese del<br />
1814 i pubblici magistrati, per evitare l’assalto al <strong>Palazzo</strong><br />
Civico, non trovarono di meglio che gettare dalla finestra<br />
alla folla il quadro di Napoleone dipinto da Monti; il ritratto<br />
venne così distrutto. Cfr. anche G. Petracchi, Pistoia dalle<br />
riforme leopoldine, cit., pp. 44, 46-47 e R. Giovannelli, Piccolo<br />
viaggio, cit., pp. 129-131; Idem, Memorie di un convalescente,<br />
cit., pp. 26-27, 29.<br />
of the Uffizi in the incumbent’s absence. See too Spalletti<br />
and Viale, Tommaso Puccini, 127-31.<br />
204. “<strong>Palazzo</strong> dei Rossi,” 90; BCF, Rossi, 21, ff. 4 v , 5 r . Laura<br />
Sozzifanti, born on March 19, 1780, was twenty-one at the<br />
time and eighteen years younger than her husband: see<br />
BCF, Rossi, 28, f. 32 r (=94 r ).<br />
205. On the construction and decoration of these rooms<br />
see notes 134 and 183. The painting, which is located at the<br />
center of the vault, leaving ample free space around it, is a<br />
triangular composition with the classically handsome figure<br />
of Eros at bottom left, seated on clouds and crowned with a<br />
garland of flowers, holding a lit torch in his right hand and<br />
extending his left to the Cupid above; the latter completes<br />
the bond of love by holding with his left hand the hand<br />
of Fidelity, dressed in white, seated on the opposite side to<br />
Eros and accompanied by a faithful family pet, a white dog,<br />
which peeps out of a cloud, on the right. Above the two allegorical<br />
personifications hovers the graceful female figure<br />
of Matrimonial Union, with a radiant heart and holding a laurel<br />
wreath in her right hand while pointing with the left at<br />
a luminous and evanescent Temple that appears high up in<br />
the sky, a symbol of the Church and its centuries of Wisdom<br />
inspired by God. A similar image of a Temple, represented<br />
in sotto in su perspective, appeared in the Allegory of Fame<br />
and Wisdom painted in 1787 by Luigi Catani on the vault of<br />
the Sala delle Colonne in the Conservatorio di San Niccolò<br />
in Prato: see Morandi, “Luigi Catani,” 27-29. Nor does it<br />
seem to be a coincidence that the central-plan structure of<br />
that temple is an obvious reference to Bramante’s celebrated<br />
Tempietto di San Pietro in Montorio and, in a broader<br />
sense, to the capital of Christendom and classical culture.<br />
The allegory of the Harmony, the Love and the Conjugal Fidelity<br />
that make marriage last is completed by an ornamental<br />
frieze running around the base of the vault. The decoration<br />
consists of a repetition of the motifs of the laurel<br />
wreath, the blazing torch and the quiver filled with arrows,<br />
alternating with bunches of stems and leaves with a triple<br />
inflorescence of poppy heads, alluding to Sleep: evidently a<br />
reference to the functions for which that marriage chamber<br />
was used. The stylistic features, clearly akin to those of Luigi<br />
Catani’s work in the decade preceding 1800, also include<br />
some illustrative peculiarities in both the figures and the<br />
clouds: the latter have a typically soft appearance, but are<br />
compact and almost square, with a flattened upper part as if<br />
to serve as a seat for the figures of Eros and Conjugal Fidelity.<br />
On Catani’s painting see too notes 211-16.<br />
206. “<strong>Palazzo</strong> dei Rossi,” 90 note 251 and 99-100 note 266.<br />
207. The only marriage recorded before Francesco dei Rossi’s<br />
was that of his father Vincenzo, on October 22, 1749:<br />
“<strong>Palazzo</strong> dei Rossi,” 17 note 35.<br />
208. On the previous situation of the bedroom with attached<br />
toilette and maid’s room see notes 134, 182 and 183.<br />
In addition to the fresco on the vault of the bridal chamber,<br />
the trompe-l’oeil ornamentation of the small toilette, painted<br />
with a mock architectural facing “in the classical manner,”<br />
brought back to light in the latest restoration, undoubtedly<br />
dated from the reorganization, around 1799-1800, of the<br />
first two on the occasion of Francesco’s marriage.<br />
209. Until not long ago, only Chiara d’Afflitto had chosen<br />
to pay a certain amount of attention to the paintings<br />
on the second floor of <strong>Palazzo</strong> de’ Rossi: see C. d’Afflitto,<br />
“Le arti figurative dal periodo neoclassico,” 299, 309. The<br />
scholar names the authors of the frescoes painted in the<br />
early decades of the 19th century as Bartolomeo Valiani,<br />
Nicola Monti and Giuseppe Bezzuoli (for the signed and<br />
dated works), attributing the decoration “after the style<br />
of Raphael” of the “new gallery” to Ferdinando Marini (in<br />
1830) and the paintings of Music and the Night to Bartolomeo<br />
Valiani. She made no mention in that concise sketch<br />
of the other paintings in the building, not even the allegory<br />
of Conjugal Fidelity.<br />
210. Neither direct examination of the paintings of Conjugal<br />
Fidelity and The Night nor the photographic documentation<br />
of their restoration reveals signatures or dates or inscriptions<br />
of any kind.<br />
211. See Morandi, “Luigi Catani,” 32-36. At the end of the<br />
early part of his career the young painter received important<br />
commissions from Bishop Scipione de’ Ricci of Pistoia<br />
and the ecclesiastic circles in contact with him: the decoration<br />
of the ceiling of the reading room of the Biblioteca<br />
Roncioniana in Prato (where in 1789 he reproduced, in the<br />
allegory of Pallas Tearing Adolescence Away from the Idleness of<br />
Venus, the scene painted by Pietro da Cortona in the Sala<br />
di Venere of <strong>Palazzo</strong> Pitti in 1641); the frescoes in the new<br />
Bishop’s Palace of Pistoia between 1789 and 1790, and in<br />
particular the Triumph of Religion with the portraits of members<br />
of the Habsburg-Lorraine dynasty in the large Audience<br />
Chamber, completed in 1790; another Triumph of the<br />
Church, painted between 1790 and 1792 on the ceiling of<br />
the Chapterhouse of the cathedral of San Stefano in Prato.<br />
This style of painting in line with the taste of the grand ducal<br />
court, where Catani had long worked for Ferdinand III,<br />
had imitators and followers in Pistoia, as has already been<br />
pointed out. At the time the cultivated Tommaso Puccini,<br />
in his capacity as director of the Uffizi and art connoisseur,<br />
would have acted as an intermediary between the artistic<br />
orientations of the capital of the grand duchy and the city<br />
of his birth.<br />
212. Ibidem, 85-92.<br />
213. Ibidem, 86-89.<br />
214. Ibidem, 90-92. From the end of the 18th century until<br />
the Restoration Luigi Catani’s style took a neoclassi-<br />
cal turn, growing more idealized and lightening its figures<br />
and coloring under the influence of contemporary French<br />
painting; but it would be further enriched by his encounter<br />
with current reworkings of ancient Roman reliefs and<br />
statuary and examples of Raphaelesque painting. On Luigi<br />
Catani’s ornamental repertoire see note 167 to this study.<br />
On his decorative work and paintings in the Villa di Scornio,<br />
with the assistance of Luigi Cheli and others between<br />
1805 and 1810 (and his direct involvement up until 1807) see<br />
L. Dominici, “Gli affreschi del Villone di Scornio dal primo<br />
Settecento al 1842,” in La villa e il parco Puccini di Scornio<br />
(“Quaderni pistoiesi di <strong>storia</strong> dell’arte,” 10) (Pistoia: Cassa<br />
di Risparmio Pistoia e Pescia, 1992), 9-54, pls. I-XVI: 39-42;<br />
idem, “La villa Puccini di Scornio,” 97-118: 116.<br />
215. See Gai, “Teatro dell’Accademia dei Risvegliati,” 358.<br />
A contemporary witness, the somewhat malicious architect<br />
Giuliano Gatteschi, tells us that in the renovation of 1796<br />
the theater curtain had been painted with “Guido [Reni]’s<br />
Aurora by the Florentine painter Catani, who also painted<br />
the Parnassus of the Muses at the Accademia dei Cittadini in<br />
Pistoia, from where the actors come out to perform”: the<br />
reference is to the Aurora painted by Guido Reni in 1613<br />
in the Casino dell’Aurora of <strong>Palazzo</strong> Rospigliosi in Rome<br />
and to the famous fresco of the Parnassus by the neoclassical<br />
artist Anton Raphael Mengs (1728-79), painted between<br />
1760 and 1761 on the ceiling of the Gallery of Villa Albani in<br />
Rome. Luigi Catani often used his technical skills to fulfill<br />
the desires of his clients, who wanted to have reproductions<br />
of celebrated works in their homes. On Ferdinando<br />
Marini’s copy of the Aurora derived by Catani from a painting<br />
by Guido Reni, see note 287.<br />
216. On Luigi Catani’s activity in the new Bishop’s Palace of<br />
Pistoia, see R. Roani Villani, “La decorazione del Seminario<br />
e del <strong>Palazzo</strong> Vescovile,” in Scipione de’ Ricci e la realtà <strong>pistoiese</strong>,<br />
179-84: 182-84 (where the author does not fail to point<br />
out the “influences of the 17th century revival” on the huge<br />
painting of the Triumph of Religion in the Audience Chamber,<br />
executed by Catani in 1790, and especially “in the group<br />
of Heresy where the woman is based directly on one of the<br />
Fates painted by Giovanni da San Giovanni on the ceiling<br />
of the Salone degli Argenti in <strong>Palazzo</strong> Pitti,” ibidem, 183); C.<br />
d’Afflitto, “Le arti figurative dal periodo neoclassico,” 291;<br />
E. Guscelli, “Il nuovo palazzo vescovile,” 94, 103; Romby,<br />
“<strong>Palazzo</strong> vescovile nuovo,” 341-43; Morandi, “Luigi Catani,”<br />
32-35 (in which, however, the scholar places the Audience<br />
Chamber not—as would have been correct—in the new<br />
Bishop’s Palace of Pistoia but in the “grand complex of the<br />
Episcopal Seminary”).<br />
217. See note 214.<br />
218. In my first critical analysis of the question I had attributed<br />
the painting to a “painter of the Conjugal Fidelity”<br />
and the later representation of The Night to Nicola Monti:<br />
see “<strong>Palazzo</strong> dei Rossi,” 96-97, 111-12; placing, however, the<br />
two works in relation with the early part of Francesco dei<br />
Rossi’s married life, given that they seemed to be in keeping<br />
with what it has been possible to find out about the<br />
character of this bold and impulsive, sharp-witted and unconventional<br />
person. Nor could the commission of an image<br />
as sensual as The Night, evocative of the pagan rites of<br />
Bacchic eros linked to the myth of Ariadne and, at the same<br />
time, the ancient legend of Cupid and Psyche, have been in<br />
any way suited to the different disposition of Francesco’s<br />
son Girolamo. On the history of the model used for the<br />
image, the Hellenistic sculpture once thought to represent<br />
Cleopatra, and then from 1805 correctly identified as Ariadne,<br />
and its transformation by Bénigne Gagneraux, see<br />
notes 227-33 below.<br />
219. See, amongst the still not very extensive literature<br />
on Nicola Monti, C. Sisi, “Niccola Monti,” in Cultura<br />
dell’Ottocento a Pistoia. La collezione Puccini, catalogue of<br />
the Museo Civico, ed. C. Mazzi and C. Sisi (Florence: La<br />
Nuova Italia Editrice, 1977), 99-101: 100; more recently R.<br />
Giovannelli, “Piccolo viaggio al centro della Toscana, 3,” in<br />
Piccolo viaggio al centro della Toscana. Da Montecatini per luoghi<br />
d’incanto, tra arte, <strong>storia</strong>, architettura, paesaggio e tradizioni popolari,<br />
ed. R. Giovannelli (Pistoia: Gli Ori / Fondazione Cassa<br />
di Risparmio di Pistoia e Pescia, 2004), 119-36; idem, Memorie<br />
di un convalescente pittore di provincia. Appunti autobiografici<br />
di Niccola Monti, pittore pistojese, scritti dal 1839 al 1841 (Florence:<br />
Edizioni Polistampa, 2016), with biographical profile<br />
of the painter and relative bibliography.<br />
220. See Sisi, “Niccola Monti,” 100. See too the essay by the<br />
same author in this volume.<br />
221. In fact the order to celebrate Emperor Napoleon’s marriage<br />
to Maria Luisa of Austria in Pistoia too had been given<br />
in a handbill printed on April 18, 1810, and signed by the<br />
maire Francesco Tolomei: the celebrations had been scheduled<br />
for the 22nd of the same month: see L’età rivoluzionaria<br />
e napoleonica, 88 note 3. On the destruction of the picture of<br />
Napoleon see Sisi, “Niccola Monti,” 100. See too A. Zucchi<br />
O.P., “<strong>Una</strong> lettera inedita del pittore Niccola Monti,” BSP,<br />
XXXII (1930), 94-96: 95-96 note 2. According to the abbé<br />
Pietro Contrucci, a contemporary witness, during the uprising<br />
against the French in 1814 the magistrates could find<br />
no better way to avoid an assault on the City Hall than to<br />
throw Monti’s portrait of Napoleon out of the window to<br />
the crowd below; as a result the picture was destroyed. See<br />
too Petracchi, “Pistoia dalle riforme leopoldine,” 44, 46-47,<br />
and Giovannelli, “Piccolo viaggio,” 129-31; idem, Memorie di<br />
un convalescente, 26-27, 29.<br />
222. Sisi, “Niccola Monti,” 100. On the “refoundation,” in<br />
July 1806, of the “Accademia di varia letteratura” as “Acca-<br />
150<br />
151