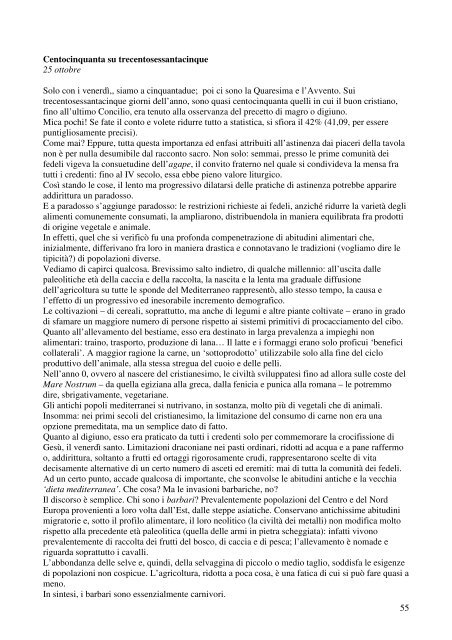Assaggi di fame - Filippo Radaelli
Assaggi di fame - Filippo Radaelli
Assaggi di fame - Filippo Radaelli
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Centocinquanta su trecentosessantacinque<br />
25 ottobre<br />
Solo con i venerdì,, siamo a cinquantadue; poi ci sono la Quaresima e l’Avvento. Sui<br />
trecentosessantacinque giorni dell’anno, sono quasi centocinquanta quelli in cui il buon cristiano,<br />
fino all’ultimo Concilio, era tenuto alla osservanza del precetto <strong>di</strong> magro o <strong>di</strong>giuno.<br />
Mica pochi! Se fate il conto e volete ridurre tutto a statistica, si sfiora il 42% (41,09, per essere<br />
puntigliosamente precisi).<br />
Come mai? Eppure, tutta questa importanza ed enfasi attribuiti all’astinenza dai piaceri della tavola<br />
non è per nulla desumibile dal racconto sacro. Non solo: semmai, presso le prime comunità dei<br />
fedeli vigeva la consuetu<strong>di</strong>ne dell’agape, il convito fraterno nel quale si con<strong>di</strong>videva la mensa fra<br />
tutti i credenti: fino al IV secolo, essa ebbe pieno valore liturgico.<br />
Così stando le cose, il lento ma progressivo <strong>di</strong>latarsi delle pratiche <strong>di</strong> astinenza potrebbe apparire<br />
ad<strong>di</strong>rittura un paradosso.<br />
E a paradosso s’aggiunge paradosso: le restrizioni richieste ai fedeli, anziché ridurre la varietà degli<br />
alimenti comunemente consumati, la ampliarono, <strong>di</strong>stribuendola in maniera equilibrata fra prodotti<br />
<strong>di</strong> origine vegetale e animale.<br />
In effetti, quel che si verificò fu una profonda compenetrazione <strong>di</strong> abitu<strong>di</strong>ni alimentari che,<br />
inizialmente, <strong>di</strong>fferivano fra loro in maniera drastica e connotavano le tra<strong>di</strong>zioni (vogliamo <strong>di</strong>re le<br />
tipicità?) <strong>di</strong> popolazioni <strong>di</strong>verse.<br />
Ve<strong>di</strong>amo <strong>di</strong> capirci qualcosa. Brevissimo salto in<strong>di</strong>etro, <strong>di</strong> qualche millennio: all’uscita dalle<br />
paleolitiche età della caccia e della raccolta, la nascita e la lenta ma graduale <strong>di</strong>ffusione<br />
dell’agricoltura su tutte le sponde del Me<strong>di</strong>terraneo rappresentò, allo stesso tempo, la causa e<br />
l’effetto <strong>di</strong> un progressivo ed inesorabile incremento demografico.<br />
Le coltivazioni – <strong>di</strong> cereali, soprattutto, ma anche <strong>di</strong> legumi e altre piante coltivate – erano in grado<br />
<strong>di</strong> sfamare un maggiore numero <strong>di</strong> persone rispetto ai sistemi primitivi <strong>di</strong> procacciamento del cibo.<br />
Quanto all’allevamento del bestiame, esso era destinato in larga prevalenza a impieghi non<br />
alimentari: traino, trasporto, produzione <strong>di</strong> lana… Il latte e i formaggi erano solo proficui ‘benefici<br />
collaterali’. A maggior ragione la carne, un ‘sottoprodotto’ utilizzabile solo alla fine del ciclo<br />
produttivo dell’animale, alla stessa stregua del cuoio e delle pelli.<br />
Nell’anno 0, ovvero al nascere del cristianesimo, le civiltà sviluppatesi fino ad allora sulle coste del<br />
Mare Nostrum – da quella egiziana alla greca, dalla fenicia e punica alla romana – le potremmo<br />
<strong>di</strong>re, sbrigativamente, vegetariane.<br />
Gli antichi popoli me<strong>di</strong>terranei si nutrivano, in sostanza, molto più <strong>di</strong> vegetali che <strong>di</strong> animali.<br />
Insomma: nei primi secoli del cristianesimo, la limitazione del consumo <strong>di</strong> carne non era una<br />
opzione preme<strong>di</strong>tata, ma un semplice dato <strong>di</strong> fatto.<br />
Quanto al <strong>di</strong>giuno, esso era praticato da tutti i credenti solo per commemorare la crocifissione <strong>di</strong><br />
Gesù, il venerdì santo. Limitazioni draconiane nei pasti or<strong>di</strong>nari, ridotti ad acqua e a pane raffermo<br />
o, ad<strong>di</strong>rittura, soltanto a frutti ed ortaggi rigorosamente cru<strong>di</strong>, rappresentarono scelte <strong>di</strong> vita<br />
decisamente alternative <strong>di</strong> un certo numero <strong>di</strong> asceti ed eremiti: mai <strong>di</strong> tutta la comunità dei fedeli.<br />
Ad un certo punto, accade qualcosa <strong>di</strong> importante, che sconvolse le abitu<strong>di</strong>ni antiche e la vecchia<br />
‘<strong>di</strong>eta me<strong>di</strong>terranea’. Che cosa? Ma le invasioni barbariche, no?<br />
Il <strong>di</strong>scorso è semplice. Chi sono i barbari? Prevalentemente popolazioni del Centro e del Nord<br />
Europa provenienti a loro volta dall’Est, dalle steppe asiatiche. Conservano antichissime abitu<strong>di</strong>ni<br />
migratorie e, sotto il profilo alimentare, il loro neolitico (la civiltà dei metalli) non mo<strong>di</strong>fica molto<br />
rispetto alla precedente età paleolitica (quella delle armi in pietra scheggiata): infatti vivono<br />
prevalentemente <strong>di</strong> raccolta dei frutti del bosco, <strong>di</strong> caccia e <strong>di</strong> pesca; l’allevamento è nomade e<br />
riguarda soprattutto i cavalli.<br />
L’abbondanza delle selve e, quin<strong>di</strong>, della selvaggina <strong>di</strong> piccolo o me<strong>di</strong>o taglio, sod<strong>di</strong>sfa le esigenze<br />
<strong>di</strong> popolazioni non cospicue. L’agricoltura, ridotta a poca cosa, è una fatica <strong>di</strong> cui si può fare quasi a<br />
meno.<br />
In sintesi, i barbari sono essenzialmente carnivori.<br />
55