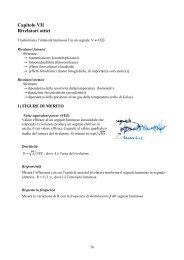You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(0) Il metodo scientifico<br />
Qual é l’oggetto della scienza naturale ? La scienza si occupa dei fenomeni naturali vale a dire di<br />
tutte quelle cose che osserviamo accadere, di quelle manifestazioni della natura, che “entrano in<br />
relazione” con i nostri sensi, e che noi consideriamo rilevanti e degne di essere studiate. In<br />
particolare, anche la fisica studia tali “manifestazioni”. E’ difficile circoscrivere con chiarezza il<br />
campo di indagine della fisica rispetto ad altre discipline quali la chimica o la biologia (e in effetti<br />
esistono discipline di confine quali la chimica fisica e la biofisica). In modo generale e forse<br />
discutibile, si può dire che la fisica si distingue dagli altri settori di indagine, per il fatto di studiare i<br />
fenomeni nelle loro manifestazioni più “elementari” o “fondamentali”, ovvero per il fatto di<br />
occuparsi dei sistemi più semplici esistenti in natura.<br />
Il metodo con cui in fisica vengono studiati i fenomeni naturali si colloca entro il quadro più vasto<br />
del metodo scientifico, una grande costruzione di pensiero e di esperienza sviluppata nel corso degli<br />
ultimi secoli. La fisica fa proprio il metodo scientifico, con alcune specificità dovute al tipo di<br />
problemi che devono essere affrontati.<br />
A cosa serve dunque il corso di laurea in fisica ? La cosa principale che gli studenti di fisica<br />
imparano é proprio il metodo della fisica, l’apprendimento del quale é in un certo senso ancora più<br />
importante della conoscenza delle leggi fisiche stesse. Il metodo fornisce, infatti, l’atteggiamento<br />
con cui il fisico si pone nello studio dei fenomeni naturali, costituisce un modo di indagine della<br />
realtà, un approccio ai problemi.<br />
Vediamo quali sono gli aspetti caratteristici di questo metodo. Nella storia del pensiero ci sono stati<br />
due atteggiamenti di fronte alla complessità della realtà fisica: (a) L’Empirismo (il cui metodo<br />
d’indagine caratteristico é detto induzione) e (b) il Razionalismo (per il quale si ha il metodo detto<br />
della deduzione). Per esemplificare questi 2 approcci prendiamo un esempio preso a prestito dalla<br />
vita quotidiana. Tutti noi scegliamo di comportarci in un certo modo in base alle informazioni che<br />
abbiamo. A che ora usciamo di casa la mattina per arrivare all’università’ prima delle 9 ? Lo<br />
studente 1 affronta il problema con il seguente approccio. Fa diverse prove: un giorno esce alle 7<br />
un giorno alle 7:30 poi alle 8 ed infine alle 8:30. Ripete in giorni diversi queste prove e alla fine<br />
osserva che se esce alle 7:30 impiega 15 minuti, se esce alle 8 impiega di più e così via. Da tali<br />
osservazioni “conclude” che l’orario migliore per uscire é uno dei tanti provati. Da ciò trae in<br />
definitiva la sua regola di comportamento. Lo studente 2 invece sulla base del fatto che le scuole<br />
aprono alle 8, gli uffici alle 9 “deduce” che é meglio uscire alle 7:30 (senza impiegare diverse<br />
settimane a fare delle prove). E’ chiaro che si tratta di un esempio di empirista (lo studente 1) e di<br />
razionalista (lo studente 2).<br />
Quale dei due approcci é quello proprio del metodo scientifico ?<br />
In realtà non lo é nessuno dei due, o meglio, lo scienziato usa ambedue i metodi, li combina.<br />
In questo consiste la sintesi propria del metodo scientifico, che si suole anche indicare come sintesi<br />
galileiana ricordando il nome di Galileo che fu il primo a formularne gli aspetti salienti nei suoi<br />
scritti: osservazione e teoria sono intimamente legate tra loro, in un certo senso “si guidano a<br />
vicenda”. Il metodo scientifico moderno nasce da questa sintesi. L’osservazione della natura non é<br />
un puro e semplice catalogare fatti o fenomeni (che é viceversa proprio dell’empirismo puro).<br />
Attraverso l’osservazione lo scienziato vuole in realtà cogliere il “meccanismo” che regola i<br />
fenomeni e pertanto tende a “selezionare” le osservazioni da fare e, al tempo stesso, tende ad<br />
“inventare un linguaggio” con il quale riesce a parlare in modo chiaro dei fenomeni naturali che<br />
osserva. La comprensione dei “meccanismi” della natura é infatti molto più potente della pura e<br />
semplice osservazione di come si svolgono le cose. Non solo, tale comprensione “spinge” ad altre<br />
osservazioni e pertanto la conoscenza che si acquisisce diventa la base per acquisizioni di<br />
conoscenze successive.<br />
5