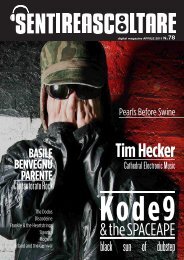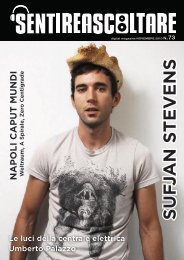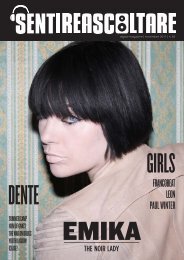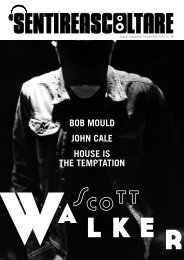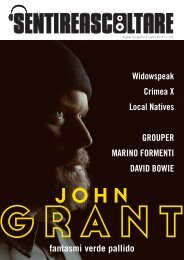RETROMANIA - Sentireascoltare
RETROMANIA - Sentireascoltare
RETROMANIA - Sentireascoltare
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CAMPI MAGNETICI #6<br />
Matia Bazar Pere Ubu<br />
tango (Emi, marzo 1983)<br />
Anni di piombo, creste selvagge e tossicità, i Settanta:<br />
i Matia Bazar - band fondata a Genova nel ‘75 sulle<br />
ceneri dei soft-prog Jet - invece a pasturare l’auditorio<br />
del belcanto, sfornando un hit dietro l’altro, da Stasera...<br />
che sera! a C’è tutto un mondo intorno, da Cavallo bianco<br />
a Solo tu, concedendosi persino la vittoria a Sanremo<br />
con la sdolcinatamente epica ...E dirsi ciao. Artefice<br />
principale quel Piero Cassano dal fiuto sensibilissimo<br />
per le melodie sbranaclassifiche. Il cui abbandono nel<br />
1981 coinciderà con l’ingresso in formazione di Mauro<br />
Sabbione, quindi di un rinnovato ordine di riferimenti,<br />
intenzioni e idee. Vedete un po’ voi: Cassano diverrà la<br />
penna dietro al fenomeno Eros Ramazzotti, per il quale<br />
comporrà i principali successi, mentre Sabbione si presenta<br />
dichiarando di ispirarsi a Kraftwerk, Ultravox e<br />
Joy Division tra gli altri.<br />
Questo dovrebbe spiegare più o meno tutto ciò che accadde<br />
di lì a poco. Ma c’è una continuità nella frattura.<br />
La svolta new wave di Berlino, Parigi, Londra (1982)<br />
cambia sì scenografie, ambiti, obiettivi, tuttavia resta la<br />
stessa progettualità di fondo: confezionare un pop di<br />
pura evasione che non rinunci al fascino della complessità,<br />
percorrere il riflusso culturale dei tardi Settanta/primi<br />
Ottanta col più arguto dei disimpegni, lasciando che<br />
nello stanzino del melodismo italiano spirassero brezze<br />
arty, avanguardie robotiche e rigurgiti d’ogni epoca e<br />
latitudine. Tango è in questo senso il loro capolavoro<br />
e un capolavoro del pop italiano di ogni tempo. E non<br />
avrebbe potuto esserlo senza la sua verifica nazionalpopolare.<br />
Intendo, ovviamente, Sanremo. Quello dell’83, vinto per<br />
intendersi da Tiziana “quarto d’ora di celebrità warholiana”<br />
Rivale. I cinque Matia Bazar si presentarono sul<br />
palco dell’Ariston come alieni azzimati sul ponte di una<br />
crociera post-moderna, come nostalgici ciber-manichini<br />
in fuga da un patinato altroquando di telefoni bianchi<br />
e daiquiri letterari, mossi da un’eleganza algida e sincopata<br />
al cospetto d’un computer perentorio. Probabilmente<br />
quelli di Vacanze Romane furono i due minuti e<br />
134<br />
mezzo - questa la durata massima consentita, il pezzo<br />
fu incautamente sfumato all’altezza del secondo chorus<br />
- più contemporanei della storia del festivalone. Era, ed<br />
è, una canzone formidabile, satura di fantasmi felliniani,<br />
riverberi operistici, cabaret sintetico e brezze latine (tra<br />
queste ultime la dichiarata devozione per Yma Sumac,<br />
straordinaria vocalist peruviana celeberrima nei Fifties).<br />
Pezzo che ancora oggi ammalia malgrado l’usura, accomodante<br />
senza pretenziosità eppure frutto di intrigante<br />
stratificazione: ovvero, il pedigree del pop migliore. Inevitabile<br />
sceglierlo ad inaugurare la scaletta composita<br />
di Tango, ricca di ammiccamenti Japan (Intellighenzia)<br />
e Ultravox (I bambini di poi), fregole Kate Bush strinite<br />
Yellow Magic Orchestra (Palestina), ma soprattutto di<br />
techno-pop dal tiro ibrido, balzano e inquietante come<br />
Elettrochoc e Il video sono io. Tutta roba che sorprese per<br />
la padronanza quasi irriverente, viatico per la definizione<br />
d’una calligrafia unica segnata dall’utilizzo disinvolto<br />
di espedienti, trovate testuali all’insegna d’un para-nonsense<br />
degno del Panella prossimo venturo (Tango nel<br />
fango) e - ovviamente - del soprano duttile ed enfatico<br />
però mai fuori luogo di Antonella Ruggiero.<br />
Una formula che non seppe ripetersi allo stesso livello<br />
nel pur buono Aristocratica (1984), dopo il quale<br />
Sabbione concluse la sua troppo breve avventura nella<br />
band. Che da allora non mancò di cogliere ulteriori successi,<br />
ma sempre più sulla scorta d’un passato - ahnoi,<br />
ahiloro - irripetibile.<br />
StEFano SolVEnti<br />
classic album<br />
thE modErn danCE (blanK, gEnnaio 1978)<br />
Quando si era ragazzini era normale leggere all’italiana<br />
quello strano insieme di lettere, Pere Ubu, un nome che<br />
suonava così bene eppure così maledettamente misterioso.<br />
In una parola: affascinante. Solo qualche anno<br />
più tardi sarebbe stato invece obbligatorio citare Alfred<br />
Jarry, francese di fine Ottocento autore di un teatro<br />
grottesco, a tratti anche brutale e osceno, che di fatto<br />
anticipava il surrealismo con questa strana cosa chiamata<br />
patafisica, “la scienza delle soluzioni immaginarie<br />
e delle regole che governano le eccezioni”, che aveva già<br />
stregato Robert Wyatt e i Soft Machine. Riascoltando a<br />
33 anni dall’uscita e a quasi 10 dal primo ascolto personale<br />
The Modern Dance però, tutti i fattori contestuali<br />
possibili (e attorno c’erano Television, Patti Smith, PiL,<br />
Joy Division, Pop Group, Gang of Four, Talking Heads,<br />
la No Wave) non superano mai il rango di indizi di una<br />
grandezza e di una irripetibilità che sono da cercare<br />
semplicemente in una ispirazione speciale.<br />
La danza moderna è un agitarsi scomposto, muoversi<br />
con l’eccitazione febbrile di chi sa di poter perdere tutto<br />
ma anche che questo tutto è niente. Il disco continua ed<br />
espande il mood apocalittico - fin dai titoli - inaugurato<br />
dai singoli 30 Seconds Over Tokyo (1975) e Final Solution<br />
(1976), con un concept paranoico dove la condizione<br />
post-industriale (gli Ubu nascono dalle ceneri dei Rocket<br />
from the Tombs, in quello stesso Ohio che sa poco<br />
di fattorie e tanto di ciminiere e fumi e che in parallelo<br />
darà i natali ai Devo) fa da cornice a storie d’amore tutte<br />
amare, deluse, concluse. Parable di una non più arable<br />
land, di una terra non più addomesticabile, desolata,<br />
sterile, fredda, indifferente, morta ammazzata. La danza<br />
moderna è un folk urbano messo ad essiccare under<br />
a big black sun (Over My Head è praticamente un desert<br />
western), è un punk-rock spigoloso e stilizzato, in bianco<br />
e nero, come la copertina: la batteria essenziale di Scott<br />
Krauss, il basso modellatore di Tony Maimone, le rasoiate<br />
synth di Allen Ravenstine, la chitarra-camaleonte<br />
di Tom Herman, che ora tratteggia con piccoli tocchi<br />
arpeggi sottili, ora innesca brucianti riff punk, ora take<br />
quasi-reggae alla Redondo Beach (Humor Me, che chiude<br />
beffarda, riuscendo nell’impresa di non lasciare l’amaro<br />
in bocca). Sopra tutto, ovviamente, la voce di David<br />
Thomas, figlio di un professore di letteratura inglese, un<br />
“ciccione che canta come un mingherlino”, dirà Stefano<br />
Tamburini/Red Vinyle in una intervista con Arto Lindsay,<br />
vocalist e lyricist delirante come sarà poi il Black<br />
Francis dei Pixies e come lui perfetta trasfigurazione<br />
musicale dell’ebete Eraserhead lynchiano, a chiudere<br />
una circolarità di ferino isterismo che ha nel Capitano il<br />
proprio capostipite e vate.<br />
Dalla sirena da evacuazione di Non-Alignment Pact, alle<br />
sfrangiature avant della intro fiatistica di Laughing, da<br />
quella Street Waves che è praticamente la versione postpunk<br />
del blues di Beefheart (il cui spirito aleggia nelle<br />
chitarre sghembe di tutti gli interludi strumentali dell’album)<br />
e di Electricity in particolare, alla teatralità espressionista<br />
di sceneggiate come Chinese Radiation, dall’inno<br />
“blank generation” Life Stinks (firmata dal primissimo<br />
chitarrista dei Pere, Peter Laughner, morto di eccessi a<br />
24 anni; per lui un toccante requiem scritto dall’amico<br />
Lester Bangs), alla marcia arrancante Real World, vicinissima<br />
ai pezzi più scuri e geometrici dei Devo di Are We<br />
Not Men . Giù giù e giù fino a quel Sentimental Journey<br />
che è un incubo claustrofobico tra Pierre Schaeffer,<br />
ovviamente Beefheart, gli Stooges di Fun House e i<br />
Residents. Senza mezzi termini, un capolavoro.<br />
Il percorso dei Pere Ubu sarà ancora splendido almeno<br />
per tutti i primi anni Ottanta e regalerà anche inattesi<br />
recenti colpi di coda. Quello del Thomas solista, sempre<br />
più o meno affiancato dai due fidi ragazzi pallidi Keith<br />
Moliné e Andy Diagram, discontinuo e irregolare, sospeso<br />
tra sperimentazioni vocali, teatro e ripetizione di<br />
sé; ma illuminato da lampi di vera ispirazione poetica<br />
e sempre rivolto alla caparbia esplorazione di luoghi<br />
immaginari - Erewhon, Spoon River contemporanea,<br />
non meno desolata dell’Ohio della gioventù - che sono<br />
specchi obliqui del reale.<br />
gabriElE marino<br />
135