Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Duccio <strong>di</strong> Buoninsegna, che collabora col maestro Cimabue a Firenze (Maestà Rucellai) e ad<br />
Assisi, ma opera soprattutto nella città natale (Maestà per l’altare maggiore del Duomo).<br />
[Artisti polivalenti. Giotto e gli inizi della pittura laica] I maggiori artisti riuniscono insieme,<br />
per altro, competenze <strong>di</strong>verse: <strong>di</strong> costruttori, scultori, pittori. È il caso <strong>di</strong> Bonanno (tra l’XI e il XII<br />
sec.), che progetta la torre <strong>di</strong> Pisa e lavora ai portali bronzei della cattedrale; <strong>di</strong> Benedetto<br />
Antelami (tra il XII e il XIII sec.), architetto e scultore nel duomo <strong>di</strong> Fidenza, nella chiesa <strong>di</strong><br />
Sant’Andrea a Vercelli e soprattutto in uno dei capolavori del gotico italiano, il battistero <strong>di</strong> Parma;<br />
<strong>di</strong> Arnolfo <strong>di</strong> Cambio (morto nel 1302), cui si attribuiscono i progetti <strong>di</strong> Santa Croce e Santa Maria<br />
del Fiore a Firenze (1295-96) e a cui si debbono alcuni tra i primi e più alti esempi <strong>di</strong> scultura<br />
profana: la statua <strong>di</strong> Carlo d’Angiò ora in Campidoglio e quella <strong>di</strong> Bonifacio VIII per il Duomo<br />
fiorentino; e infine e soprattutto <strong>di</strong> Giotto (1266-1337), il quale, oltre a progettare e avviare i lavori<br />
per il campanile <strong>di</strong> Santa Maria del Fiore, rivoluzionò la pittura <strong>italiana</strong> ed europea con il grande<br />
ciclo <strong>di</strong> affreschi per la Basilica <strong>di</strong> San Francesco ad Assisi e con quello altrettanto gran<strong>di</strong>oso per<br />
la cappella degli Scrovegni a Padova (1303-5). Con Giotto e i suoi successori, la pittura passa da<br />
uno sta<strong>di</strong>o primitivo, influenzato dai modelli bizantini (le tavole <strong>di</strong> questo periodo sono i cosiddetti<br />
fon<strong>di</strong> oro, perché le figure sacre, fortemente stilizzate, galleggiano su una superficie dorata che non<br />
dà alcuna impressione <strong>di</strong> realismo), ad una fase più matura: le vicende e i personaggi che troviamo<br />
negli affreschi assisiati e padovani ci appaiono reali, sentimentalmente veri, colti nella loro qualità<br />
in<strong>di</strong>viduali e non rappresi in tipi, così come accadeva nella tra<strong>di</strong>zione precedente. Questo sforzo <strong>di</strong><br />
realismo avrà tra i suoi effetti quello <strong>di</strong> aprire la strada ad un’arte non più legata soltanto ai temi<br />
biblici o all’agiografia ma aperta <strong>alla</strong> cronaca ‘laica’. Simone Martini (Siena 1284 – Avignone<br />
1344), allievo <strong>di</strong> Duccio, affianca alle pitture <strong>di</strong> soggetto tra<strong>di</strong>zionalmente religioso (affresco della<br />
Maestà nel Palazzo Pubblico <strong>di</strong> Siena, 1315), opere su soggetto ‘civile’ (San Ludovico da Tolosa<br />
incorona Roberto d’Angiò re <strong>di</strong> Napoli, 1317; il ritratto equestre <strong>di</strong> Guidoriccio da Fogliano, 1328).<br />
E <strong>alla</strong> fine degli anni Trenta del Trecento, Ambrogio Lorenzetti ci offre, nella Sala dei Nove del<br />
Palazzo Pubblico <strong>di</strong> Siena, il primo grande esempio <strong>di</strong> pittura politica della tra<strong>di</strong>zione <strong>italiana</strong>: gli<br />
affreschi con le Allegorie del buono e del cattivo governo.<br />
2. Le letterature straniere<br />
[L’epica in Francia] In Francia, già a partire dal X secolo si registra una larga produzione <strong>di</strong><br />
poesia in volgare <strong>di</strong> materia agiografica (in cui cioè si narrano e si esaltano le vite dei santi), spesso<br />
legata <strong>alla</strong> liturgia (come il Saint-Alexis, scritto nell’XI secolo in area normanna), o <strong>di</strong> materia<br />
epico-cavalleresca. Dal mito che avvolge la corte <strong>di</strong> Carlo Magno nascono attorno al Mille quelle<br />
leggende che danno lo spunto alle cosiddette chansons de geste (‘canzoni <strong>di</strong> gesta’). Si tratta <strong>di</strong><br />
lunghe narrazioni in versi in cui si magnificano le imprese <strong>di</strong> Carlo e dei suoi Pala<strong>di</strong>ni (i cavalieri<br />
della sua corte) nella lotta contro i Saraceni, i quali penetrando da sud attraverso la Spagna<br />
rappresentarono una costante minaccia per la cristianità. Il fondamento storico <strong>di</strong> questi racconti è<br />
dunque solido: i protagonisti sono spesso identificabili con personaggi della corte carolingia e gli<br />
episo<strong>di</strong> narrati, per quanto siano trasfigurati dall’invenzione poetica, s’ispirano in genere a fatti<br />
realmente avvenuti. Il connubio tra storia nazionale e invenzione dovette garantire a queste opere un<br />
largo successo: è probabile che le chansons – a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> generi quasi esclusivamente ‘cortesi’<br />
come la lirica e i romans – venissero lette sia nelle corti signorili sia nelle piazze delle città,<br />
destando l’interesse <strong>di</strong> un pubblico per così <strong>di</strong>re ‘trasversale’. Questa ampia circolazione rende<br />
anche ragione <strong>di</strong> una caratteristica peculiare <strong>di</strong> questi testi, cioè dell’abbondanza <strong>di</strong> varianti <strong>di</strong><br />
forma e <strong>di</strong> contenuto, dunque <strong>di</strong> vere e proprie versioni <strong>di</strong> una stessa chanson: segno del fatto che si<br />
trattava <strong>di</strong> opere per lo più recitate, e dunque più o meno ampiamente ritoccate a seconda della<br />
cultura dei giullari (gli anonimi cantori che eseguivano le chansons presso le corti e nelle città) e<br />
delle circostanze in cui avveniva la recita (durata della performance, composizione del pubblico,<br />
ecc.).<br />
13


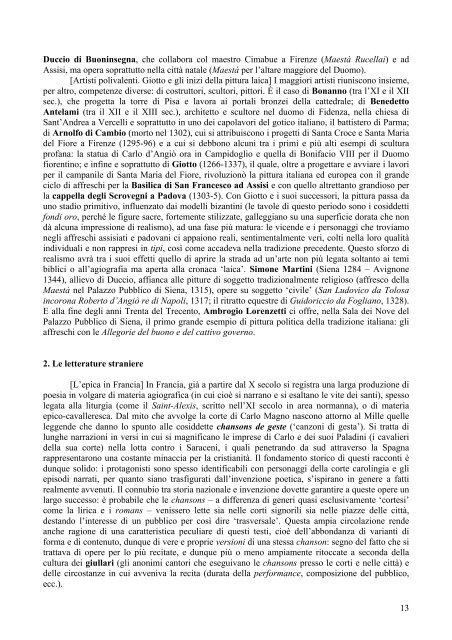






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
