Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
d<strong>alla</strong> vita popolare fiorentina. Di fatto, gran parte dei personaggi sacchettiani sono presi<br />
<strong>di</strong>rettamente d<strong>alla</strong> realtà, e citati per nome e cognome, così da dare luogo a una cronaca giocosa e<br />
pettegola piuttosto che a una vera e propria opera d’invenzione. Scrive infatti Sacchetti nella<br />
premessa al libro: «E perché molti [...] forse <strong>di</strong>ranno, come spesso si <strong>di</strong>ce: “Queste son favole”: a<br />
ciò rispondo che ce ne saranno forse alcune, ma nella verità mi sono ingegnato <strong>di</strong> comporle. Ben<br />
potrebbe essere, come spesso incontra [‘càpita’], che una novella sarà intitolata a Giovanni, e uno<br />
<strong>di</strong>rà: “ella intervenne a Piero”; questo sarebbe piccolo errore, ma non sarebbe che la novella non<br />
fosse stata».<br />
[Gli scrittori religiosi] Infine, una spinta decisiva a favore dell’uso del volgare venne dagli<br />
scrittori <strong>di</strong> religione. Non che il volgare venisse adoperato nella liturgia o nelle <strong>di</strong>scussioni<br />
teologiche, dove il latino regnerà ancora incontrastato; ma nella pre<strong>di</strong>cazione, nella preghiera, nei<br />
trattati spirituali la volontà <strong>di</strong> farsi comprendere da un pubblico più ampio <strong>di</strong> quello dei soli<br />
‘letterati’ porta gli autori ad adottare la lingua della comunicazione quoti<strong>di</strong>ana, oppure a<br />
volgarizzare scritti religiosi sino ad allora accessibili soltanto in latino: tipico il caso delle leggende<br />
legate <strong>alla</strong> figura <strong>di</strong> san Francesco. Anche in questo caso è la Toscana il centro del rinnovamento.<br />
Qui il domenicano Giordano da Pisa (prima metà del secolo) compone e pronuncia più <strong>di</strong><br />
settecento pre<strong>di</strong>che in volgare, rivolte non ai confratelli ma <strong>alla</strong> borghesia mercantile delle città, e<br />
perciò scritte nella sua lingua e su temi che più da vicino la riguardano: il lusso, i costumi delle<br />
donne, l’usura, la corruzione. E qui Domenico Cavalca, anch’egli pisano (1270-1342), svolge<br />
un’importante opera <strong>di</strong> volgarizzamento <strong>di</strong> trattati latini relativi <strong>alla</strong> <strong>di</strong>sciplina del buon cristiano e<br />
ai sacramenti: lo Specchio dei peccati, lo Specchio <strong>di</strong> croce, il Pungilingua. Qui, infine, il<br />
domenicano fiorentino Iacopo Passavanti (morto nel 1357) compone, oltre a vari sermoni latini, il<br />
trattato Specchio <strong>di</strong> vera penitenza, una (incompiuta) rassegna dei vizi e delle virtù scritta sul<br />
modello dei manuali de poenitentia ma, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> questi ultimi, a beneficio del pubblico ignaro<br />
<strong>di</strong> latino: il quale pubblico – ed è questo il fatto cruciale, destinato a sviluppi d’incalcolabile<br />
importanza nell’età della Riforma e dopo – entra così in contatto <strong>di</strong>rettamente, senza la me<strong>di</strong>azione<br />
dei sacerdoti, con testi <strong>di</strong> carattere religioso.<br />
4. Dante Alighieri<br />
4.1 La vita<br />
[La giovinezza] Dante nasce nel 1265 a Firenze. All'epoca, la città è il principale centro<br />
economico e finanziario della Toscana, ma è anche segnata <strong>dalle</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>e e <strong>dalle</strong> lotte tra le<br />
fazioni: così come altrove nel centro-nord della penisola <strong>italiana</strong>, i partigiani dell'Impero (ghibellini)<br />
e i partigiani del Papato (guelfi) si contendevano la supremazia, il che significava, <strong>di</strong> volta in volta,<br />
la strage e l'esilio della parte avversa. Dante appartiene a una famiglia della piccola nobiltà. Stu<strong>di</strong>a<br />
certamente a Firenze, nelle «scuole de li religiosi» (Convivio, II xii 7): ossia in quegli Stu<strong>di</strong>a<br />
ecclesiastici cui, a quel tempo, potevano accedere anche i laici. Integra questa istruzione ‘regolare’<br />
con la lettura dei filosofi antichi e col <strong>di</strong>alogo con gli intellettuali della sua generazione (come i<br />
poeti Cavalcanti e Cino da Pistoia) e <strong>di</strong> quella precedente: su tutti riconoscerà come maestro il poeta<br />
e retore Brunetto Latini.<br />
[Gli anni della maturità a Firenze] La superiore cultura e l'appartenenza a una famiglia non<br />
registrata tra quelle magnatizie (famiglie, queste ultime, cui per volontà del popolo minuto erano<br />
state precluse le cariche pubbliche) fanno sì che, a metà degli anni Novanta, Dante possa<br />
partecipare in prima persona al governo del Comune. Per Firenze, questo è un periodo<br />
particolarmente burrascoso a causa delle lotte tra le fazioni dei guelfi Bianchi - riuniti attorno <strong>alla</strong><br />
famiglia dei Cerchi - e dei guelfi Neri, che fanno capo <strong>alla</strong> famiglia Donati. Coi primi, <strong>di</strong>fensori del<br />
popolo minuto e delle magistrature citta<strong>di</strong>ne, si schiera Dante. All’inizio è uno fra i tanti, nelle<br />
assemblee che affiancano il Capitano del Popolo e i Priori; poi, crescendo il suo prestigio, riceve<br />
incarichi più importanti. Nel 1300 è eletto priore. Nel 1301 ha un compito molto delicato. Papa<br />
43


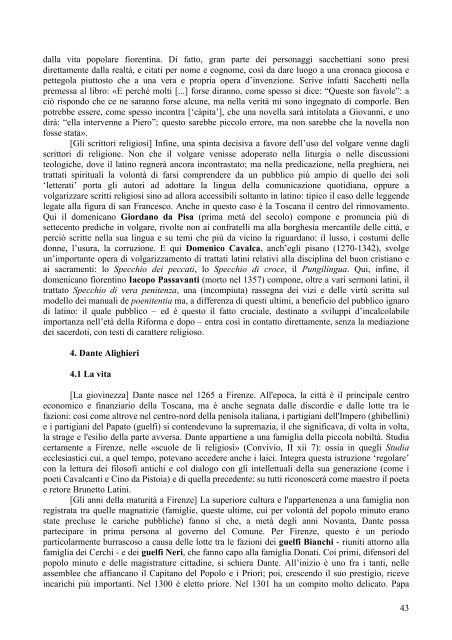






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
