Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
[Lo ‘scisma d’occidente’] Il ritorno del papato a Roma non avvenne senza proteste e<br />
<strong>di</strong>visioni. Già nel 1378 una parte del collegio dei car<strong>di</strong>nali tentò <strong>di</strong> riportare la sede ad Avignone.<br />
Ne nacque una frattura – detta scisma d’Occidente – che oppose all’interno della Chiesa due<br />
fazioni, una romana e l’altra francese e, per trent’anni, un papa eletto d<strong>alla</strong> prima ad un ‘antipapa’<br />
eletto d<strong>alla</strong> seconda. Lo scisma si ricomporrà soltanto nel 1417 con il concilio <strong>di</strong> Costanza e la<br />
nomina a pontefice – con sede a Roma – <strong>di</strong> Martino V.<br />
1.3 Le scienze e la tecnica<br />
[L’unità <strong>di</strong> teoria e prassi] A partire dall’XI secolo si assiste in Europa a uno straor<strong>di</strong>nario<br />
progresso nelle scienze e nelle arti applicate. Ciò è dovuto sia alle mutate con<strong>di</strong>zioni sociali –<br />
l’incremento della popolazione, le nuove esigenze imposte dall’intensificarsi dei commerci e<br />
dell’attività manifatturiera – sia <strong>alla</strong> progressiva acquisizione del pensiero scientifico greco e arabo.<br />
Il dato più caratteristico <strong>di</strong> questo periodo è l’unità fra scienza e tecnica: vale a <strong>di</strong>re che gli<br />
scienziati elaborano teorie ma non perdono mai <strong>di</strong> vista le loro possibili applicazioni concrete, e<br />
lavorano <strong>alla</strong> risoluzione <strong>di</strong> problemi pratici.<br />
[La matematica] Si prenda per esempio il caso della più pura delle scienze, la matematica. Il<br />
Liber embadorum (‘Libro delle aree’) del Savasorda, un ebreo vissuto tra Spagna e Provenza nella<br />
prima metà del sec. XII, affronta e risolve problemi relativi <strong>alla</strong> pratica mercantile e nautica. E il<br />
primo grande matematico italiano, il pisano Leonardo Fibonacci (inizio del sec. XIII) è lui stesso<br />
un mercante, che applica il suo ingegno a questioni relative al commercio. Nel Liber Abbaci (1202)<br />
introduce forse per primo in Europa le cifre arabe al posto <strong>di</strong> quelle romane; nella Practica<br />
Geometriae (1220), ispirata in parte all’opera del Savasorda, in parte a testi greci e arabi conosciuti<br />
durante i suoi viaggi d’affari nel Me<strong>di</strong>terraneo, Leonardo getta le fondamenta della trigonometria e<br />
applica per primo l’algebra <strong>alla</strong> risoluzione <strong>di</strong> problemi geometrici. Il genio matematico del<br />
Fibonacci non avrà rivali sino al Rinascimento. Sulla sua scia si muoveranno, ormai nell’età <strong>di</strong><br />
Dante, l’inglese Giovanni <strong>di</strong> Sacrobosco (autore del De arte numeran<strong>di</strong> e del De sphaera mun<strong>di</strong>) e<br />
soprattutto, in pieno Trecento, il francese Nicola Oresme, il quale nel Tractatus de latitu<strong>di</strong>nis<br />
formarum (1361) elaborerà una rappresentazione grafica delle funzioni matematiche attraverso assi<br />
perpen<strong>di</strong>colari che precorre la geometria cartesiana.<br />
[La produzione <strong>di</strong> energia] In altri settori della scienza, l’aspetto pratico prende decisamente<br />
il sopravvento su quello teorico. Non si scrivono trattati <strong>di</strong> chimica o <strong>di</strong> meccanica o <strong>di</strong> idraulica,<br />
ma ogni artigiano conosce, per averle apprese dal maestro, le tecniche necessarie <strong>alla</strong> produzione<br />
dei manufatti: è un sapere che si comunica attraverso la pratica, non attraverso un insegnamento<br />
formale simile a quello cui siamo abituati oggi. Di qui, per lo storico, una certa <strong>di</strong>fficoltà nel<br />
ricostruire con esattezza la mappa e la cronologia delle scoperte e delle invenzioni, per le quali<br />
occorre fidarsi della testimonianza, spesso imprecisa e lacunosa, dei cronachisti del tempo. Nel<br />
settore, allora come oggi cruciale, della produzione <strong>di</strong> energia due sono le innovazioni più notevoli<br />
che hanno luogo a partire dal sec. XII: la progressiva introduzione in Europa dei mulini a vento e<br />
l’impiego dell’energia idraulica non solo, come in passato, per la macina, ma anche per la<br />
conciatura, la filatura e le altre attività legate <strong>alla</strong> lavorazione dei tessuti. Nel secolo XIII, poi,<br />
l’energia idraulica inizierà ad essere usata anche nella metallurgia: negli altoforni, alimentati da<br />
grossi mantici, sarà possibile aumentare la temperatura <strong>di</strong> fusione e ottenere metalli più puri e più<br />
resistenti, e ciò avrà importanti ricadute sulla vita civile (perché il legno comincerà ad essere<br />
sostituito dal ferro, sino ad allora costosissimo, negli attrezzi agricoli) e su quella militare (perché le<br />
nuove tecniche rivoluzioneranno l’industria delle armi).<br />
[L’agricoltura: i prodotti e le tecniche] In un mondo ancora per gran<strong>di</strong>ssima parte conta<strong>di</strong>no,<br />
è chiaro che le innovazioni più importanti siano quelle relative alle tecniche agricole. Per quanto<br />
riguarda i prodotti, mentre restano vive le colture tra<strong>di</strong>zionali della vite e dell’olivo, gli arabi<br />
introducono in Italia, fra XIII e XIV secolo, la coltura degli agrumi e della canna da zucchero. Una<br />
vera e propria rivoluzione avviene però nel settore dei filati, che alimenteranno quella che durante<br />
7


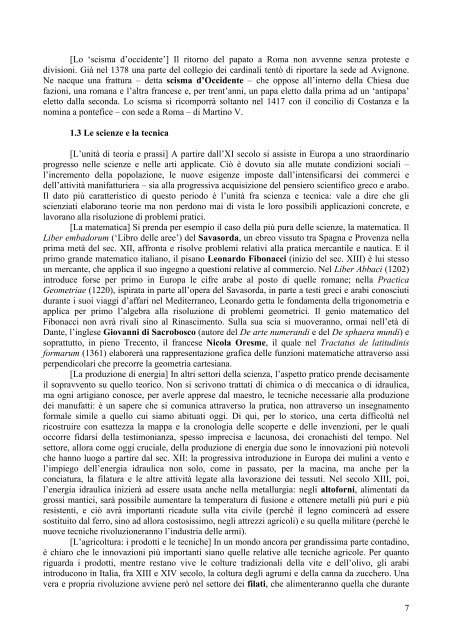






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
