Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
conoscenza del Me<strong>di</strong>oevo latino (Prudenzio e Clau<strong>di</strong>ano, ma soprattutto il De consolatione<br />
philosophiae <strong>di</strong> Boezio) sta del resto a fondamento della sua opera maggiore, il Libro de’ vizî e<br />
delle virtu<strong>di</strong>.<br />
[Il Libro de’ vizi e delle virtu<strong>di</strong>] Nei 76 capitoli del Libro s’intrecciano due storie esemplari.<br />
La prima corrisponde al viaggio - viaggio-visione simile a quello <strong>di</strong> Dante nella Comme<strong>di</strong>a - che il<br />
protagonista e autore del Libro compie per la propria salvezza spirituale. Caduto in uno stato <strong>di</strong><br />
sconforto e <strong>di</strong> prostrazione, Bono incontra la Filosofia, che lo consola per la per<strong>di</strong>ta dei beni<br />
materiali e lo esorta a intraprendere in sua compagnia il cammino verso la virtù. Una serie <strong>di</strong><br />
incontri e <strong>di</strong> colloqui - il primo con la Fede che lo interroga circa il Credo, i sacramenti, i peccati<br />
capitali, ecc., gli altri con le varie «Virtu<strong>di</strong>» che lo esaminano a loro volta - porta Bono ad essere<br />
ammesso, nell’ultimo paragrafo, tra i fedeli delle Virtù: «E dacché m’ebbero benedetto e segnato e<br />
ricevuto per fedele, scrissero BONO GIAMBONI nella matricola loro, secondo che la Filosofia <strong>di</strong>sse<br />
ch’io era chiamato». Circa <strong>alla</strong> metà del suo viaggio il protagonista assiste ad un grande spettacolo<br />
esemplare. Radunata in un’immensa pianura, «tutta la gente del mondo» combatte <strong>di</strong>visa in due<br />
fazioni contrapposte, chi per le Virtù chi per i Vizi (capitanati da Superbia). Presto la visione, da<br />
allegorica che era, <strong>di</strong>venta storica, e la cornice della battaglia fornisce al narratore il pretesto per un<br />
lungo excursus sulla storia del mondo e della cristianità, d<strong>alla</strong> creazione al peccato originale e d<strong>alla</strong><br />
fondazione della Chiesa <strong>alla</strong> lotta contro le eresie. La lotta (e la visione) si chiude con la vittoria<br />
delle Virtù e della vera religione; ma è una vittoria parziale, dal momento che rimane aperto il<br />
conflitto tra il cattolicesimo e l’ultima e più insi<strong>di</strong>osa delle eresie ‘partorite da Satana’, l’Islam.<br />
[Le lettere <strong>di</strong> Guittone d’Arezzo] Rispetto all’opera del Giamboni, l’epistolario <strong>di</strong> Guittone<br />
d’Arezzo (cfr. § 3.2) offre un modello tutto <strong>di</strong>verso <strong>di</strong> ammaestramento morale. Lo stile irruento, la<br />
ricchezza <strong>di</strong> esclamazioni e <strong>di</strong> interrogative retoriche, tipiche della pre<strong>di</strong>cazione e dell’oratoria,<br />
sono lo strumento <strong>di</strong> una morale ‘militante’ perfettamente inquadrabile in quello che abbiamo visto<br />
essere il secondo tempo della carriera poetica <strong>di</strong> Guittone: l’opera del convertito. Come spesso le<br />
canzoni, le lettere si in<strong>di</strong>rizzano a singoli destinatari - confratelli, amici, uomini investiti <strong>di</strong><br />
responsabilità civili o politiche - per confermarli sulla strada del bene o per <strong>di</strong>stoglierli dal vizio.<br />
Nate dunque come forma <strong>di</strong> comunicazione privata, esse vennero presto raccolte dall’autore o dai<br />
suoi <strong>di</strong>scepoli a formare un epistolario organico per l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> tutti. Le 34 lettere che ci<br />
rimangono (certo una scelta da un corpus più ampio), come rispecchiano la forza polemica del<br />
Guittone poeta, così ne ripetono lo stile spesso oscuro e contorto, gonfio <strong>di</strong> latinismi, costrutti<br />
poetici e, soprattutto, <strong>di</strong> citazioni <strong>dalle</strong> ‘autorità’ (i classici latini e gli autori cristiani) tanto<br />
numerose da rendere più <strong>di</strong> una lettera una semplice collezione <strong>di</strong> sententiae a tema. E come il<br />
poeta, così il prosatore dovrà a questo gusto per gli artifici formali lo scarso successo incontrato<br />
nella tra<strong>di</strong>zione <strong>italiana</strong> già a partire dal Trecento.<br />
[Brunetto Latini. La vita] Nella storia della letteratura <strong>italiana</strong> delle origini Brunetto Latini<br />
occupa una posizione <strong>di</strong> grande rilievo. È poeta lirico, <strong>di</strong>dattico (col Tesoretto), traduttore dal latino<br />
e trattatista: insomma raduna in sé competenze <strong>di</strong>sparate che ne fanno il primo intellettuale italiano<br />
davvero polivalente, quelle stesse competenze che ritroveremo, potenziate, nel suo <strong>di</strong>scepolo e<br />
amico Dante Alighieri. E come e più <strong>di</strong> Dante, Brunetto fu coinvolto nella vita politica e civile del<br />
suo tempo. Fiorentino <strong>di</strong> nascita, è sindaco <strong>di</strong> Montevarchi nel 1260, quin<strong>di</strong> ambasciatore del<br />
comune <strong>di</strong> Firenze presso Alfonso il Saggio <strong>di</strong> Castiglia. Esule per cinque anni in Francia in seguito<br />
<strong>alla</strong> vittoria dei ghibellini, rientra nella città natale nel 1266 e qui ricopre varie cariche, da<br />
cancelliere a priore, sino <strong>alla</strong> <strong>morte</strong>, nel 1294.<br />
[Il volgarizzamento della Rhetorica ad Herennium] Benché abbia luogo negli anni<br />
dell’esilio francese, proprio al suo impegno civile dev’essere collegata l’opera del traduttore. Il<br />
volgarizzamento del De inventione (‘Sull’invenzione’) ciceroniano (la cosiddetta Rhetorica vetus<br />
[‘Vecchia retorica’], la nova essendo la cosiddetta Rhetorica ad Herennium [‘Retorica a Erennio’],<br />
falsamente attribuita a Cicerone) si accompagna infatti ad un fitto commento che reinterpreta a<br />
beneficio del ‘reggitore’, cioè <strong>di</strong> colui che porta la responsabilità politica, le norme retoriche che<br />
nell’originale latino erano prescritte all’oratore: uscita <strong>dalle</strong> aule del tribunale, la retorica viene<br />
35


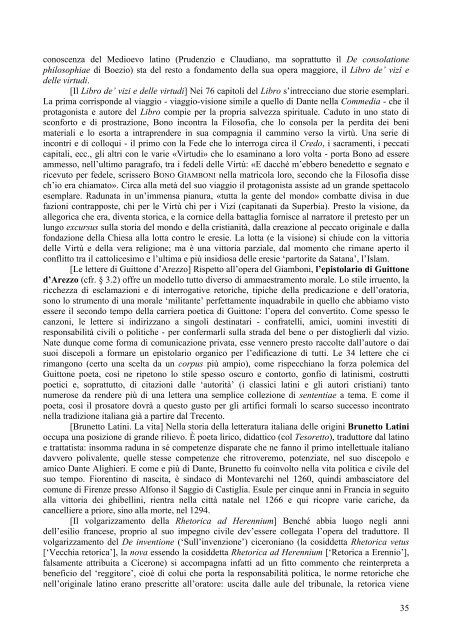






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
