Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
poteva così accostarsi <strong>di</strong>rettamente ai testi omerici originali,, che cita infatti orgogliosamente nelle<br />
Genealogie. Negli ultimi due libri, Boccaccio svolge un’appassionata <strong>di</strong>fesa della poesia: laddove,<br />
egli sostiene, gli stu<strong>di</strong> ‘positivi’ come il <strong>di</strong>ritto o la me<strong>di</strong>cina sono in<strong>di</strong>rizzati al guadagno, e non<br />
hanno come fine primario il progresso umano, la poesia dev’essere piuttosto assimilata <strong>alla</strong> filosofia<br />
e <strong>alla</strong> teologia: come queste ultime, essa non ha come fine l’arricchimento ma il progresso delle<br />
conoscenze e il miglioramento dei costumi. L’obiezione, che <strong>alla</strong> poesia viene mossa, secondo cui<br />
si tratterebbe soltanto <strong>di</strong> fabulae (‘favole, storie inventate’) è, osserva Boccaccio, legittima, ma<br />
facilmente confutabile: poiché la vera scienza consiste nel saper vedere sotto il velo della favola,<br />
dell’allegoria, il contenuto <strong>di</strong> verità che la poesia racchiude.<br />
[Le biografie] Mentre le Genealogie illustrano la forte motivazione umanistica <strong>di</strong> Boccaccio,<br />
il De casibus virorum illustrium (‘Sventure <strong>di</strong> uomini illustri’) e il De mulieribus claris (‘Le donne<br />
famose’) sono due opere <strong>di</strong> carattere più tra<strong>di</strong>zionalmente moralistico-eru<strong>di</strong>to. La prima, offerta al<br />
fiorentino Mainardo Cavalcanti, e ultimata attorno al 1360, è una rassegna, da Adamo ai<br />
contemporanei, <strong>di</strong> personaggi celebri caduti in <strong>di</strong>sgrazia; la seconda (1361), offerta <strong>alla</strong> nobildonna<br />
Andreina Acciaioli, è una raccolta <strong>di</strong> circa cento ritratti <strong>di</strong> eroine, d<strong>alla</strong> leggendaria Elena a<br />
Giovanna regina <strong>di</strong> Napoli. Il piacere del raccontare, così caratteristico del Decameron e delle altre<br />
opere volgari, è, in questi due trattati, del tutto abbandonato: non si tratta veramente <strong>di</strong> ‘storie’,<br />
liberamente narrate, bensì <strong>di</strong> esempi che l’autore illustra moralisticamente – con apostrofi, invettive,<br />
esortazioni – ai suoi destinatari.<br />
[Il Corbaccio] La satira anti-femminile (ovvero, con termine derivato dal greco, misogina), è<br />
un tema caratteristico della letteratura me<strong>di</strong>evale: ‘manuali’ che insegnano a resistere alle tentazioni<br />
delle donne, o che ne svelano gli inganni e i <strong>di</strong>fetti, sono ben <strong>di</strong>ffusi nel mondo romanzo, e<br />
Boccaccio paga il suo tributo a questa tra<strong>di</strong>zione nel racconto intitolato Corbaccio (forse dal nome<br />
<strong>di</strong> quello che era ritenuto il più vile degli uccelli), databile probabilmente al 1365. L’autore – questa<br />
la semplice trama del libro – ama una vedova che non lo corrisponde. Fa un sogno: in una valle,<br />
incontra il defunto marito della donna amata, che lo ammonisce: l’amore – egli sostiene - non fa per<br />
lui, e la donna che ha scelto è ricolma <strong>di</strong> tutti i vizi e i <strong>di</strong>fetti del suo sesso. U<strong>di</strong>to l’elenco <strong>di</strong> questi<br />
vizi e <strong>di</strong>fetti, l’autore-protagonista rimane convinto e, guarito d<strong>alla</strong> sua infatuazione, esce d<strong>alla</strong><br />
valle. Ispirato <strong>alla</strong> vasta tra<strong>di</strong>zione misogina suddetta, e in particolare al De vetula (‘La vecchia’),<br />
uno scritto latino falsamente attribuito a Ovi<strong>di</strong>o, il Corbaccio rappresenta - col suo <strong>di</strong>sincantato<br />
realismo, con la crudezza <strong>di</strong> certe descrizioni relative <strong>alla</strong> sfera corporea e sessuale - una specie <strong>di</strong><br />
controcanto al quasi contemporaneo trattato latino De mulieribus claris, che Boccaccio scrive<br />
invece «in eximiam muliebris sexus laudem» (‘in alta lode del sesso femminile’).<br />
[La fortuna] Nella canzone in cui piange la <strong>morte</strong> <strong>di</strong> Boccaccio, Franco Sacchetti non<br />
menziona neppure il Decameron: lo scrittore è ricordato, e <strong>di</strong>chiarato grande, soltanto in virtù delle<br />
opere latine. Questo silenzio è in contrad<strong>di</strong>zione con l’amplissimo successo <strong>di</strong> cui il Decameron<br />
godette già mentre Boccaccio era in vita. Libro veramente ‘popolare’, perché narra <strong>di</strong> una realtà<br />
vicina all’esperienza <strong>di</strong> ogni potenziale lettore, esso raggiunse anche i lettori meno colti: molte delle<br />
sue novelle e dei suoi personaggi <strong>di</strong>ventarono proverbiali; e ‘copisti per passione’ (cioè non scribi<br />
professionisti ma semplici amanti della letteratura) lo sottoposero a vere e proprie riscritture,<br />
‘aggiornando’, cioè avvicinando <strong>alla</strong> propria sfera d’esperienza, i nomi dei luoghi e dei personaggi.<br />
Come nessun’altra opera del Me<strong>di</strong>oevo, inoltre, il Decameron conobbe un imme<strong>di</strong>ato successo<br />
all’estero: lo tradussero e imitarono Chaucer in Inghilterra, Christine de Pizan in Francia, Juan de<br />
Mena in Spagna; e piacque anche a un umanista raffinato come Petrarca, che ad<strong>di</strong>rittura tradusse in<br />
latino la novella <strong>di</strong> Griselda (X 10). Ma il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Sacchetti prefigura quello degli umanisti<br />
quattrocenteschi, i quali si <strong>di</strong>sinteressano della letteratura volgare e fermano invece la loro<br />
attenzione sulle gran<strong>di</strong> compilazioni eru<strong>di</strong>te degli anni della maturità <strong>di</strong> Boccaccio: le Genealogiae<br />
deorum gentilium, il De mulieribus claris, ecc. La ripresa d’interesse per le novelle del Decameron<br />
ha luogo prima, sullo scorcio del Quattroocento, all’interno del circolo <strong>di</strong> Lorenzo il Magnifico e <strong>di</strong><br />
Poliziano, poi con Pietro Bembo, il quale nelle Prose della volgar lingua (1525) in<strong>di</strong>ca nel volgare<br />
<strong>di</strong> Boccaccio il modello che ogni prosatore italiano dovrebbe sforzarsi <strong>di</strong> imitare. Questo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />
69


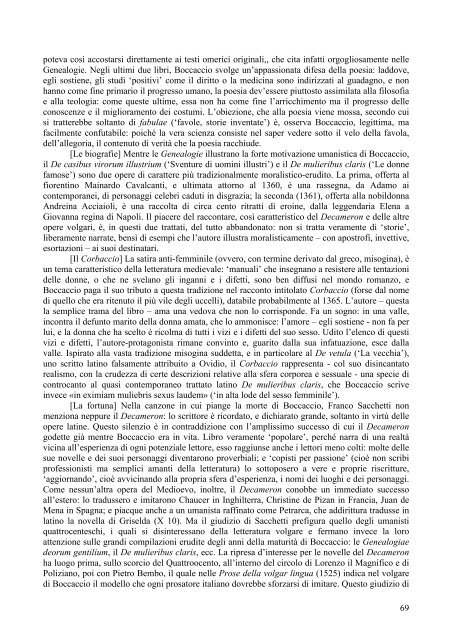






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
