Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>di</strong> virtù e <strong>di</strong> comportamento cristiano. Nelle novelle più estese, questa significazione morale viene<br />
resa esplicita per due volte dal narratore, il quale prende <strong>di</strong>rettamente la parola sia in avvio <strong>di</strong><br />
racconto, per istradare il lettore <strong>alla</strong> giusta comprensione del testo (queste righe iniziali vengono<br />
designate come «prologo» nella nov. XIV, ed assolvono dunque la funzione <strong>di</strong> micro-cornice, ossia<br />
<strong>di</strong> legante tra i vari racconti), sia in coda, per mettere in chiaro il significato esemplare della novella.<br />
[I Conti <strong>di</strong> antichi cavalieri] Databile all’ultimo trentennio del secolo e localizzabile nella<br />
Toscana orientale (forse ad Arezzo) è un’altra breve silloge <strong>di</strong> racconti messa insieme, come i Conti<br />
senesi, non per <strong>di</strong>letto bensì per utilità pratica ma, <strong>di</strong>versamente da quelli, senza implicazioni <strong>di</strong> tipo<br />
religioso. I Conti <strong>di</strong> antichi cavalieri si propongono infatti <strong>di</strong> far conoscere «detti saggi e belli e <strong>di</strong><br />
gran sentimento a·cciò che sempre inviamento bono ne possa avere e·ppigliare ciascuno cui<br />
governa». In altri termini, gli exempla qui raccolti e romanzati rielaborando principalmente il Liber<br />
Ystoriarum Romanorum non hanno un generico intento <strong>di</strong>dattico bensì una precisa funzione <strong>di</strong><br />
ammaestramento e ‘moralizzazione’ dei reggitori dello stato: onde la scelta, come protagonisti, <strong>di</strong><br />
cavalieri (cioè equites, nobili) dell’età greco-romana che, in quanto eterni modelli <strong>di</strong> virtù, possono<br />
affascinare e convincere uomini <strong>di</strong> ogni parte politica. In coerenza con l’intento dell’opera, che è<br />
quello <strong>di</strong> istruire i governanti del Comune, è costante in tutte le novelle <strong>di</strong> ambientazione greca o<br />
romana l’interesse per le virtù politico-militari, mentre poco spazio viene concesso ai valori della<br />
saggezza e della temperanza, preminenti invece nelle altre raccolte <strong>di</strong> novelle contemporanee.<br />
[I Fiori e vita <strong>di</strong> filosafi e d’altri savi e d’imperadori] Probabile fonte dei Conti appena citati<br />
e, forse, del Novellino, è la raccolta nota come Fiori e vita <strong>di</strong> filosafi e d’altri savi e d’imperadori,<br />
databile agli anni Settanta del Duecento. L’opera, che traduce, riducendo e rimaneggiando a sua<br />
volta, un compen<strong>di</strong>o dello Speculum historiale <strong>di</strong> Vincenzo <strong>di</strong> Beauvais, conobbe un’eccezionale<br />
fortuna nel Me<strong>di</strong>oevo per essere un comodo repertorio <strong>di</strong> aneddoti sulla vita degli antichi filosofi e<br />
degli eroi romani e, insieme, una collezione <strong>di</strong> sentenze riciclabili in ogni occasione: il titolo<br />
rispecchia appunto questa «giustapposizione <strong>di</strong> una parte aneddotica (vita) e <strong>di</strong> una antologicasentenziosa<br />
(fiori)» (D’Agostino). Le due classi <strong>di</strong> personaggi presentate come esemplari (savi e<br />
filosofi come Pitagora, Socrate, Platone, eroi romani come Valerio, Bruto, Torquato, apprezzati per<br />
le loro virtù morali e non più - come nei Conti <strong>di</strong> antichi cavalieri - per le imprese guerresche) sono<br />
considerati insieme, su un identico piano, per aver <strong>di</strong>mostrato saggezza nella loro condotta o nei<br />
loro scritti: anche personaggi noti per altri meriti (meriti letterari nel caso <strong>di</strong> Plauto o <strong>di</strong> Stazio)<br />
interessano qui solo come ‘savi’ produttori <strong>di</strong> sentenze <strong>di</strong> facile riuso. Naturale quin<strong>di</strong> che le due<br />
sezioni delle ‘novelle’ abbiano ampiezza e rilievo <strong>di</strong>seguali. Vale a <strong>di</strong>re che la parte biografica è<br />
ridotta all’osso («Epicurio fue uno filosafo, che non seppe lettera, né non seppe <strong>di</strong>sputare»: seguono<br />
citazioni d<strong>alla</strong> sua opera), o si fonda su aneddoti inverificati scelti per le loro applicazioni morali,<br />
mentre tutto l’interesse si rivolge ai detti memorabili: i lunghissimi profili <strong>di</strong> Cicerone e <strong>di</strong> Seneca<br />
sono <strong>di</strong> fatto composti quasi per intero da stralci delle loro opere, sicché la biografia romanzata si<br />
trasforma in antologia.<br />
[Il «Novellino». Struttura] Il Novellino è la raccolta <strong>di</strong> brevi racconti che, composta<br />
nell’ultimo ventennio del secolo, getta le basi della nostra prosa narrativa. È dubbio se la sua<br />
struttura e la consistenza attuale (cento novelle) risalgano <strong>alla</strong> stesura originale o se siano invece il<br />
frutto <strong>di</strong> una selezione più tarda operata da chi volesse dare al Decameron boccacciano il contraltare<br />
<strong>di</strong> «Cento novelle antiche» (titolo della prima e<strong>di</strong>zione cinquecentesca, che presuppone appunto il<br />
ricordo dell’opera più recente e più celebre): il più antico tra i manoscritti che ci hanno conservato il<br />
Novellino aggiunge infatti alle cento della vulgata varie altre novelle, le une tratte pari pari da<br />
raccolte contemporanee come il Fiore <strong>di</strong> filosafi, originali le altre. Come che stiano esattamente le<br />
cose, certo è che il Novellino presenta, se non una vera e propria architettura narrativa da<br />
‘macrotesto’, un principio <strong>di</strong> strutturazione interna, o meglio una varietà <strong>di</strong> princìpi: novelle<br />
unificate da un tema comune (per esempio la saggezza, nella prima decina), o dall’ambientazione (il<br />
mondo classico, nelle novelle 66-72), o dall’identità del protagonista (le novelle ‘federiciane’ 21-<br />
39


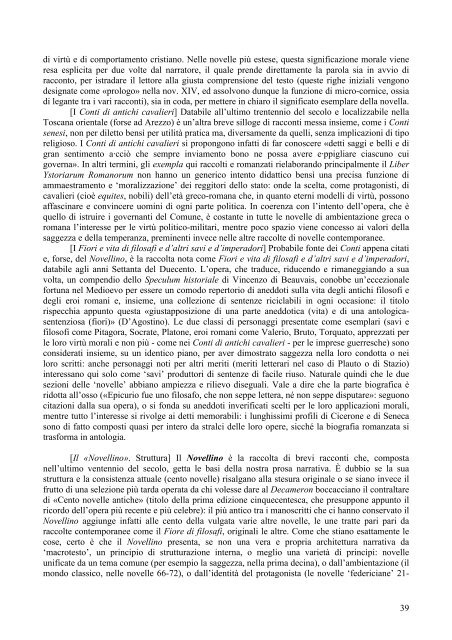






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
