Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
morale a sfondo cristiano, ciascuno nel suo volgare nativo: i più importanti sono il veronese<br />
Giacomino, il milanese Bonvesin da la Riva e il cosiddetto Anonimo Genovese.<br />
[La poesia della ‘scuola siciliana’. La lingua dei poeti ‘federiciani’] Un consistente gruppo<br />
<strong>di</strong> poeti in volgare si raccoglie attorno <strong>alla</strong> corte dell’imperatore Federico II, probabilmente nel<br />
terzo decennio del XIII secolo. Sono per lo più siciliani ma, dato che si tratta <strong>di</strong> una corte itinerante,<br />
anche pugliesi, calabresi, campani, laziali; sono notai, cancellieri, funzionari <strong>di</strong> vario rango. La<br />
lingua in cui la maggior parte <strong>di</strong> loro scrive dev’essere un siciliano ‘illustre’ depurato dei tratti<br />
<strong>di</strong>alettali più marcati e ricco <strong>di</strong> latinismi e provenzalismi: <strong>di</strong>versa, quin<strong>di</strong>, più raffinata e colta<br />
rispetto al siciliano «quod pro<strong>di</strong>t a terrigenis me<strong>di</strong>ocribus» (‘come suona in bocca ai nativi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a<br />
estrazione’) condannato da Dante nel De vulgari eloquentia (I xii 6) come i<strong>di</strong>oma rozzo e inadatto<br />
<strong>alla</strong> letteratura. Lo stesso selezionatissimo repertorio lessicale adoperato dai lirici siciliani, e lo<br />
stretto legame con i modelli trovabadorici, allontanava del resto questa poesia dal registro<br />
quoti<strong>di</strong>ano e realistico, che avrebbe richiesto un’aderenza maggiore al <strong>di</strong>aletto, e spingeva invece<br />
gli autori a confrontarsi con le lingue della tra<strong>di</strong>zione colta, quelle che erano state usate nei testi<br />
letterari cui si ispiravano i loro propri esperimenti <strong>di</strong> poesia: il latino e il provenzale, appunto.<br />
[Una poesia monotematica: l’amore] La poesia dei siciliani (termine che va inteso, si ba<strong>di</strong><br />
bene, in senso culturale e non geografico: ‘siciliani’ si <strong>di</strong>cono per convenzione tutti gli autori che<br />
mostrano <strong>di</strong> essere in contatto con la corte <strong>di</strong> Federico II) è quasi esclusivamente poesia d’amore. I<br />
rari testi d’argomento morale sono opera degli autori più tar<strong>di</strong> della ‘scuola’, quelli che<br />
probabilmente vennero a contatto con la poesia toscana; e sono testi <strong>di</strong> scarso impegno e <strong>di</strong> ridotta<br />
estensione: sonetti, mai canzoni. Il tema politico, già vivissimo fra i trovatori, è del tutto assente dal<br />
canone. Tale scelta tematica ha probabilmente motivazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne linguistico e stilistico: sia che<br />
il volgare, lingua della comunicazione privata, non ufficiale, venisse ritenuto inadatto ad esprimere<br />
contenuti <strong>di</strong> rilievo pubblico; sia che il tema squisito ed eterno dell’amore avesse agli occhi dei<br />
funzionari-poeti della cerchia <strong>di</strong> Federico un prestigio particolare, analogamente a ciò che avverrà<br />
mezzo secolo dopo con i cosiddetti stilnovisti.<br />
[Caratteri della poesia siciliana] Anche parlando d’amore, tuttavia, i poeti siciliani<br />
manifestano una volontà <strong>di</strong> chiusura e isolamento rispetto al contesto storico-sociale. Nelle loro<br />
canzoni manca regolarmente la tornata, cioè quella stanza <strong>di</strong> congedo che nelle canzoni provenzali<br />
e poi in quelle toscane serve a in<strong>di</strong>rizzare il testo all’amata, o a un destinatario in<strong>di</strong>viduato, o al<br />
pubblico dei lettori. Rarissime sono le tenzoni, cioè quegli scambi <strong>di</strong> sonetti o canzoni che<br />
formeranno invece il tessuto connettivo della società letteraria <strong>italiana</strong> nel secondo Duecento e nel<br />
Trecento. Quanto al contenuto dei testi, in essi vi è una quasi totale assenza <strong>di</strong> eventi, siano essi<br />
traumatici o liberatori, ciò che fa sì che il poeta-amante ci appaia prigioniero <strong>di</strong> un eterno presente<br />
<strong>di</strong> dolore e <strong>di</strong> aspettazione (occorrerà attendere Dante perché la <strong>di</strong>mensione della memoria venga<br />
finalmente riven<strong>di</strong>cata <strong>alla</strong> poesia). Infine, il poeta-amante osserva scrupolosamente il precetto<br />
trobadorico del celar (‘nascondere’, in provenzale) della salvaguar<strong>di</strong>a del proprio amore e del buon<br />
nome della donna attraverso il silenzio per timore dei ‘malparlieri’: il lettore ignora in pratica tutti i<br />
dettagli della ‘storia’. Queste caratteristiche fanno della poesia dei siciliani un’esperienza puramente<br />
privata che non sembra aver bisogno né <strong>di</strong> un pubblico (la corte, il ceto nobiliare o alto-borghese<br />
che pure dovette essere il primo consumatore <strong>di</strong> queste liriche) né, almeno in apparenza, <strong>di</strong> un<br />
confronto con gli altri rimatori.<br />
[La metrica] Nel settore della metrica, il modello trobadorico è accolto in maniera selettiva.<br />
Non vengono recepite né le forme della poesia colloquiale o invettiva come il partimen e la cobla<br />
esparsa, che godranno <strong>di</strong> una pur limitata fortuna tra i toscani, né le forme della poesia per musica<br />
come la dansa (i siciliani non conoscono la b<strong>alla</strong>ta, che è invenzione <strong>di</strong> poeti centro-italiani), né<br />
infine - lasciando l’àmbito strettamente metrico - i cosiddetti generi tematici come la pastorella,<br />
l’enueg o il plazer. Prende corpo invece un canone tripartito nel quale la canzone occupa <strong>di</strong> gran<br />
lunga il posto più importante e fanno qualche rara apparizione il <strong>di</strong>scordo (sorta <strong>di</strong> lunga canzone in<br />
versicoli fittamente rimati e schema metrico irregolare) e il sonetto. Mentre il <strong>di</strong>scordo, frequentato<br />
19


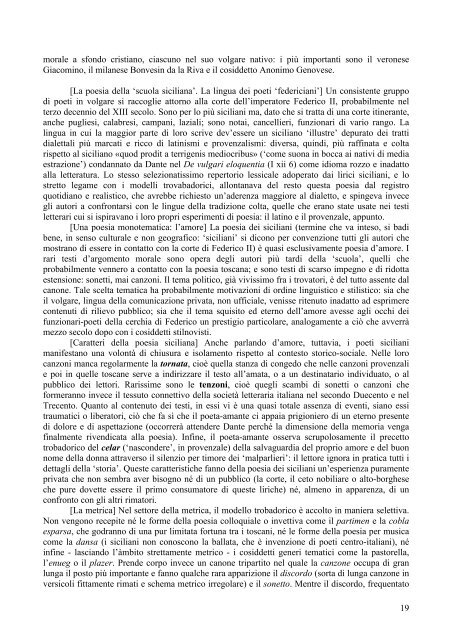






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
