Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
[Linee evolutive della poesia nel Trecento. I due filoni principali: lirica e narrativa in versi]<br />
La poesia trecentesca può essere <strong>di</strong>stinta in due filoni principali:quello lirico e quello allegoriconarrativo.<br />
Il primo riprende e sviluppa il modello proposto dai gran<strong>di</strong> poeti toscani dell’ultimo<br />
quarto del Duecento: Cino, Cavalcanti, Dante. Il secondo segue la strada aperta d<strong>alla</strong> Comme<strong>di</strong>a: la<br />
rappresentazione oggettiva, in versi, <strong>di</strong> contenuti morali, filosofici, dottrinali.<br />
[La lirica: d<strong>alla</strong> Toscana al Veneto] La tra<strong>di</strong>zione lirica si spegne quasi del tutto, in Toscana,<br />
dopo la generazione stilnovista: anticipando quella che sarà una delle tendenze dominanti del<br />
secolo, i ‘minori’ vissuti all’ombra <strong>di</strong> Petrarca e Boccaccio si orientano, piuttosto che verso la<br />
poesia d’amore, verso un tipo <strong>di</strong> lirica <strong>di</strong>dattico-morale <strong>di</strong> scarso impegno formale e ideologico.<br />
Solo nella seconda metà del secolo, dopo Petrarca, poeti fiorentini come Alberto degli Albizi e Cino<br />
Rinuccini vorranno tornare all’ortodossia ‘cortese’: e comporranno esclusivamente liriche d’amore<br />
attingendo insieme al repertorio dello stilnuovo e <strong>alla</strong> nuova maniera petrarchesca. Il terreno per la<br />
poesia è più fertile in Veneto. Qui, in seguito alle faide tra guelfi e ghibellini, si trasferiscono molti<br />
intellettuali toscani: e vi soggiornano prima Dante (anni Dieci) poi Petrarca (anni Cinquanta e<br />
Sessanta), ciascuno raccogliendo attorno a sé un gruppo <strong>di</strong> ammiratori e imitatori. Il trevigiano<br />
Nicolò de’ Rossi (1290-post 1348) è il primo a riprendere in maniera consapevole la lezione<br />
stilnovista de<strong>di</strong>cando a una donna chiamata col senhal <strong>di</strong> Floruzza alcune centinaia <strong>di</strong> sonetti e<br />
quattro canzoni, una delle quali scritta a imitazione della canzone filosofica cavalcantiana Donna<br />
me prega.<br />
[Il nuovo ruolo sociale del poeta] Nel corso del secolo, la crisi delle istituzioni comunali e<br />
l’affermazione delle corti signorili ha riflessi importanti anche sull’attività artistica. Gli intellettuali<br />
che un tempo occupavano i posti più importanti nelle magistrature citta<strong>di</strong>ne (si pensi a Brunetto<br />
Latini, o allo stesso Dante) ora vengono arruolati nelle corti per svolgere il ruolo <strong>di</strong> epistolografi o<br />
cancellieri, o <strong>di</strong> poeti al servizio del signore: Dante e Petrarca svolgeranno talvolta questa mansione<br />
(per esempio rispondendo a sonetti inviati ai prìncipi da altri poeti: Dante per i Malaspina, Petrarca<br />
per i Colonna), ma molti autori ‘minori’ loro contemporanei ne fecero una vera e propria<br />
professione, e passarono la loro vita viaggiando tra le corti del nord Italia: è il caso del toscano<br />
Fazio degli Uberti (nato nel 1367); del ferrarese Antonio Beccari (1315-1371); del padovano<br />
Francesco <strong>di</strong> Vannozzo (ante 1340-post 1389) – tutti ospiti, in tempi <strong>di</strong>versi, della corte milanese<br />
dei Visconti e <strong>di</strong> quella veronese degli Scaligeri.<br />
[La poesia allegorico-narrativa: Cecco d’Ascoli] Quanto ai poemi allegorico-narrativi, il<br />
Trecento produce, com’è noto, due capolavori, la Comme<strong>di</strong>a e i Trionfi, e un’opera altrettanto<br />
fortunata anche se <strong>di</strong> minor valore letterario, l’Amorosa visione <strong>di</strong> Boccaccio. Ma, accanto a queste<br />
vette, è da segnalare l’esistenza <strong>di</strong> una larghissima famiglia <strong>di</strong> imitatori più o meno pedestri: al<br />
linguaggio versificato – <strong>di</strong> solito nella forma della terzina incatenata o dell’ottava – vengono affidati<br />
temi e compiti che a noi lettori post-romantici sembra possano essere espressi e sod<strong>di</strong>sfatti soltanto<br />
d<strong>alla</strong> prosa. In questa vastissima produzione merita un cenno almeno l’Acerba <strong>di</strong> Cecco d’Ascoli<br />
(1269-1327), un poema incompiuto in cinque libri che passa in rassegna una buona fetta dello<br />
scibile umano spiegando le proprietà dei pianeti, la natura delle virtù e dei vizi, le proprietà degli<br />
animali e delle pietre, ecc.<br />
[Fazio degli Uberti] Mentre Cecco – caso più unico che raro nel Trecento – polemizza con<br />
Dante, opponendo il proprio enciclope<strong>di</strong>smo, il proprio interesse filosofico e scientifico alle ‘favole’<br />
narrate nella Comme<strong>di</strong>a, il Dittamondo <strong>di</strong> Fazio degli Uberti è una chiara ed esplicita imitazione del<br />
poema dantesco sia nel metro, sia nei motivi, sia nelle strategie narrative. Originale è però il tema<br />
centrale dell’opera: un viaggio immaginario attraverso tutto il mondo con la guida dell’antico<br />
geografo Solino. Il resoconto del viaggio – il poema stesso – finisce così per essere un manuale<br />
storico-geografico ricco <strong>di</strong> notizie su luoghi esotici ma ancora più ricco <strong>di</strong> leggende e mirabilia che<br />
fanno del Dittamondo una sorta <strong>di</strong> repertorio della letteratura fantastica.<br />
3.3. La prosa<br />
33


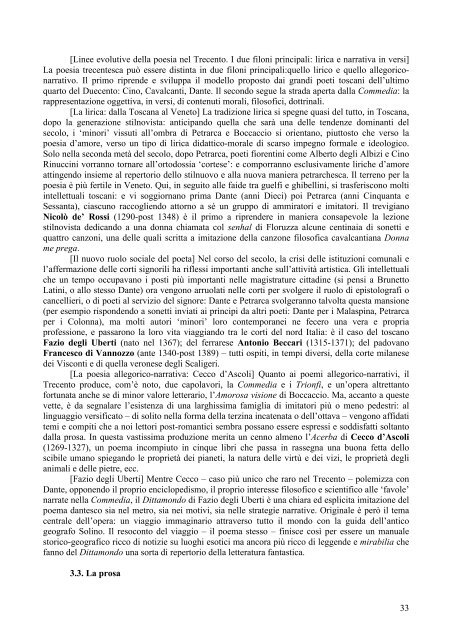






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
