Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’amore dei trovatori e dei poeti del Duecento era un sentimento recitato in pubblico, una sorta <strong>di</strong><br />
rappresentazione delle convenzioni cortesi in cui i sentimenti e i pensieri dell’autore avevano poca<br />
parte. Petrarca interpreta invece la lirica d’amore nel modo che ancor oggi ci è familiare: si<br />
confessa, narra una reale esperienza d’amore in totale solitu<strong>di</strong>ne, senza porsi il problema del<br />
pubblico e limitando al massimo la ripetizione dei clichés cortesi. Si può <strong>di</strong>re che grazie a lui si<br />
verifichi una conversione dall’oggettività <strong>alla</strong> soggettività. L’in<strong>di</strong>viduo che ama e desidera viene ad<br />
occupare quello spazio che nel passato era riservato <strong>alla</strong> rappresentazione della donna, ai rituali del<br />
corteggiamento, all’analisi oggettivante dell’amore: l’io del poeta-amante è ora al centro della<br />
scena. Questa chiusura nei confronti del contesto sociale, questo ripiegamento dell’io su se stesso,<br />
«che a prima vista può sembrare un impoverimento, nei secoli si rivelerà un territorio sconfinato. È<br />
anche grazie a questa scelta che Petrarca <strong>di</strong>venterà il caposcuola della poesia moderna. Egli ha<br />
sottratto il <strong>di</strong>scorso amoroso ai con<strong>di</strong>zionamenti storici, alle trasformazioni dei contesti sociali e<br />
culturali e ne ha fatto una zona franca, capace <strong>di</strong> rigenerarsi con il trascorrere del tempo [... Tale<br />
scelta] definisce la moderna poesia erotica come spazio dell’io e delle sue contrad<strong>di</strong>zioni»<br />
(Santagata).<br />
[La lingua] Il classicismo petrarchesco riguarda, in secondo luogo, il linguaggio della lirica.<br />
Coll’avvento del petrarchismo non ci sarà più spazio per gli sperimentalismi, le audacie formali, i<br />
giochi verbali che avevano avuto largo corso nel Duecento. La lingua <strong>di</strong> Petrarca è omogenea,<br />
compatta nei toni. Da un lato, pur essendo ricca <strong>di</strong> riferimenti colti <strong>alla</strong> tra<strong>di</strong>zione non soltanto<br />
volgare (nei testi del Canzoniere sono frequenti le allusioni <strong>alla</strong> Bibbia, ai classici latini, ai padri<br />
della Chiesa), essa evita i tecnicismi che avevano adoperato i poeti-retori come Guittone d’Arezzo<br />
nel Duecento; dall’altro, pur essendo limpida, comprensibile, lontana <strong>dalle</strong> complicazioni del trobar<br />
clus, essa non fa alcuna concessione al linguaggio ‘parlato’: è su questa norma <strong>di</strong> me<strong>di</strong>etas<br />
(‘me<strong>di</strong>età’) che Petrarca costruisce quello che è il modello linguistico a cui per secoli si<br />
adegueranno i poeti italiani.<br />
5.5 La fortuna<br />
Il genio <strong>di</strong> Petrarca fu imme<strong>di</strong>atamente riconosciuto dai contemporanei. Da un lato la sua<br />
grande cultura classica, dall’altro la laurea poetica, ricevuta prima dei quarant’anni, fecero <strong>di</strong> lui il<br />
letterato più noto e ammirato dei suoi tempi, non solo in Italia ma in tutta Europa. La sua prima<br />
biografia venne scritta, da Boccaccio, quando non aveva ancora compiuto il cinquant’anni: è il De<br />
vita et moribus domini Francisci Petracchi de Florentia. A contare, qui, è soprattutto lo scrittore <strong>di</strong><br />
prosa e <strong>di</strong> poesia latina, e tale sarà la tendenza anche nel secolo successivo, quando, per i suoi<br />
ritrovamenti e i suoi stu<strong>di</strong>, gli umanisti lo celebreranno come un caposcuola: il vero erede della<br />
rinata tra<strong>di</strong>zione classica. Solo nel Cinquecento – quando la filologia classica avrà assimilato e<br />
superato le scoperte petrarchesche – la tendenza si invertirà e l’interesse dei lettori e degli stu<strong>di</strong>osi si<br />
concentrerà sul Petrarca volgare. Pietro Bembo prima curerà la stampa del Canzoniere presso Aldo<br />
Manuzio, il migliore stampatore del tempo (1502); poi, nelle Prose della volgar lingua, in<strong>di</strong>cherà<br />
nella lingua poetica <strong>di</strong> Petrarca il modello da seguire per tutti i poeti volgari.<br />
[La fortuna del Canzoniere] Di qui in poi, la fortuna del Canzoniere sarà tale da non avere<br />
paragoni in tutta la letteratura occidentale. Per secoli, anche dopo il periodo dell’imitazione più<br />
pedestre, tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento (definita appunto l’età del<br />
petrarchismo), i lirici europei continueranno a trarre ispirazione <strong>dalle</strong> liriche petrarchesche sui due<br />
piani della forma e del contenuto. Per quanto riguarda la forma, Petrarca imporrà <strong>alla</strong> tra<strong>di</strong>zione<br />
<strong>italiana</strong> un lessico estremamente selezionato e ‘alto’, ben lontano d<strong>alla</strong> lingua dell’uso (perciò,<br />
leggendo un poeta dell’Ottocento, la sua lingua ci appare così <strong>di</strong>stante d<strong>alla</strong> nostra: da Petrarca in<br />
poi la lingua poetica è rimasta un ‘sistema’ sostanzialmente, e artificialmente, stabile, senza grosse<br />
variazioni rispetto a quella del modello). Per quanto riguarda il contenuto, <strong>di</strong>venterà un fatto<br />
normale, nei due secoli successivi, raccontare attraverso le poesie, cioè raccogliere le proprie rime<br />
in canzonieri dotati, per così <strong>di</strong>re, <strong>di</strong> una <strong>di</strong>rezione e <strong>di</strong> un senso complessivo: l’uso ‘narrativo’ della<br />
62


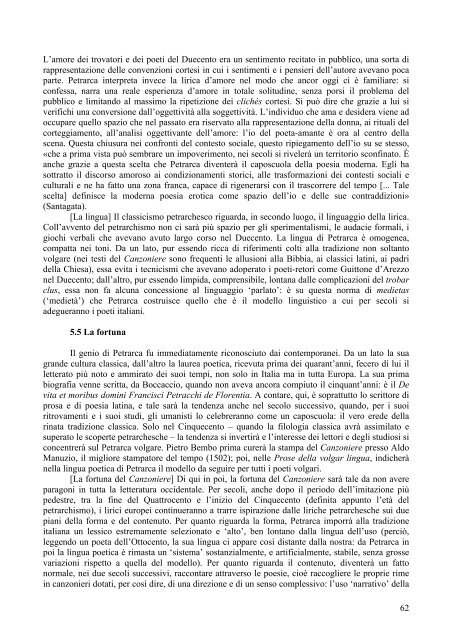






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
