Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
12.4). Questi due modelli sono citati esplicitamente da Dante nel canto II dell'Inferno, quando<br />
chiede a Virgilio perché proprio lui è stato prescelto per il viaggio nell’oltretomba cristiano: «Io non<br />
Enëa, io non Paulo sono» (Inf. II 32). Ma sia la visione sia il viaggio attraverso mon<strong>di</strong> immaginari e<br />
soprannaturali sono strutture narrative largamente <strong>di</strong>ffuse sia nell'agiografia (le ‘vite dei santi’: per<br />
esempio nel Purgatorio <strong>di</strong> San Patrizio, o nella Navigazione <strong>di</strong> San Brendano) sia nei vangeli<br />
apocrifi (quei vangeli, cioè, che pur essendo estranei al canone fissato d<strong>alla</strong> Chiesa cattolica,<br />
godevano <strong>di</strong> larga <strong>di</strong>ffusione anche a livello popolare), sia in testi appartenenti a tra<strong>di</strong>zioni straniere:<br />
francesi, spagnoli, arabi (particolarmente importante il Libro della Scala, in cui è rappresentato il<br />
viaggio <strong>di</strong> Maometto nell'oltretomba).<br />
[Lingua e stile: il metro] Nella Comme<strong>di</strong>a, Dante adopera una forma metrica <strong>di</strong> cui non si<br />
trovano, prima <strong>di</strong> lui, altre attestazioni: la terzina (o terza rima) detta ‘incatenata’: una forma aperta,<br />
allungabile a piacere, a seconda delle esigenze del <strong>di</strong>scorso. Lo schema delle rime è il seguente:<br />
ABA BCB CDC DED EFE, ecc.<br />
È possibile che tra le ragioni della scelta <strong>di</strong> questo metro vi sia un'intenzione simbolica: il ritorno<br />
del ‘numero sacro’ 3 (come le persone della Trinità, e come le cantiche della Comme<strong>di</strong>a). Ma la<br />
terzina ha soprattutto un'insostituibile funzione narrativa: consente <strong>di</strong> sviluppare il <strong>di</strong>scorso in<br />
maniera or<strong>di</strong>nata e omogenea ma, insieme, evita la monotonia delle rime baciate (<strong>di</strong> lunghe serie <strong>di</strong><br />
rime baciate a due a due si erano serviti spesso i poeti che, prima <strong>di</strong> Dante, avevano tentato la strada<br />
del poemetto in volgare).<br />
[Il lessico nell’Inferno] La varietà dei temi e delle figure rappresentate nella Comme<strong>di</strong>a si<br />
rispecchia nel linguaggio. Quello della Vita nova e delle Rime poteva limitarsi al riuso <strong>di</strong> un limitato<br />
numero <strong>di</strong> termini e <strong>di</strong> espressioni tra<strong>di</strong>zionali: si trattava quasi sempre <strong>di</strong> testi amorosi che<br />
utilizzavano dunque un linguaggio dei sentimenti fortemente co<strong>di</strong>ficato. L'oggetto della Comme<strong>di</strong>a<br />
è molto più ampio e complesso. La caratteristica saliente del poema è la polarità - che può<br />
significare anche compresenza a breve <strong>di</strong>stanza - tra registro basso e registro altro, tra umile e<br />
sublime. Da un lato, per la raffigurazione dell'Inferno, Dante si serve <strong>di</strong> uno stile aspro,<br />
violentemente realistico, a volte triviale. Non <strong>di</strong>sdegna perciò termini della lingua popolare<br />
(stregghia, scardova, buffa, ecc.); allinea nomi <strong>di</strong> luogo e <strong>di</strong> persona foneticamente rari e buffi o<br />
spaventosi: per esempio i <strong>di</strong>avoli si chiamano Alichino, Calcabrina, Cagnazzo, Barbariccia,<br />
Farfarello, ecc. (Inf. XXI); soprattutto, adopera questi proce<strong>di</strong>menti stilistici in rima, facendo sì che<br />
il suono aspro delle parole si estenda a intere terzine.<br />
[Il lessico nel Purgatorio e nel Para<strong>di</strong>so] Rispetto <strong>alla</strong> rappresentazione dell'Inferno quella<br />
del Purgatorio e del Para<strong>di</strong>so richiede uno stile del tutto <strong>di</strong>verso. Occorre, qui, dare conto delle<br />
gerarchie angeliche, della forma e della funzione dei cieli, e occorre affrontare delicati temi<br />
teologici. Inoltre quella che Dante ha davanti agli occhi non è una realtà materiale e carnale, fatta <strong>di</strong><br />
peccatori e <strong>di</strong> pene, ma un mondo <strong>di</strong> puri spiriti che sono o saranno beati. Di qui la scelta <strong>di</strong><br />
un'espressione più raffinata, lontana dal linguaggio quoti<strong>di</strong>ano. Dante fa larghissimo uso <strong>di</strong><br />
latinismi (image, viro – ‘uomo’, cive - ‘citta<strong>di</strong>no’, ecc.) spesso ricavati dal linguaggio scolastico e<br />
teologico (querente, qui<strong>di</strong>tate, sillogismo, ecc). Si pensi a un verso come «là ’ve s’appunta ogni ubi<br />
e ogne quando» (Par. XXIX 12). Dovendo inoltre dar conto <strong>di</strong> una realtà estranea a ogni<br />
esperienza umana (il Para<strong>di</strong>so), Dante inventa, insieme ai dettagli della visione, le parole che<br />
servono a esprimerla: <strong>di</strong> qui i neologismi incielarsi, insusarsi, indovarsi, o versi come «s’io<br />
m’intuassi, come tu t’inmii» (Par. IX 81: ‘se io penetrassi nel tuo pensiero come tu nel mio’).<br />
[Fortuna critica. Gli scritti in prosa] Ripercorrendo, in sintesi, le tappe principali della<br />
fortuna <strong>di</strong> Dante, conviene innanzitutto <strong>di</strong>stinguere tra il prosatore e il poeta. Il trattato sulla lingua e<br />
quello sulla politica ebbero, per ragioni <strong>di</strong>verse, circolazione limitata. Il De vulgari eloquentia restò<br />
incompiuto, e circolò pochissimo (ne restano solo tre manoscritti trecenteschi), tanto che, quando<br />
nel Cinquecento, venne ‘ritrovato’ e tradotto dal Trissino molti pensarono ad un falso; la prima<br />
e<strong>di</strong>zione a stampa è del 1577. La Monarchia, per il suo risoluto spirito anti-teocratico, non piacque<br />
53


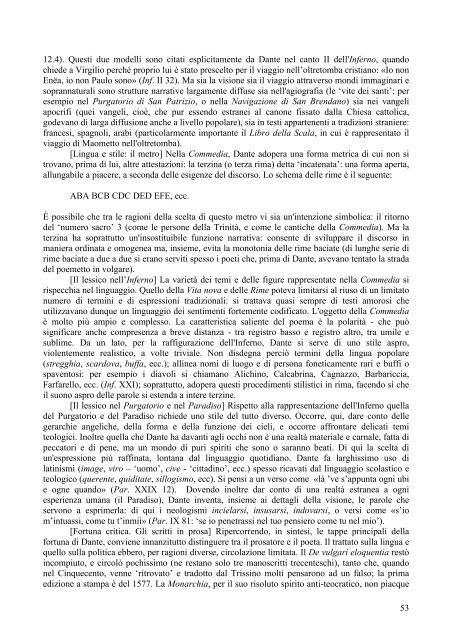






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
