Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La <strong>di</strong>fficoltà concettuale sta soprattutto in questo, che Cavalcanti risponde <strong>alla</strong> sua (immaginaria?)<br />
interlocutrice servendosi della filosofia aristotelica e del suo interprete Averroè: e la canzone, come<br />
si è potuto vedere dal breve brano citato, è tutto un fiorire <strong>di</strong> tecnicismi e astratte definizioni.<br />
[Il significato <strong>di</strong> Donna me prega nella poesia delle origini] Donna me prega segna<br />
un’importante novità nella storia della lirica <strong>italiana</strong> delle origini. Alla canzone d’amore si<br />
sostituisce la canzone sull’amore: il sentimento <strong>di</strong>venta materia <strong>di</strong> riflessione filosofica. Lo era già<br />
stato in parte con Guido delle Colonne e con Guinizzelli, ma nessuno dei due poeti si era spinto a<br />
questo livello <strong>di</strong> complessità e <strong>di</strong> impegno: non stupisce che Donna me prega sia stata, sin dal<br />
Trecento, stu<strong>di</strong>ata e commentata (privilegio che in genere i testi volgari non hanno, e men che meno<br />
quelli lirici) da generazioni <strong>di</strong> lettori.<br />
[La b<strong>alla</strong>ta Perch’i’ no spero] La b<strong>alla</strong>ta Perch’i’ no spero <strong>di</strong> tornar giammai è, insieme a<br />
Donna me prega, il testo più celebre <strong>di</strong> Cavalcanti, soprattutto in ragione della sua originalità<br />
tematica. Si tratta infatti non <strong>di</strong> una normale lirica amorosa ma <strong>di</strong> una sorta <strong>di</strong> testamento. Lontano<br />
da Firenze, il poeta si rivolge <strong>alla</strong> b<strong>alla</strong>ta stessa e la prega <strong>di</strong> recarsi d<strong>alla</strong> donna amata facendosi<br />
messaggera delle sue ultime parole: egli è infatti convinto che la sua <strong>morte</strong> sia prossima.<br />
Perch’i’ no spero <strong>di</strong> tornar giammai,<br />
b<strong>alla</strong>tetta, in Toscana,<br />
va tu, leggera e piana,<br />
dritt’a la donna mia,<br />
che per sua cortesia<br />
ti farà molto onore.<br />
È possibile – come ritenevano i critici ottocenteschi, da Foscolo a De Sanctis – che questa poesia sia<br />
davvero una sorta <strong>di</strong> congedo dall’esilio da parte del poeta morente; ma è anche possibile che si<br />
tratti soltanto <strong>di</strong> una finzione retorica: cioè <strong>di</strong> una situazione puramente letteraria priva <strong>di</strong> un<br />
concreto fondamento biografico. Quale che sia l’interpretazione corretta, il testo si <strong>di</strong>stingue per una<br />
originalità e una verità sentimentale che raramente si trovano nei testi pre-petrarcheschi, e che<br />
sembrano invece – e ciò spiega il favore <strong>di</strong> cui il testo gode presso i lettori o<strong>di</strong>erni - il prodotto <strong>di</strong><br />
una sensibilità moderna.<br />
[Cino da Pistoia. La vita] Con Dante e Cavalcanti, il terzo grande poeta stilnovista è il<br />
pistoiese Cino. Egli riassume in sé quelli che sono i caratteri <strong>di</strong>stintivi della ‘scuola’: uno stile dolce<br />
e piano, una misura ‘classica’ nei metri e nella lingua, l’amore come tema quasi esclusivo. Nato<br />
negli anni Settanta del Duecento, morto nel 1337, Cino fu, oltre che poeta, uno dei massimi giuristi<br />
del suo tempo: insegnò a Siena, Perugia, Napoli, e scrisse opere importanti in materia <strong>di</strong> teoria del<br />
<strong>di</strong>ritto (si ricor<strong>di</strong> almeno la sua Lectura in Co<strong>di</strong>cem). Guelfo, esule forse a Firenze nei primi anni<br />
del Trecento, egli fu, come Dante, fautore dell’imperatore Arrigo VII, e partecipò attivamente <strong>alla</strong><br />
vita civile e politica della sua città esercitando l’avvocatura e assumendo incarichi <strong>di</strong> consigliere del<br />
comune e <strong>di</strong> ambasciatore.<br />
[L’amore per Selvaggia] Tra gli stilnovisti, Cino è l’autore più prolifico. Buona parte dei<br />
suoi circa centocinquanta testi sono de<strong>di</strong>cati a una donna <strong>di</strong> nome Selvaggia. Con gli stilnovisti,<br />
infatti, i poeti tornano a dare un nome alle donne cantate nei loro versi: in ideale continuità con<br />
quella che era stata la norma nella lirica classica (Catullo, Properzio, Ovi<strong>di</strong>o). Tale nome può<br />
caricarsi <strong>di</strong> significati simbolici grazie a più o meno sottili interpretazioni (così, chiaramente, la<br />
Beatrice beatifica della Vita nova), ma rappresenta comunque qualcosa <strong>di</strong> più reale e vero<br />
dell’epiteto generico <strong>di</strong> donna.<br />
[La poetica] Poeta leu nelle sue rime d’amore, Cino è più sperimentale nei sonetti <strong>di</strong><br />
corrispondenza, ‘genere’ che egli pratica con grande assiduità soprattutto negli anni trascorsi presso<br />
lo Stu<strong>di</strong>um <strong>di</strong> Bologna. Qui la dolcezza del poeta d’amore lascia spazio a un registro ‘me<strong>di</strong>o’ che <strong>di</strong><br />
volta in volta è al servizio della satira, dell’invettiva, della burla. I suoi corrispondenti bolognesi<br />
sono gli ere<strong>di</strong> del primo e maggiore poeta emiliano, Guinizzelli. Certo nessuno <strong>di</strong> loro è all’altezza<br />
29


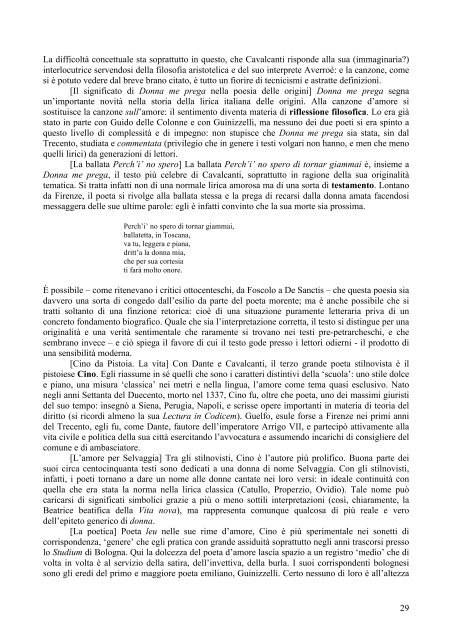






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
