Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
[Latino e volgare nell’età <strong>di</strong> Dante] Come si è già detto, nell'età <strong>di</strong> Dante, tra XIII e XIV<br />
secolo, la gran parte dei testi veniva scritta in latino. La poesia in volgare era, si può <strong>di</strong>re, appena<br />
nata, e ancor meno <strong>di</strong>ffuso era l'impiego del volgare in prosa. Nelle università, nei pubblici uffici,<br />
nelle chiese, il latino era, e sarebbe stato ancora a lungo, la lingua <strong>di</strong> gran lunga più usata. Me<strong>di</strong>tare<br />
su questa situazione è necessario per comprendere l'originalità e il coraggio <strong>di</strong> Dante che scrive, agli<br />
albori del Trecento, il De vulgari eloquentia, un saggio sull'eloquenza (cioè sulla lingua e sullo<br />
stile) volgare.<br />
[L’originalità del progetto dantesco] Erano stati scritti molti trattati che insegnavano le<br />
regole della grammatica e della composizione latina, ma - come osserva Dante all'inizio del De<br />
vulgari eloquentia - occuparsi scientificamente del volgare è un'impresa del tutto nuova: «non ci<br />
risulta che nessuno prima <strong>di</strong> noi abbia svolto una qualche trattazione sulla teoria dell’eloquenza<br />
volgare» (I.1). È una contrad<strong>di</strong>zione soltanto apparente che, a questo scopo, Dante stesso si serva<br />
del latino. Il fatto è che, pur volendo parlare della lingua che è comune a tutti, Dante non si rivolge<br />
al popolo bensì ai dotti, cioè a quanti con il loro esempio e con i loro scritti potevano, se persuasi<br />
<strong>dalle</strong> argomentazioni svolte nell'opera, dare man forte al suo progetto.<br />
[Struttura e temi] L'opera è incompiuta. È probabile che il parallelo impegno costituito d<strong>alla</strong><br />
stesura del Convivio, se non già della Comme<strong>di</strong>a, abbia costretto Dante a interrompere la trattazione<br />
del De vulgari a metà del secondo libro. L'autore aveva in programma almeno altri due libri. Uno,<br />
probabilmente, relativo <strong>alla</strong> prosa, l'altro certamente de<strong>di</strong>cato al «volgare me<strong>di</strong>ocre», cioè <strong>alla</strong><br />
lingua e allo stile adatti al registro comico. Se l'incompletezza del trattato ci priva del punto <strong>di</strong> vista<br />
<strong>di</strong> Dante su questi aspetti, non va <strong>di</strong>menticato che la sostanza del suo pensiero linguistico è<br />
contenuta nei due capitoli scritti. Quello che Dante cerca <strong>di</strong> definire è anzitutto un volgare<br />
«illustre», raffinato nella forma e nel lessico, che sia in grado <strong>di</strong> competere con il latino come lingua<br />
della comunicazione colta (il registro umile, per i temi meno elevati, costituirebbe quin<strong>di</strong> un aspetto<br />
secondario, dal momento che non qui potrebbe essere provata la superiore <strong>di</strong>gnità del volgare) e<br />
perché le leggi della poesia, approfon<strong>di</strong>te nel secondo libro, valgono anche per la prosa.<br />
Nell'estetica me<strong>di</strong>evale, infatti, la <strong>di</strong>stanza tra prosa e poesia è meno grande <strong>di</strong> quanto non sia oggi:<br />
entrambe obbe<strong>di</strong>scono alle stesse norme retoriche e stilistiche e possono avere la stessa funzione (è<br />
per questa ragione, tra l'altro, che i me<strong>di</strong>evali potevano mettere in versi temi che noi oggi<br />
consideriamo esclusivi della prosa: la morale, la scienza, la religione).<br />
[Il giu<strong>di</strong>zio sulla letteratura del passato] Esauritasi, o risolta, la «questione della lingua»,<br />
l'interesse del De vulgari è legato oggi soprattutto ai giu<strong>di</strong>zi espressi da Dante sulla letteratura: gli<br />
esempi <strong>di</strong> cui si serve per esporre la sua teoria linguistica ci aiutano infatti a capire che cosa egli<br />
pensasse dei poeti del suo tempo e dei suoi predecessori. Quando spiega come dev'essere fatto un<br />
verso, o quali sono le parole da usare, Dante cita infatti spesso dei brani <strong>di</strong> poesie che debbono<br />
servire da modello. La cosa è importante in sé, perché sono molto rari, nel Me<strong>di</strong>oevo, gli scritti in<br />
cui venga almeno abbozzata una storia della letteratura, tantomeno in volgare, o in cui si confronti<br />
criticamente l'opera <strong>di</strong> autori <strong>di</strong>versi. Ma è importante soprattutto se guar<strong>di</strong>amo <strong>alla</strong> natura degli<br />
esempi e al modo in cui essi vengono presentati e <strong>di</strong>scussi. In primo luogo, Dante appare molto ben<br />
informato non solo sulla poesia delle varie regioni italiane ma anche su quella francese e<br />
provenzale: egli sente trovatori e trovieri (cfr. § 2) come parte della sua stessa tra<strong>di</strong>zione. In<br />
secondo luogo, Dante non cita soltanto per elogiare - in<strong>di</strong>cando l'autore citato come modello da<br />
seguire - ma anche per criticare. Tra i poeti della corte <strong>di</strong> Federico II, vissuti nel Mezzogiorno<br />
d'Italia nella prima metà del Duecento, cita e apprezza Guido delle Colonne, Giacomo da Lentini,<br />
Rinaldo d'Aquino, e li loda in quanto seppero allontanarsi dal rozzo <strong>di</strong>aletto d'origine (il siciliano<br />
così come si legge, per esempio, nel Contrasto <strong>di</strong> Cielo d'Alcamo). Quanto ai trovatori, in<br />
coincidenza con la tripartizione tematica tra salus, venus e virtus (De vulgari eloquentia, II.2),<br />
nomina Bertran de Born, come cantore delle armi (salus, nel senso <strong>di</strong> ‘salvezza’), Giraut de Bornelh<br />
come poeta per eccellenza della rettitu<strong>di</strong>ne (virtus) e Arnaut Daniel come poeta dell'amore (venus).<br />
Vari elementi fanno ritenere che proprio quest'ultimo fosse il trovatore più apprezzato da Dante.<br />
Arnaut infatti non solo viene citato altre volte nel trattato, ma l'omaggio che qui Dante gli rende<br />
47


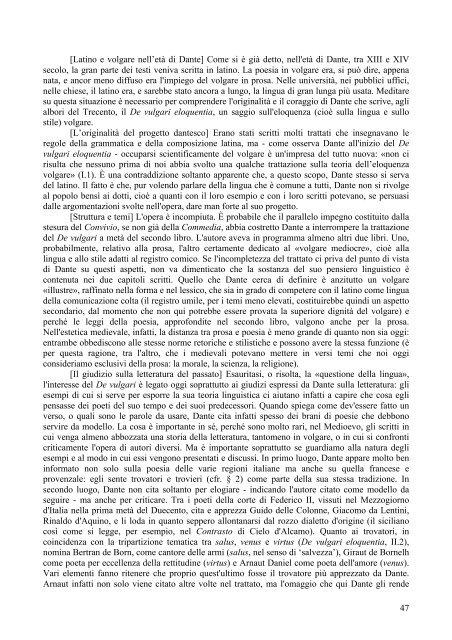






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
