Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
[Altri generi narrativi: i lais e i romanzi in prosa] Epica e romanzo cavalleresco non<br />
esauriscono il repertorio dei generi narrativi antico-francesi. Molto più brevi dei romanzi (poche<br />
centinaia, a volte poche decine <strong>di</strong> versi) sono i lais, che tramandano leggende <strong>di</strong> origine celtica e<br />
bretone. La maggior parte dei lais a noi pervenuti è opera non <strong>di</strong> uno scrittore ma – caso rarissimo<br />
nel Me<strong>di</strong>oevo - <strong>di</strong> una scrittrice, Maria <strong>di</strong> Francia, vissuta nella seconda metà del sec. XII (dunque<br />
negli stessi anni <strong>di</strong> Chrétien de Troyes) <strong>alla</strong> corte <strong>di</strong> Enrico Plantageneto. Così come l’epica delle<br />
chansons e i romanzi, anche i lais sono narrazioni in versi. La prosa, in latino e nelle lingue<br />
romanze, era adoperata <strong>di</strong> solito per le scritture sacre, per i documenti ufficiali, per la storiografia.<br />
Perché essa venga usata anche nella letteratura d’invenzione in volgare occorre attendere il<br />
Duecento, quando il materiale leggendario cantato dai poeti troverà spazio in gran<strong>di</strong> cicli prosastici<br />
destinati non più <strong>alla</strong> recitazione ma <strong>alla</strong> lettura ‘privata’: e nasceranno la saga del Lancelot-Graal<br />
(1215-1235), quella già citata del Tristan (1230-1235), e quella <strong>di</strong> Guiron le Courtois (1235 circa).<br />
[I romanzi allegorici: il Roman de la Rose] Se l’epica delle chansons de geste ‘ricrea’ una<br />
leggenda a partire da dati storici oggettivi, e se il romanzo cavalleresco inventa i suoi personaggi<br />
facendoli muovere in un mondo immaginario <strong>di</strong> corti meravigliose, tornei, incantamenti, i romanzi<br />
allegorici, le cosiddette ‘visioni’ rinunciano ad ogni legame con la realtà e mettono al centro della<br />
narrazione non degli esseri umani ma delle astrazioni, dei simboli. Prototipo e modello <strong>di</strong> queste<br />
allegorie è la Psicomachia del poeta latino Prudenzio (secc. IV-V d.C.), che mette in scena una<br />
guerra tra i vizi e le virtù cristiane d<strong>alla</strong> quale queste ultime riescono vittoriose. Tra i ‘romanzi’ che<br />
<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente s’ispirano all’opera prudenziana merita <strong>di</strong> essere ricordato, anche per<br />
la <strong>di</strong>ffusione che esso a sua volta ebbe in tutta Europa, il Roman de la Rose (‘Romanzo della rosa’,<br />
ma si cita sempre con il titolo originale), iniziato da Guillaume de Lorris attorno al 1240 e<br />
terminato da Jean de Meung verso la fine del Duecento. In sogno, l’autore-protagonista aspira a<br />
conquistare la Rosa, simbolo del sesso femminile, ma in questa impresa è ostacolato da una serie <strong>di</strong><br />
forze ostili raffigurate come simboli: la Vergogna, il Pericolo, la Gelosia, Malabocca, ecc. A tali<br />
‘nemici’ si oppongono altrettante virtù ‘positive’: la Pietà, la Bella Accoglienza, Venere, ecc. Il<br />
romanzo è la storia <strong>di</strong> questa lunga ma infine vittoriosa battaglia.<br />
[I prodromi del teatro] Il teatro delle origini è legato <strong>alla</strong> liturgia e <strong>alla</strong> vita religiosa della<br />
comunità. Durante le funzioni sacre, o in occasione delle festività religiose, gruppi <strong>di</strong> fedeli<br />
mettevano in scena episo<strong>di</strong> tratti <strong>dalle</strong> vite dei santi o d<strong>alla</strong> Bibbia (soprattutto la storia <strong>di</strong> Adamo ed<br />
Eva, o della Passione): ed è questa, del resto, una pratica <strong>di</strong> devozione ancor oggi vitale. Il processo<br />
<strong>di</strong> ‘laicizzazione’ del teatro si avvia proprio in Francia nel corso del XII e del XIII secolo, quando le<br />
recite (jeux, nella tra<strong>di</strong>zione francese, autos, in quella spagnola) iniziano ad aver luogo non più<br />
all’interno delle chiese ma all’aperto, e nuovi temi profani trovano spazio accanto a quelli sacri.<br />
Tale processo potrà <strong>di</strong>rsi compiuto con le opere <strong>di</strong> Adam de la Halle (1240-1288): il Jeu de la<br />
Feullié, che mette in scena la comica storia <strong>di</strong> un paesano che si reca nella grande città per stu<strong>di</strong>are,<br />
e il Jeu de Robin et Marion, comme<strong>di</strong>a a due voci in cui un cavaliere tenta <strong>di</strong> sedurre una pastorella.<br />
[La lirica in Francia: trovieri e trovatori] Anche la lirica in volgare nasce e si sviluppa, prima<br />
che altrove, sul territorio dell’attuale Francia. Nel nord, in una vasta regione che ha al suo centro<br />
Parigi, il volgare è il <strong>di</strong>aletto oitanico (la lingua d’oïl), e i lirici che a partire dagli anni Settanta del<br />
secolo XII compongono in questa lingua sono detti trovieri. Si tratta <strong>di</strong> borghesi, <strong>di</strong> cavalieri come<br />
il Chastelain de Coucy, e <strong>di</strong> nobili come Goffredo <strong>di</strong> Bretagna o Thibaut <strong>di</strong> Navarra. Nel sud, nelle<br />
regioni della Provenza e della Linguadoca, il volgare è il <strong>di</strong>aletto occitanico (la lingua d’oc). È in<br />
quest’area e in questo i<strong>di</strong>oma che - a partire d<strong>alla</strong> metà del sec. XI e per circa due secoli, in netto<br />
anticipo dunque rispetto a quella dei trovieri - viene composta la poesia dei trovatori.<br />
[La poesia trobadorica: i temi] I temi della poesia trobadorica sono molteplici: (1) la<br />
cronaca e la vita politica contemporanea commentate con forte spirito partigiano da poeti che spesso<br />
risiedevano nelle corti <strong>di</strong> prìncipi che in quella cronaca e in quella politica erano <strong>di</strong>rettamente<br />
coinvolti; (2) la satira, poiché spesso i poeti intrattengono il loro pubblico con scherzi e invettive<br />
all’in<strong>di</strong>rizzo dei loro avversari (tipica è la forma poetica della tenzone, un <strong>di</strong>alogo in versi nel quale<br />
due poeti si affrontano ciascuno argomentando, stanza dopo stanza, il proprio punto <strong>di</strong> vista); (3) la<br />
15


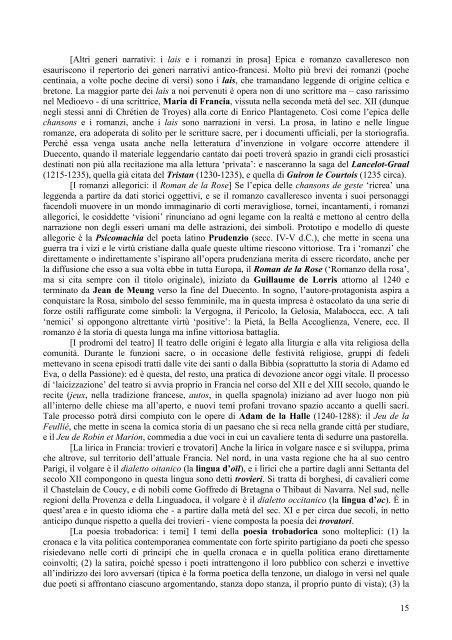






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
