Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
segnata dal conflitto fra queste tre città, ciascuna al centro <strong>di</strong> una a volte amplissima zona <strong>di</strong><br />
influenza. Alla fine del secolo, con la signoria <strong>di</strong> Gian Galeazzo Visconti (1385-1402), Milano<br />
arrivò a conquistare Padova e Verona, e ad esercitare un dominio in<strong>di</strong>retto su vaste zone del centro<br />
Italia. Ma, <strong>alla</strong> <strong>morte</strong> <strong>di</strong> Gian Galeazzo, Venezia e Firenze ripresero l’iniziativa, la prima<br />
estendendo il suo potere sulla terraferma sino a comprendere l’intero Veneto attuale, la seconda<br />
sottomettendo Arezzo e, nel 1406, la nemica storica, Pisa.<br />
[Il Mezzogiorno d’Italia nel Trecento] La storia dell’Italia meri<strong>di</strong>onale nel Trecento è<br />
caratterizzata da un fenomeno analogo a quello ora descritto: l’indebolimento delle gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>nastie<br />
regnanti e il frazionamento del potere. Nel Regno <strong>di</strong> Sicilia, gli Aragonesi dovettero governare<br />
scendendo a patti con i baroni dell’isola, che ripristinarono una sorta <strong>di</strong> potere feudale su larga parte<br />
del territorio. Nel Regno <strong>di</strong> Napoli, il debole Roberto d’Angiò (1309-1343) fu costretto a fare<br />
ampie concessioni <strong>alla</strong> nobiltà locale, delegando parte della sua autorità a ‘parlamenti’ citta<strong>di</strong>ni<br />
egemonizzati dai gran<strong>di</strong> proprietari terrieri. La <strong>di</strong>sunione del regno e la crisi finanziaria – che portò<br />
al ritiro del cre<strong>di</strong>to da parte dei banchieri fiorentini – furono il prelu<strong>di</strong>o del conflitto politico che <strong>alla</strong><br />
fine del secolo oppose Luigi d’Angiò a Carlo <strong>di</strong> Durazzo (e i rispettivi casati e satelliti: Angioini e<br />
Durazzeschi) per la successione al trono. La crisi si concluderà, nel 1442, con la conquista <strong>di</strong> Napoli<br />
da parte degli Aragonesi, che riuniranno dopo un secolo e mezzo il Mezzogiorno d’Italia sotto<br />
un’unica corona.<br />
1.2 Il ruolo della Chiesa nella storia <strong>italiana</strong> due-trecentesca<br />
[La crisi morale della Chiesa e i tentativi <strong>di</strong> riforma: movimenti pauperistici ed eresie] Il<br />
<strong>di</strong>fficile equilibrio tra il potere politico e il potere religioso è, come si è accennato, una delle<br />
questioni fondamentali nella storia <strong>italiana</strong> dopo il Mille. Come anche si è detto, la Chiesa tese<br />
sempre più ad unire i due poteri estendendo la sua giuris<strong>di</strong>zione sulle cose terrene. Ma la<br />
compromissione col mondo portò con sé la corruzione dei costumi del clero: nulla <strong>di</strong> più lontano<br />
d<strong>alla</strong> norma <strong>di</strong> una vita cristiana, così come era stata illustrata dal Vangelo e dai Padri della Chiesa,<br />
della condotta <strong>di</strong> quei religiosi che vivevano nel lusso e nel vizio facendo pubblico commercio delle<br />
cariche ecclesiastiche. Questa crisi sollecitò reazioni <strong>di</strong>verse. La prima fu quella dei movimenti<br />
pauperistici come la cosiddetta Pataria, che nel secolo XI, a Milano, lottò contro la corruzione del<br />
clero locale. La seconda fu quella degli ‘eretici’, che <strong>alla</strong> volontà moralizzatrice univano più<br />
pericolose – perché potenzialmente rivoluzionarie – istanze <strong>di</strong> revisione in materia dottrinale: non<br />
solo una riforma del clero ma una riforma della fede. La Chiesa <strong>di</strong> Roma agì contro questi gruppi <strong>di</strong><br />
eretici con estrema violenza: nel giro <strong>di</strong> alcuni decenni, i catari (cioè i ‘puri’), la più cospicua <strong>di</strong><br />
queste sette ereticali, furono sterminati nel nord Italia e nel sud della Francia, e lo stesso accadde a<br />
gruppuscoli minori riuniti intorno a figure carismatiche, come i seguaci <strong>di</strong> Gerardo Segalelli (gli<br />
‘apostolici’), finito sul rogo nel 1300, o <strong>di</strong> fra Dolcino (‘dolciniani’), fatti massacrare da papa<br />
Clemente V.<br />
[I nuovi or<strong>di</strong>ni religiosi nel Duecento] La terza reazione <strong>alla</strong> corruzione della Chiesa, la più<br />
importante e gravida <strong>di</strong> futuro, si mantenne entro i confini dell’ortodossia. Si tratta dei nuovi or<strong>di</strong>ni<br />
religiosi che nascono in Italia all’inizio del Duecento. Il castigliano Domenico <strong>di</strong> Guzmàn (1175-<br />
1221), dopo aver combattuto gli eretici nel sud della Francia organizzò una comunità <strong>di</strong> sacerdoti<br />
che nel 1216 ricevette l’approvazione <strong>di</strong> papa Onorio III: nasceva l’or<strong>di</strong>ne domenicano. I suoi<br />
membri vennero detti ‘frati pre<strong>di</strong>catori’, perché questo fu il loro primo compito: viaggiare <strong>di</strong> città in<br />
città pre<strong>di</strong>cando la fede cristiana; e anche ‘frati men<strong>di</strong>canti’, poiché, in linea col precetto evangelico<br />
della povertà, potevano sostentarsi soltanto con ciò che ricevevano in elemosina. Gli ideali<br />
dell’umiltà e della povertà sono anche caratteristici dell’or<strong>di</strong>ne francescano, sorto all’incirca negli<br />
stessi anni. Nato ad Assisi nel 1182 da una famiglia <strong>di</strong> mercanti, ancora giovane Francesco raccolse<br />
attorno a sé un piccolo gruppo <strong>di</strong> confratelli, chiamati minores. Ben presto, questa comunità si<br />
<strong>alla</strong>rgò e fece proseliti in tutta Europa. Nel 1223, la cosiddetta Regula bullata dei francescani venne<br />
approvata da papa Onorio III; poco dopo (1226), Francesco moriva.<br />
5


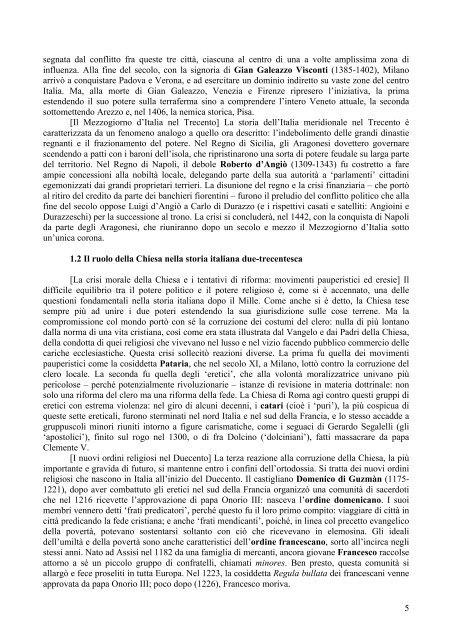






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
