Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
poi, non si era mai veramente interrotta: la descrizione della vita e delle gesta <strong>di</strong> uomini famosi è un<br />
luogo comune della storiografia me<strong>di</strong>evale. La novità <strong>di</strong> Petrarca consiste soprattutto in tre fatti: un<br />
<strong>di</strong>verso rapporto con le fonti eru<strong>di</strong>te, nel senso che egli non si limita a ripetere quanto vi trova<br />
scritto ma fa opera veramente critica <strong>di</strong> storiografo, confrontandole ed emendandole dagli errori; un<br />
atteggiamento ‘laico’ <strong>di</strong> fronte ai personaggi ritratti, apprezzati e lodati, più che per la loro funzione<br />
provvidenziale, per le loro virtù umane (il coraggio, la lealtà, ecc.); una rigida selezione quanto al<br />
‘genere’ dei biografati: «non vi si parla – scriverà Petrarca – <strong>di</strong> me<strong>di</strong>ci né <strong>di</strong> poeti o filosofi, ma<br />
soltanto <strong>di</strong> coloro che si <strong>di</strong>stinsero per le virtù militari o per il grande amore per la patria»: è quello<br />
che oggi chiameremmo il ‘valore civile’ a interessare il biografo, non la virtù in sé. Il De viris venne<br />
ripreso da Petrarca all’inizio degli anni Cinquanta e ampliato con l’aggiunta <strong>di</strong> biografie <strong>di</strong><br />
personaggi appartenenti alle civiltà extraromane: l’oriente, il mito greco, la Bibbia; ma anche questa<br />
seconda redazione dell’opera resterà incompiuta.<br />
[I Rerum memorandarum libri] Nel 1343, Petrarca avvia un’altra opera storiografica meno<br />
impegnativa del De viris illustribus, i Rerum memorandarum libri. Si tratta <strong>di</strong> una raccolta <strong>di</strong><br />
aneddoti - sul modello dei Fatti e detti memorabili dello storico latino Valerio Massimo - che,<br />
secondo il progetto iniziale, dovevano servire a illustrare le quattro virtù car<strong>di</strong>nali: giustizia,<br />
prudenza, fortezza e temperanza. La materia degli aneddoti è tratta non solo, come nel De viris,<br />
d<strong>alla</strong> storia romana, ma anche da quella contemporanea: tra i detti e i fatti memorabili registrati ci<br />
sono anche quelli, per esempio, <strong>di</strong> re Roberto d’Angiò, <strong>di</strong> Matteo Visconti, <strong>di</strong> Dante. I limiti<br />
dell’opera sono chiari. Se il De viris era troppo ambizioso, e perciò venne abbandonato, questo<br />
catalogo <strong>di</strong> Res memorandae è troppo caotico e occasionale per avere un reale interesse<br />
storiografico: anch’esso rimase incompiuto e venne pubblicato soltanto dopo la <strong>morte</strong> del poeta.<br />
[La svolta autobiografica degli anni Quaranta: il Secretum] Nel corso degli anni Quaranta,<br />
lasciata l’oggettività dell’epica e della storiografia, l’opera <strong>di</strong> Petrarca si orienta verso un più forte<br />
coinvolgimento soggettivo: il poeta riflette e parla <strong>di</strong> sé, in linea con quel proposito <strong>di</strong> autoanalisi e<br />
<strong>di</strong> conversione cui si è accennato sopra. Nella prosa latina del Secretum (intitolato in effetti De<br />
secreto conflictu curarum mearum ‘Sul segreto conflitto delle mie angustie’), Petrarca si ispira per<br />
il contenuto alle Confessioni <strong>di</strong> sant’Agostino e per la forma ai <strong>di</strong>aloghi ciceroniani, e mette in<br />
scena una conversazione immaginaria tra se stesso e Agostino al cospetto della Verità. Nel primo<br />
libro, che funge da introduzione, Agostino esorta Francesco a riflettere sulla <strong>morte</strong> e a orientare la<br />
sua vita al bene: nessuno – sostiene infatti il maestro – può essere infelice contro la propria volontà.<br />
Nel secondo libro Agostino passa in rassegna i peccati capitali richiamando l’attenzione <strong>di</strong><br />
Francesco su quelli che più lo affliggono: e mentre egli può <strong>di</strong>rsi immune dall’invi<strong>di</strong>a, d<strong>alla</strong> gola o<br />
dall’avarizia, non altrettanto si può <strong>di</strong>re della lussuria, o <strong>di</strong> peccati tipici degli intellettuali come<br />
l’ambizione e l’acci<strong>di</strong>a. Proprio sulle tentazioni della carne e sulla fama terrena Agostino insiste nel<br />
terzo libro: l’amore per Laura, sostiene Agostino, ha allontanato, non avvicinato Francesco a Dio: la<br />
devozione per una creatura terrena è d’ostacolo a una condotta autenticamente cristiana. Quanto <strong>alla</strong><br />
letteratura, è tempo che Francesco abbandoni le opere ‘laiche’ che gli avevano dato la laurea poetica<br />
e passi a me<strong>di</strong>tare sui testi sacri e sul destino della sua anima: la <strong>morte</strong> – e in ciò il Secretum si<br />
avvicina a quelle opere della tra<strong>di</strong>zione cristiana de<strong>di</strong>cate al contemptus mun<strong>di</strong> (‘Il <strong>di</strong>sprezzo delle<br />
cose mondane’) – non è lontana.<br />
[Le opere d’ispirazione cristiana] La carriera letteraria <strong>di</strong> Petrarca segue almeno in parte, <strong>di</strong><br />
qui in poi, la <strong>di</strong>rezione in<strong>di</strong>cata dal Secretum. Tra il 1347 e il 1348 (ma alcuni stu<strong>di</strong>osi hanno<br />
proposto una datazione più alta, al 1342-43) scrive in latino sette Salmi penitenziali: preghiere<br />
tramate <strong>di</strong> citazioni bibliche in cui il poeta confessa il proprio smarrimento, <strong>di</strong>chiara il proposito <strong>di</strong><br />
pentirsi e confida nella misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong>vina. Anche i due ‘saggi’ De vita solitaria e De otio<br />
religioso, scritti nella seconda metà degli anni Quaranta, recano chiari i segni dell’ispirazione<br />
cristiana: l’eru<strong>di</strong>zione classica delle opere del decennio precedente lascia il posto a un interesse<br />
introspettivo e parenetico. Il primo trattato (1346, con successivi rimaneggiamenti e de<strong>di</strong>ca nel<br />
1366, a Filippo <strong>di</strong> Cabassoles) è un elogio della solitu<strong>di</strong>ne e dell’otium intellettuale («leggere ciò<br />
che hanno scritto gli antichi – questo il progetto petrarchesco – e scrivere ciò che leggeranno i<br />
58


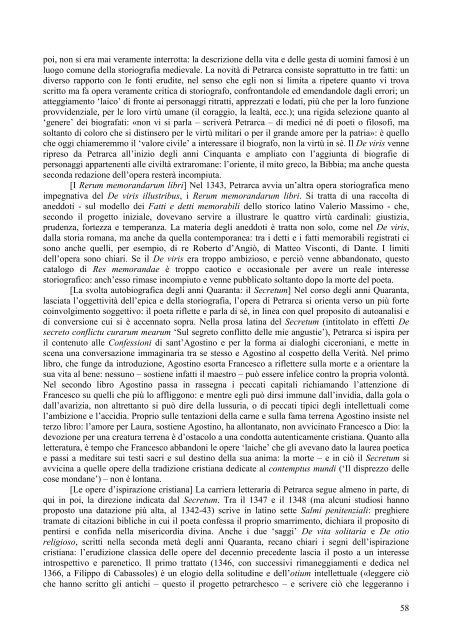






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
