Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
alle gerarchie ecclesiastiche, e fu condannata al rogo come libro eretico dal legato papale Bertrando<br />
del Poggetto (resterà nell’In<strong>di</strong>ce dei libri proibiti d<strong>alla</strong> Chiesa cattolica sino al 1881); l’approvarono<br />
invece, trovandovi buoni argomenti a convalida delle proprie tesi, quanti ritenevano che la sfera<br />
politica dovesse mantenersi autonoma d<strong>alla</strong> sfera religiosa: e si spiega così il favore con cui l’opera<br />
venne letta da un rivoluzionario come Cola <strong>di</strong> Rienzo o, nel Cinquecento, dai maggiori esponenti<br />
delle chiese riformate. Fortuna più ampia ebbe il trattato filosofico del Convivio: ma rari imitatori,<br />
posto che la lingua della filosofia restò ancora per lungo tempo il latino.<br />
[La poesia lirica]. Con Petrarca, Dante fu il massimo e più influente poeta lirico del<br />
Me<strong>di</strong>oevo. La struttura della Vita nova – una cornice prosastica che mette in sequenza e commenta<br />
alcuni testi poetici, facendo <strong>di</strong> questa successione la trama <strong>di</strong> un racconto – era, probabilmente,<br />
troppo ardua perché potesse trovare subito degli imitatori: e per trovare qualcosa <strong>di</strong> simile occorrerà<br />
aspettare, ormai sullo scorcio del Quattrocento, il Comento <strong>di</strong> Lorenzo de’ Me<strong>di</strong>ci alle proprie<br />
liriche. Ma temi, motivi, forme e strutture metriche delle sue poesie vennero largamente imitati nei<br />
due secoli successivi: e, soprattutto nella sfera della poesia morale e allegorica (la sfera <strong>di</strong> una<br />
canzone come Tre donne intorno al cor mi son venute), il suo esempio restò vivo e anche nell’età<br />
dell petrarchismo.<br />
[La Comme<strong>di</strong>a] Quanto <strong>alla</strong> Comme<strong>di</strong>a, basti fissare qui le coor<strong>di</strong>nate essenziali <strong>di</strong> una<br />
fortuna davvero sterminata, imparagonabile a quella <strong>di</strong> qualsiasi altra opera letteraria me<strong>di</strong>evale. A<br />
pubblicarla, cioè a commissionarne copie e a sovrintendere <strong>alla</strong> sua prima circolazione, furono<br />
probabilmente i figli stessi <strong>di</strong> Dante, Iacopo e Pietro, poco dopo la <strong>morte</strong> del poeta. E subito i<br />
letterati si cimentarono nel commento, in latino o in volgare, all’opera, inaugurando una tra<strong>di</strong>zione<br />
esegetica ancor oggi vitale; si ricor<strong>di</strong>no almeno i commenti <strong>di</strong> Graziolo de’ Bambaglioli, <strong>di</strong> Iacopo<br />
della Lana (anni Venti del Trecento), <strong>di</strong> Guido da Pisa, <strong>di</strong> Andrea Lancia detto l’Ottimo (anni<br />
Trenta), <strong>di</strong> Benvenuto da Imola, a metà secolo, e <strong>di</strong> Francesco da Buti poco più tar<strong>di</strong>. Una pietra<br />
miliare nella fortuna del poema sono poi le letture pubbliche tenute da Giovanni Boccaccio nel<br />
1373 e nel 1374 a Firenze (Esposizioni): pur rimaste frammentarie, esse consacrarono la Comme<strong>di</strong>a<br />
al rango <strong>di</strong> classico, meritevole <strong>di</strong> essere non solo letto ma stu<strong>di</strong>ato. Di qui in poi, la Comme<strong>di</strong>a sarà<br />
sempre, per il pubblico dei lettori, l’opera letteraria più amata e familiare. L’atteggiamento degli<br />
intellettuali fu meno univoco. Gli umanisti del Quattrocento rimproverarono Dante per aver usato,<br />
in un’opera <strong>di</strong> soggetto così elevato, il volgare e non il latino. E anche circa l’uso del volgare, il<br />
Rinascimento – e in primis il massimo giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> cose <strong>di</strong> lingua e letteratura nella prima metà del<br />
secolo XVI, Pietro Bembo – preferirà tendenzialmente il raffinatissimo Petrarca al troppo rozzo e<br />
<strong>di</strong>seguale Dante, e il primo, non il secondo, proporrà come modello degno <strong>di</strong> essere imitato. Questo<br />
pregiu<strong>di</strong>zio spiega, in parte, la relativa sfortuna della Comme<strong>di</strong>a nel corso del Seicento (tre sole<br />
e<strong>di</strong>zioni a stampa durante tutto il secolo). Toccherà a Giambattista Vico, nella prima metà del<br />
Settecento, rifondare la critica dantesca mettendo l’accento su quei caratteri della Comme<strong>di</strong>a che<br />
saranno poi particolarmente cari <strong>alla</strong> critica romantica: il rapporto con il sentimento popolare e con<br />
la naura, che apparenta Dante ad Omero; la forza quasi barbarica della rappresentazione, soprattutto<br />
nell’Inferno; la capacità <strong>di</strong> unire in sintesi perfetta fantasia e storia. Nel corso dell’Ottocento,<br />
l’amore per la Comme<strong>di</strong>a non farà che aumentare, sia perché ad essa si richiameranno i maggiori<br />
poeti del secolo, da Foscolo a Leopar<strong>di</strong> (si pensi <strong>alla</strong> canzone giovanile Sopra il monumento <strong>di</strong><br />
Dante che si preparava in Firenze), da Monti a Pascoli, sia perché del poema si approprierà il<br />
patriottismo risorgimentale, trasformandolo in una sorta <strong>di</strong> mito <strong>di</strong> fondazione della nazione<br />
<strong>italiana</strong>: e a questa lettura ‘politica’ contribuirà anche il massimo critico italiano del secolo<br />
Francesco De Sanctis. Nel solco del Vico e della critica romantica (Hegel), lo stesso De Sanctis<br />
concentrerà l’attenzione sul problema cruciale del realismo dantesco: problema che ha sollecitato<br />
più tar<strong>di</strong> le ricerche del maggiore dantista del Novecento, Erich Auerbach. Insieme ad Auerbach<br />
andranno ricordati almeno altri tre stu<strong>di</strong>osi novecenteschi che, da prospettive <strong>di</strong>verse, hanno fornito<br />
interpretazioni innovative del poema: l’americano Charles Singleton (per i rapporti della Comme<strong>di</strong>a<br />
con i testi sacri e la letteratura cristiana) e gli italiani Bruno Nar<strong>di</strong> (per le conoscenze filosofiche <strong>di</strong><br />
Dante) e Gianfranco Contini (per la lingua e lo stile).<br />
54


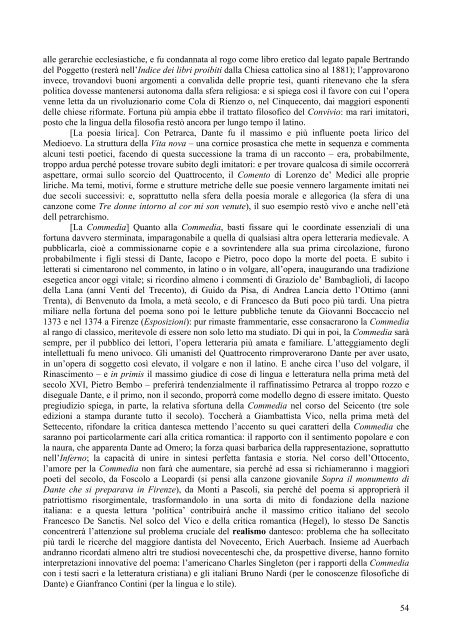






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
