Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
[I temi: amore e fortuna] Gli argomenti delle novelle sono così descritti nel Proemio (14):<br />
«... nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno così<br />
ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi». Amore e fortuna sono, in effetti, i temi dominanti<br />
del libro. Il primo era, come si è visto, già largamente presente nella narrativa <strong>di</strong> Boccaccio – ma<br />
nella sua versione elegiaca (casi sfortunati <strong>di</strong> <strong>di</strong>sgrazie d’amore) piuttosto che in quella burlesca o<br />
euforica prevalente nel Decameron, dove il nome <strong>di</strong> amore è dato spesso <strong>alla</strong> semplice<br />
sod<strong>di</strong>sfazione sessuale: la quarta e la quinta giornata sono quelle consacrate alle imprese d’amore<br />
così concepite (ecco per esempio la rubrica che introduce la quarta giornata: «Sotto il reggimento <strong>di</strong><br />
Filostrato, si ragiona <strong>di</strong> coloro, li cui amori ebbero infelice fine»). Il secondo tema, la fortuna, va<br />
inteso nel senso più largo <strong>di</strong> ‘caso, destino, fatalità, accidente, peripezia’: ciò che <strong>di</strong> strano e<br />
singolare, insomma, movimenta la normale vita degli uomini, Novelle ispirate a questo soggetto si<br />
trovano soprattutto nella seconda giornata («si ragiona <strong>di</strong> chi, da <strong>di</strong>verse cose infestato, sia, oltre<br />
<strong>alla</strong> sua speranza, riuscito a lieto fine») e nella terza.<br />
[Il versante ‘comico’] Ma a questi due temi almeno due altri se ne debbono aggiungere,<br />
entrambi appartenenti al registro ‘basso’ o comico della narrativa: il motto, che dà la materia alle<br />
novelle della sesta giornata (dove si racconta dei «leggiadri motti» e delle «pronte risposte» che i<br />
personaggi trovano per venire a capo <strong>di</strong> una situazione spinosa); e la beffa, che è al centro delle<br />
novelle dell’ottava giornata (dove, come recita la rubrica che la introduce, «si ragiona <strong>di</strong> quelle<br />
beffe che tutto il giorno o donna ad uomo, o uomo a donna, o l’uno uomo all’altro si fanno»). Una<br />
parte considerevole delle novelle decameroniane – e tra queste alcune delle più famose – è scritta<br />
infattii col principale scopo <strong>di</strong> far ridere, e ciò avviene o per l’uso pronto ed arguto della parola da<br />
parte dei protagonisti o per il genio da essi <strong>di</strong>mostrato nel mettere nel sacco i loro interlocutori. Così<br />
- per illustrare il primo caso: l’abilità nell’uso delle parole - Guido Cavalcanti zittisce con una<br />
battuta un gruppo <strong>di</strong> buontemponi che volevano prendersi gioco <strong>di</strong> lui (nov. VI 9). Oppure, così<br />
frate Cipolla rime<strong>di</strong>a ad una beffa che due giovani avevano macchinato contro <strong>di</strong> lui: i due<br />
sostituiscono la penna che frate Cipolla spacciava per una reliquia (una piuma dell’arcangelo<br />
Gabriele) con un pugno <strong>di</strong> carbone; il frate se ne accorge tar<strong>di</strong>, durante l’omelia, ma non si perde<br />
d’animo: un nuovo miracolo – sostiene – ha trasformato la penna nei carboni coi quali «fu arrostito<br />
san Lorenzo», la cui festa, non per caso, ricorre «<strong>di</strong> qui a due dì» (nov. VI 10). E così – per<br />
illustrare il secondo caso: capacità <strong>di</strong> ingannare il prossimo – lo sfrontato ser Ciappelletto riesce a<br />
darla a bere al prete che lo confessa in punto <strong>di</strong> <strong>morte</strong>, e dopo una vita spesa nel vizio e nel crimine<br />
viene seppellito in terra consacrata e in fama <strong>di</strong> santità (nov. I 1). Oppure, così allo sciocco<br />
Calandrino viene fatto credere <strong>di</strong> essere invisibile (nov. VIII 3).<br />
[Il nuovo realismo boccacciano] Si tratta, scrive Boccaccio nel Proemio, <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> «ne’<br />
moderni tempi avvenuti come negli antichi». Una parte delle novelle s’ispira in effetti <strong>alla</strong> storia e<br />
<strong>alla</strong> letteratura antica, o situa nell’antichità – o in un mondo <strong>di</strong>verso da quello contemporaneo – la<br />
trama del racconto: è la componente eru<strong>di</strong>ta della poetica <strong>di</strong> Boccaccio, che già aveva fatto le sue<br />
prove nel Filocolo, e che ispirerà le opere latine della maturità. Ma l’importanza del Decameron<br />
risiede soprattutto nelle novelle sui ‘costumi contemporanei’. Attraverso <strong>di</strong> esse entra nella<br />
letteratura <strong>italiana</strong> la realtà umana nelle sue più varie manifestazioni: veri citta<strong>di</strong>ni, veri borghesi,<br />
donne e uomini reali sono i protagonisti della narrazione, e le loro non sono le sublimi passioni che<br />
erano state cantate nell’epica o nei romanzi cavallereschi, ma le comuni passioni che sono proprie<br />
<strong>di</strong> ogni essere umano. Sicché, se anche spesso il tema del racconto non è originale perché Boccaccio<br />
recupera (e talvolta ripete pari pari) i modelli della novellistica classica, me<strong>di</strong>olatina o volgare,<br />
l’ambientazione – l’Italia contemporanea, e la città <strong>di</strong> Firenze in particolare – sortisce sempre effetti<br />
<strong>di</strong> notevole realismo. Ed è in questa lezione – la rappresentazione della vita così come essa è, senza<br />
le idealizzazioni che erano state caratteristiche della letteratura cortese, e senza i moralismi degli<br />
exempla cristiani – il lascito più duraturo del Decameron <strong>alla</strong> tra<strong>di</strong>zione narrativa occidentale, e<br />
insieme la ragione della sterminata fortuna <strong>di</strong> cui il libro godrà nei secoli successivi.<br />
[Lo stile] Non dello stile del Decameron bisognerebbe parlare, bensì degli stili, al plurale. Il<br />
linguaggio reagisce e si adegua, infatti, <strong>alla</strong> varietà dei registri e delle situazioni messe in scena<br />
67


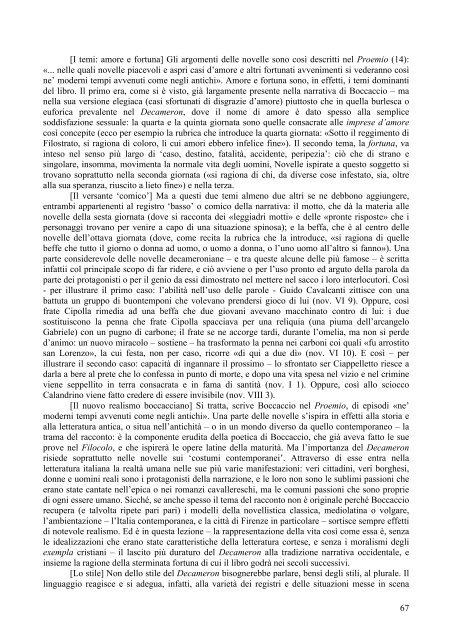






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
