Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
nelle novelle. Il Cinquecento apprezzò, e promosse a norma per tutti i prosatori, soprattutto il puro<br />
ed elegantissimo fiorentino che Boccaccio adopera nella cornice, quando parla in prima persona:<br />
una prosa elaborata, sintatticamente complessa, incline a sigillare i perio<strong>di</strong> con particolari figure<br />
ritmiche (quello che nella prosa latina viene definito cursus). Al polo <strong>di</strong>ametralmente opposto, lo<br />
stile delle novelle ‘comiche’ (per esempio quelle della sesta giornata) ebbe grande influenza sui<br />
novellieri ere<strong>di</strong> <strong>di</strong> Boccaccio. Non che la prosa narrativa anteriore a lui non conoscesse il registro<br />
‘basso’, tutt’altro, ma nel Decameron tale registro si arricchisce <strong>di</strong> molte ine<strong>di</strong>te sfumature. Per<br />
esempio, Boccaccio è consapevole delle potenzialità espressive dei <strong>di</strong>aletti, e se ne serve per la<br />
descrizione <strong>di</strong> ambienti e personaggi. Inoltre, egli è maestro nella resa del <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong>retto: mentre i<br />
narratori che lo hanno preceduto prestavano le loro parole ai personaggi del racconto, senza alcun<br />
tentativo <strong>di</strong> caratterizzazione in<strong>di</strong>viduale, Boccaccio dà a ciascuno una voce <strong>di</strong>versa, anticipando<br />
quella ‘polifonia’ <strong>di</strong> linguaggi e <strong>di</strong> stili che sarà tipica del romanzo moderno. Ma c’è poi, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong><br />
raffinatezze come queste, il comico ‘puro’, il puro e semplice <strong>di</strong>vertimento verbale, e in tal caso<br />
Boccaccio non <strong>di</strong>sdegna <strong>di</strong> servirsi <strong>di</strong> artifici tra<strong>di</strong>zionali: giochi <strong>di</strong> parole, bisticci, doppi sensi o –<br />
come nell’esempio che segue, tratto d<strong>alla</strong> novella <strong>di</strong> frate Cipolla (VI x 17) – la figura fonica detta<br />
omeoteleuto (cioè l’identità <strong>di</strong> desinenza tra parole contigue in un testo in prosa): «egli [Guccio<br />
Imbratta, aiutante del frate] è tardo, sugliardo e bugiardo; negligente, <strong>di</strong>subi<strong>di</strong>ente e mal<strong>di</strong>cente;<br />
trascutato, smemorato e scostumato; senza che egli ha alcune altre teccherelle con queste, che si<br />
taccion per lo migliore».<br />
[Modelli e fonti] Così come è necessario parlare <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> stili, allo stesso modo<br />
sono molti i modelli ai quali Boccaccio può essersi ispirato per la costruzione del Decameron. Si è<br />
accennato <strong>alla</strong> tra<strong>di</strong>zione arabo-orientale della cornice; ma l’idea <strong>di</strong> una ‘narrazione <strong>di</strong> gruppo’<br />
poteva venire allo scrittore anche da testi classici come i Saturnalia <strong>di</strong> Macrobio o le Metamorfosi<br />
<strong>di</strong> Apuleio. Quanto <strong>alla</strong> peste e <strong>alla</strong> ‘brigata’ dei giovani, una possibile fonte figurativa è stata <strong>di</strong><br />
recente segnalata (Battaglia Ricci) negli affreschi raffiguranti il Trionfo della <strong>morte</strong> nel Camposanto<br />
monumentale <strong>di</strong> Pisa. Nelle singole novelle, Boccaccio sfrutta e contamina tra<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>sparate -<br />
non ultima quella per eccellenza inverificabile: la tra<strong>di</strong>zione orale – ed è dunque impossibile dare<br />
un quadro sintetico dei suoi ‘prelievi’. Ma, in sintesi, si consideri l’eccezionale ampiezza delle fonti<br />
boccacciane: oltre ad attingere <strong>dalle</strong> raccolte <strong>di</strong> ‘esempi’ in latino (come la Leggenda aurea <strong>di</strong><br />
Jacopo da Varazze) e in volgare (raccolte rivisitate, come si è accennato, secondo un’ottica laica e<br />
non moralistico-cristiana), egli conosce e riusa i testi latini (Apuleio, Ovi<strong>di</strong>o), i fabliaux (‘favole’) e<br />
le poesie francesi lette <strong>alla</strong> corte napoletana degli Angiò, le comme<strong>di</strong>e me<strong>di</strong>olatine oltre che,<br />
naturalmente, i ‘classici’ della giovane letteratura <strong>italiana</strong>: il Novellino, la Comme<strong>di</strong>a. A queste<br />
influenze colte si affianca infine la tra<strong>di</strong>zione popolare: i proverbi e gli aneddoti che circolavano a<br />
Firenze (per esempio, quello relativo <strong>alla</strong> «bella risposta» che Guido Cavalcanti dà ai suoi<br />
motteggiatori: novella VI 9)<br />
6.4 Le opere successive al «Decameron» e la fortuna <strong>di</strong> Boccaccio<br />
[Le Genealogie] Negli anni della piena maturità, dopo la scrittura del Decameron,<br />
Boccaccio abbandona le ‘favole’ romanzesche, liquida – secondo un cliché ben <strong>di</strong>ffuso nel<br />
Me<strong>di</strong>oevo – come errori giovanili le proprie poesie in volgare (che a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> Petrarca non<br />
raccoglierà mai in un volume unitario) e s’impegna in alcuni trattati eru<strong>di</strong>ti in latino. Un libro sulla<br />
mitologia classica era stato sollecitato a Boccaccio già attorno al 1350 da Ugo IV <strong>di</strong> Lusignano, re<br />
<strong>di</strong> Cipro. Ugo morì nel 1359, ma Boccaccio sod<strong>di</strong>sfece lo stesso il desiderio dell’antico committente<br />
lavorando, dai primi anni Sessanta sino <strong>alla</strong> <strong>morte</strong>, alle Genealogiae deorum gentilium (‘Genealogie<br />
degli dei pagani’). L’opera si articola in quin<strong>di</strong>ci libri: nei primi tre<strong>di</strong>ci - che compen<strong>di</strong>ano l’intero<br />
patrimonio della mitologia pagana, e che avranno grande influenza su letterati e pittori durante tutto<br />
il Rinascimento - Boccaccio riversa tutta la sua non comune cultura classica, ricorrendo, oltre che ai<br />
ben noti Virgilio e Ovi<strong>di</strong>o, anche ad Omero: grazie alle lezioni dell’eru<strong>di</strong>to Leonzio Pilato,<br />
Boccaccio possedeva infatti (quasi unico tra i suoi contemporanei) buoni ru<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> greco, e<br />
68


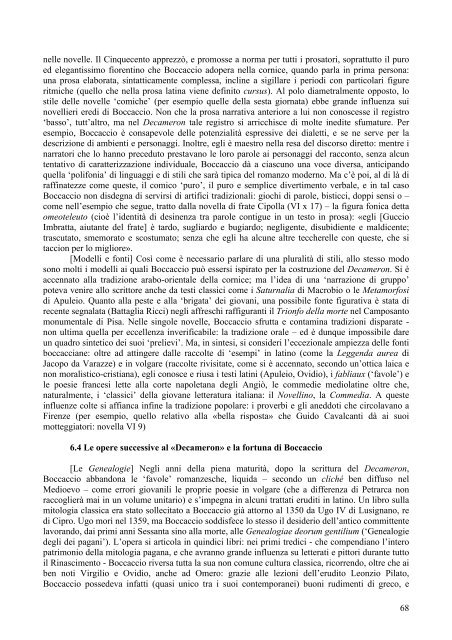






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
