Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Letteratura italiana: dalle Origini alla morte di ... - Claudio Giunta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
posteri»). Il secondo, scritto dopo una visita al fratello Gherardo monaco a Montreux (e infatti<br />
de<strong>di</strong>cato ai frati Certosini), è un paragone tra la vita serena dei monaci, che hanno rinunciato al<br />
mondo, e le pene <strong>di</strong> chi, come Petrarca, nel mondo è ancora coinvolto.<br />
[Il Bucolicum carmen] La presenza del soggetto, l’autobiografismo che si è detto essere<br />
presente nel Petrarca saggista degli anni Quaranta lascia tracce cospicue anche nelle egloghe latine<br />
del Bucolicum carmen. Si tratta <strong>di</strong> 12 egloghe scritte tra il 1346 e il 1348 e poi – secondo un<br />
costume tipico <strong>di</strong> Petrarca - a più riprese rimaneggiate. Come già ricordato per Dante (cfr. § 4.8),<br />
l’egloga pastorale è un genere <strong>di</strong> antica tra<strong>di</strong>zione classica in cui viene rappresentata la vita dei<br />
campi attraverso il <strong>di</strong>alogo tra i pastori. Petrarca imita questo modello, ma se ne serve per parlare,<br />
sotto un pesante velo allegorico, <strong>di</strong> temi che lo riguardano personalmente: l’amore per Laura,<br />
l’ambizione letteraria, i rapporti con i Colonna; oppure delle vicende politiche contemporanee: la<br />
<strong>morte</strong> <strong>di</strong> Roberto d’Angiò e la crisi del regno napoletano, le lotte tra le famiglie romane.<br />
[Il De reme<strong>di</strong>is] Negli anni Cinquanta, Petrarca vive prevalentemente a Milano, presso i<br />
Visconti. Qui conclude, in breve tempo (ma come sempre vi saranno, negli anni successivi, ritocchi<br />
e aggiunte), il grande trattato morale De reme<strong>di</strong>is utriusque fortunae (‘Sui rime<strong>di</strong> per la buona e la<br />
cattiva fortuna’) una sorta <strong>di</strong> guida <strong>alla</strong> retta vita in cui si insegna a far fronte <strong>alla</strong> buona (primo<br />
libro) o <strong>alla</strong> cattiva sorte (secondo libro). La struttura dell’opera è molto semplice, e prossima a<br />
quella <strong>di</strong> molti trattati me<strong>di</strong>evali: la Ragione <strong>di</strong>aloga nel primo libro con la Gioia e la Speranza (122<br />
<strong>di</strong>aloghi), nel secondo con il Dolore e il Timore (131 <strong>di</strong>aloghi), e pacatamente corregge l’eccessiva<br />
euforia o l’eccessivo sconforto dei suoi interlocutori, spiegando come affrontare i <strong>di</strong>versi casi della<br />
vita: gli incarichi pubblici, le cure familiari, la guerra, la ricchezza, le calamità naturali, la <strong>morte</strong> dei<br />
propri cari e la propria, ecc. È, s’intende, una Ragione che s’ispira, oltre che <strong>alla</strong> Bibbia, ai gran<strong>di</strong><br />
saggi dell’età classica: «La conoscenza dell’antichità viene umanisticamente subor<strong>di</strong>nata al frutto<br />
che se ne può trarre nella vita, alle norme che ne derivano per il vivere <strong>di</strong> ogni giorno» (Branca).<br />
Grazie a questa universalità dei temi – il trattato parla in sostanza della vita umana in tutte le sue<br />
manifestazioni – e grazie <strong>alla</strong> semplicità della sua struttura ‘da manuale’, il De reme<strong>di</strong>is godette <strong>di</strong><br />
un’enorme <strong>di</strong>ffusione durante tutto il Rinascimento.<br />
[I Trionfi] A Milano, Petrarca inizia anche a lavorare ad un’opera poetica in volgare che lo<br />
terrà impegnato sino <strong>alla</strong> <strong>morte</strong> (su quello che nel progetto avrebbe dovuto essere l’ultimo canto<br />
Petrarca torna anche durante il 1374) e che tuttavia resterà incompiuta: i Trionfi. Si tratta <strong>di</strong> un<br />
poema in terzine chiaramente ispirato <strong>alla</strong> Comme<strong>di</strong>a dantesca: una visione nella quale Petrarca da<br />
un lato passa in rassegna i gran<strong>di</strong> spiriti del passato raccolti in ‘famiglie’, dall’altro riflette sul suo<br />
amore per Laura e sul suo destino ultraterreno. Due elementi assicurarono all’opera, nei due secoli<br />
successivi, una fortuna larghissima, paragonabile soltanto a quella del Canzoniere (insieme al quale<br />
venne più volte copiata e stampata): i dati autobiografici che vi sono <strong>di</strong>sseminati, e che dovevano<br />
suscitare grande curiosità tra i cultori del poeta; e – analogamente a quanto avviene nella Comme<strong>di</strong>a<br />
- l’unione <strong>di</strong> cultura classica e cristiana, cioè la rappresentazione <strong>di</strong> personaggi appartenenti al<br />
mondo greco-latino all’interno <strong>di</strong> una struttura simbolica or<strong>di</strong>nata secondo i princìpi della morale<br />
cristiana.<br />
[La trama] Articolato in sei trionfi, ciascuno <strong>di</strong>viso in uno o più canti, il poema è il<br />
resoconto <strong>di</strong> una visione. In un giorno <strong>di</strong> aprile (il sesto: e il sei aprile del 1327 Petrarca sostiene<br />
infatti <strong>di</strong> aver incontrato per la prima volta Laura), il poeta si trova – come il suo modello, Dante –<br />
‘smarrito’. Il percorso che il poeta compie <strong>di</strong> qui in poi è scan<strong>di</strong>to dall’incontro con una lunghissima<br />
schiera <strong>di</strong> defunti illustri: Petrarca contempla prima il Triumphus Cupi<strong>di</strong>nis (‘trionfo d’Amore’): il<br />
carro del ‘<strong>di</strong>o’ è seguito dagli spiriti che durante la loro vita vennero vinti dall’amore. Si tratta<br />
soprattutto <strong>di</strong> ‘coppie celebri’ prelevate dal mito o d<strong>alla</strong> storia classica (si veda per esempio il lungo<br />
episo<strong>di</strong>o relativo agli amori <strong>di</strong> Sofonisba e Massinissa, l’alleato <strong>di</strong> Scipione l’Africano), ma non<br />
mancano le coppie ‘moderne’, come Dante e Beatrice: né manca, <strong>alla</strong> fine del corteo, un posto per<br />
lo stesso Petrarca, vittima dell’amore per Laura. I canti successivi rappresentano una sorta <strong>di</strong><br />
integrazione e <strong>di</strong> superamento del Trionfo dell’Amore. Mentre prosegue la rassegna dei gran<strong>di</strong><br />
spiriti defunti (ed è questa la parte dell’opera meno vicina al nostro gusto, per l’affollarsi<br />
59


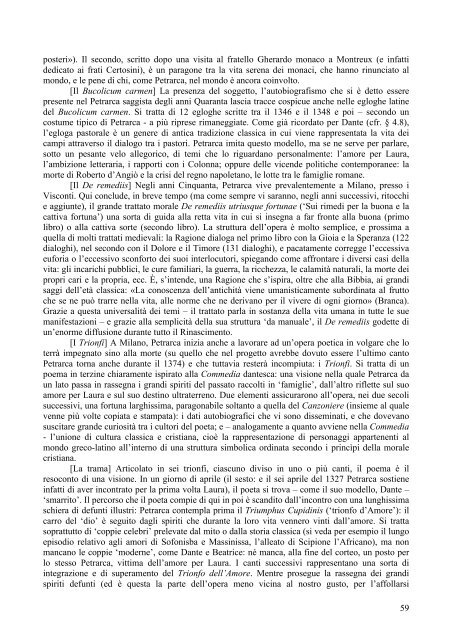






![Il disastro dell'informazione in Italia [PDF] - Claudio Giunta](https://img.yumpu.com/15119341/1/184x260/il-disastro-dellinformazione-in-italia-pdf-claudio-giunta.jpg?quality=85)
