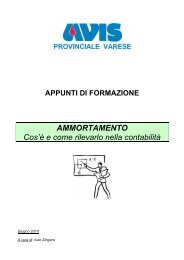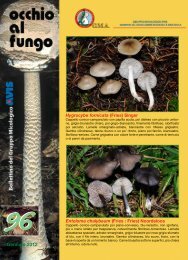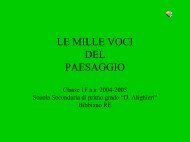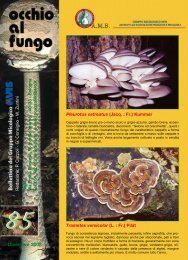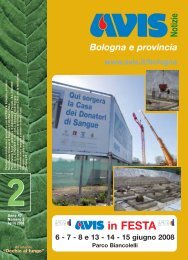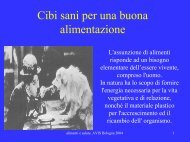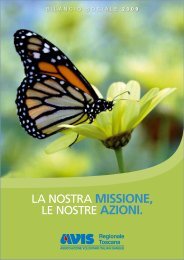Ricerca Immigrati_impaginato(.Pdf 1.8 MB) - Avis
Ricerca Immigrati_impaginato(.Pdf 1.8 MB) - Avis
Ricerca Immigrati_impaginato(.Pdf 1.8 MB) - Avis
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
solo. Anzi, una varietà di fattori teoreticamente distinti si combinano<br />
per produrre gli effetti che osserviamo [Ibid., p.553].<br />
In tutt’altra direzione sembra andare il lavoro di Johannesson e Mellstrom [2005],<br />
che si chiedono già dal titolo del loro saggio se Titmuss aveva ragione<br />
nell’incentivare le donazioni gratuite. Lo studio si basa su di un esperimento condotto<br />
in Svezia su soggetti non donatori, divisi in maschi e femmine. I ricercatori<br />
offrono tre differenti opportunità: diventare donatori senza alcuna forma di pagamento,<br />
oppure dietro pagamento di 50 corone (circa sette dollari), infine scegliere<br />
se tenere le 50 corone o donarle per opere caritatevoli, e giungono alle seguenti<br />
conclusioni:<br />
La risposta al quesito posto nel titolo sembra essere un sì condizionato.<br />
Per quanto riguarda le donne, l’ipotesi di Titmuss di un “effetto<br />
di spiazzamento” [crowding out effect] riceve un supporto empirico<br />
dai dati raccolti. L’effetto è anche quantificabile. L’introduzione di sistemi<br />
di pagamento riduce le scorte di sangue di quasi la metà. Per<br />
gli uomini non abbiamo trovato alcun effetto di spiazzamento. Abbiamo<br />
anche mostrato come l’effetto di spiazzamento possa esser<br />
ridotto permettendo agli individui di donare il compenso in opere di<br />
carità. I nostri risultati hanno importanti implicazioni politiche. Suggeriscono<br />
in effetti che lo scetticismo con cui in molti paesi si giudicano<br />
le formule di pagamento per le donazioni di sangue, sia giustificato<br />
nei fatti. Ma i nostri risultati suggeriscono anche che il potenziale<br />
problema dell’introduzione di un pagamento in denaro può essere risolto<br />
semplicemente aggiungendo l’opzione dell’opera di carità<br />
spendibile con quegli stessi soldi [op.cit. p.12].<br />
Concludo questa prima parte con la citazione di Johansson e Mellstrom per cercare<br />
di mitigare il j’accuse da più parti rivolto a Titmuss. Vorrei comunque aggiungere<br />
una considerazione. L’introduzione delle domande-test, che intendono fornire<br />
un quadro complessivo del presunto stato di salute psico-fisica del donatore,<br />
interviene profondamente nell’immagine di sé di chi vuole donare. Questo cambiamento,<br />
resosi necessario all’indomani della scoperta delle nuove malattie<br />
emotrasmissibili al fine di tracciare un quadro il più esauriente possibile delle abitudini<br />
comportamentali del donatore, provoca uno scarto profondo rispetto<br />
all’impostazione del lavoro di Richard Titmuss. Anzitutto, molto prosaicamente,<br />
una perdita di tempo, che all’atto della prima donazione può determinare ripensamenti<br />
[Hollingsworth e Wildman 2004, p.10]. Questa perdita di tempo, in realtà,<br />
maschera il reale costo del sangue, “…che nei fatti è assorbito dai donatori. Purtroppo,<br />
quei costi diventano nuovamente visibili per l’esistenza di un mercato parallelo<br />
del sangue nelle strutture che lavorano per profitto. Ci si chiede: è eticamente<br />
corretto che i donatori assorbano molti di quei costi sotto l’apparenza<br />
78