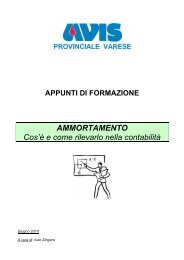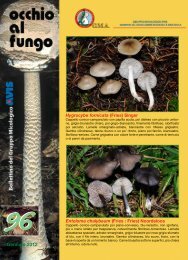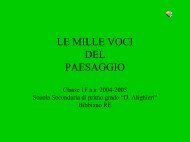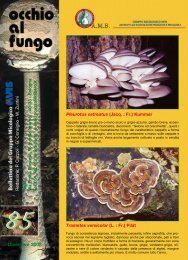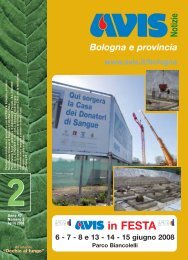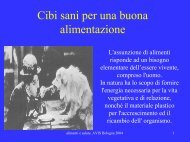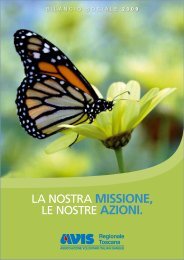Ricerca Immigrati_impaginato(.Pdf 1.8 MB) - Avis
Ricerca Immigrati_impaginato(.Pdf 1.8 MB) - Avis
Ricerca Immigrati_impaginato(.Pdf 1.8 MB) - Avis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Come si vede, le interpretazioni possono essere molto variegate. Mi sentirei di<br />
affermare che non esiste un profilo 30 di un donatore che possiede requisiti specifici.<br />
Si tratterebbe di rendere naturali comportamenti che sono certamente mediati<br />
da processi culturali. Proprio in questa poliedricità si cela il mio convincimento:<br />
applicare le stesse procedure in contesti differenti è dimostrato che non funziona<br />
31 .<br />
30 La questione è stata analizzata anche dal punto di vista psicologico-sociale. Il lavoro di Piliavin,<br />
Callero [1991] si inserisce nel filone di ricerche, nate dopo la Seconda Guerra Mondiale,<br />
che si interessavano ai fattori che riguardavano lo sviluppo dell’altruismo come pratica sociale.<br />
Al termine di una lunga ricerca sul terreno, di circa dieci anni, i due psicologi sociali giungono<br />
alla conclusione che donatori impegnati si diventa, non si nasce. Il loro interesse si accentra<br />
particolarmente sulla comprensione dei processi che trasformano un donatore saltuario nella<br />
figura di quello che loro definiscono “altruistic deviant”. Lo sviluppo complessivo del lavoro<br />
assume rilevanza dal punto di vista pratico e teoretico. Pratico perché gli autori forniscono<br />
strumenti utili alle associazioni di raccolta per trasformare i donatori saltuari i donatori più efficienti<br />
e continui; teoretico perché esplorano vari modelli tratti dalla psicologia sociale per comprendere<br />
quali siano i puntelli dell’altruismo nel momento in cui si decide di donare. Fernàndez-Montoya,<br />
A., Lòpez-berrio, A., Luna del Castello, 1998, analizzano come l’aspetto psicologico<br />
del donatore si evolva nel tempo. In uno studio di sette anni su 126 donatori che hanno<br />
mantenuto costante il loro impegno, dichiarano che dalle interviste risulta che la motivazione<br />
di base rimane pressoché inalterata, con la percezione dell’altruismo come causa principale<br />
del proseguimento della propria opera di donazione [cfr. p. 145]. Sviluppano, infine, conclusioni<br />
che concordano con AA.VV. 2005: la specificità dei messaggi da lanciare per il reclutamento<br />
riveste molta importanza: se l’enfasi sull’altruismo può far presa sullo spirito di ex donatori,<br />
“I messaggi rivolti ai non-donatori dovrebbero enfatizzare l’inevitabile necessità della donazione<br />
(per esempio nelle sue pratiche e concrete conseguenze) e trasmettere al tempo<br />
stesso la facilità con cui si può fare una donazione”. [Fernandez-Montoya, op. cit. p.146]. Lee,<br />
Piliavin, Call [1999] cercano di sviluppare un modello teorico dell’identità del donatore che sia<br />
compatibile con tre differenti forme di dono: volontariato (tempo), soldi, sangue. Le conclusioni<br />
riferiscono che la teoria sviluppata in Piliavin, Callero, 1991 [supra] può essere generalizzata<br />
ed applicata a tutte e tre le forme di altruismo. Ma, nello specifico, l’identità di coloro che<br />
donano il sangue presenta particolarità che la rendono unica. Essa risulta maggiormente influenzata,<br />
rispetto alle altre forme di volontariato, dal ruolo ricoperto dai genitori e<br />
dall’esperienza vissuta nella socializzazione con gli adulti; inoltre, i sentimenti dettati dalla moralità<br />
intesa come obbligo verso gli altri, hanno un effetto assai più forte sulla formazione identitaria<br />
di un donatore di sangue. Alcuni autori vedono addirittura nell’appagamento fisico uno<br />
dei motivi ricorrenti nella fidelizzazione dei donatori: i risultati del lavoro di Nilssonn, Sojka<br />
[2003] condotto in Svezia, ci dicono che circa 151 intervistati sui 528 complessivi dello studio<br />
dichiarano di sentire molti influssi benefici dopo la donazione. Consideriamo i motivi adotti per<br />
donare: l’elenco parte sempre dall’altruismo, dal bisogno di fare del bene, ma, alla luce di<br />
questi risultati, perché non chiedersi se anche l’auto-appagamento fisico non possa rientrare<br />
fra le cause che mantengono il donatore fedele? Criticamente mi chiedo perché questa prospettiva<br />
sia così poco presa in considerazione.<br />
31 “Un altro problema è costituito dal fatto che i programmi di raccolta sangue ottengano risultati<br />
differenti a seconda dell’area geografica. In generale, le aree rurali e le piccole città possiedono<br />
una percentuale di donatori superiore a quella presente nelle grandi città. Si è teorizzato<br />
che il senso di appartenenza alla comunità e il bisogno di supporto reciproco siano più<br />
forti nelle aree rurali e nei villaggi. Ma è vero altresì che alcune zone rurali forniscono pochissimi<br />
donatori mentre grandi città ne hanno molti, in percentuale. Anche i dati demografici hanno<br />
la loro importanza. E’ stata osservata una grande partecipazione in zone dove la popola-<br />
90