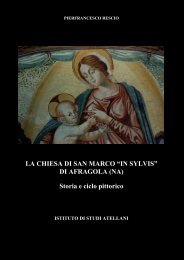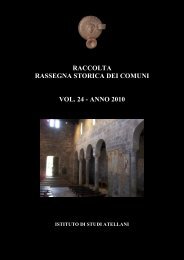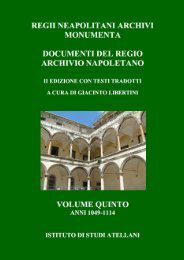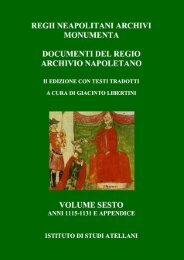raccolta rassegna storica dei comuni vol. 4 - anno 1972
raccolta rassegna storica dei comuni vol. 4 - anno 1972
raccolta rassegna storica dei comuni vol. 4 - anno 1972
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verso il mezzogiorno del 26 febbraio 1266, Carlo D'Angiò, frendens sicut aper dentibus<br />
dai colli circostanti, compresi fra S. Vitale e la Fasanella, fu in vista di Benevento,<br />
chiusa fra i due suoi fiumi in piena ed irta di torri, e scorse l'esercito di Manfredi, già<br />
schierato in ordine di battaglia, (ad quendam montem, narra l'Angioino nella «Lettera a<br />
papa Clemente IV», perveni, unde subiectus, et admodum patens campus ordinatas iam<br />
hostium acies ostendebat). Al conte di Provenza non sembrò vero poter dare subito<br />
inizio alle ostilità per metter fine all'incubo della mancanza di vettovaglie ed al logorio<br />
fisico <strong>dei</strong> suoi uomini; sulla decisione <strong>dei</strong> due rivali «influì - afferma il Gregorovius - la<br />
disperazione». Il cozzo fu tremendo: «i Francesi - ci rammenta Giovanni Villani -<br />
cominciarono a colpire, contro le regole della cavalleria, i cavalli, per la qualcosa in<br />
piccola ora i tedeschi furono molto malmenati e molto abbattuti e quasi in sconfitta<br />
<strong>vol</strong>ti».<br />
Manfredi <strong>vol</strong>le, allora, giocare una carta decisiva entrando in battaglia con la sua<br />
schiera, ma «la maggior parte <strong>dei</strong> baroni pugliesi e del Regno, o per viltà di cuore, o<br />
veggendo che essi avevano la peggio o - ci fu chi disse - per tradimento, come gente<br />
infedele e vaga di nuovo signore, fallirono a Manfredi abbandonandolo e fuggendo chi<br />
verso gli Abruzzi e chi verso la città di Benevento». Il giovane sovrano, «rimasto con<br />
pochi, fece come valente signore»: spronò il cavallo e, accompagnato dal prode romano<br />
Teobaldo Anibaldi, si gettò nella mischia, cadendo da eroe. In poche ore alcune migliaia<br />
di uomini avevano deciso, in una «piccola battaglia», le sorti di un regno, il destino della<br />
penisola italiana, l'immortalità di un sovrano.<br />
* * *<br />
Qual era la «planitia pulcherrima», il «patens campus», dove Angioini e Svevi si<br />
affrontarono in quella fatidica giornata? Qual è il ponte, «presso a Benevento» dove<br />
trovò sepoltura il sovrano «biondo e di gentile aspetto?» L'incertezza ha origini<br />
antichissime, perché mentre i cronisti siciliani sostengono che la battaglia avvenne apud<br />
pontem Valentinum in partibus Beneventi, quelli fiorentini indicano la pianura di Roseto<br />
ubi S. Maria della Gradelle dicitur. Nemmeno gli storici più recenti (Zazo, Rotili,<br />
Hagemann, Petroccia) sono riusciti a risolvere tale vexata quaestio che da sette secoli<br />
affascina gli studiosi di molti Paesi.<br />
E' ormai opinione comune che l'esercito di Manfredi, costituito da circa 15.000 uomini -<br />
accampato fuori dalla cinta muraria, sul colle di San Marco oggi Capodimonte - alla<br />
notizia dell'arrivo del nemico, per sbarrargli il passo verso Lucera e vietargli di occupare<br />
Benevento, abbia varcato il ponte sul Calore e si sia schierato in assetto di battaglia in<br />
una vasta pianura: «vidimus - scrive Ugo Del Balzo che era al seguito di Carlo D'Angiò -<br />
in quodam planitia pulcherrima, Manfridum quondam principem cum toto exercitu<br />
suo».<br />
Nelle vicinanze del colle di San Marco esisteva soltanto il vadum carrarum sancti<br />
Marciani, attraverso il quale si poteva raggiungere la chiesa di San Marciano e la vasta<br />
pianura omonima. Il fiume in piena (ciò è attestato da Saba Malaspina e dal continuatore<br />
dell'Historia del Iasmilla, i quali affermano che molti soldati svevi furono tra<strong>vol</strong>ti, nella<br />
fuga, dalle onde impetuose del fiume) dovette costringere gli Svevi a servirsi di uno <strong>dei</strong><br />
ponti che mettevano in <strong>comuni</strong>cazione la città con le terre vicine.<br />
Oltre al ponte Valentino (nei pressi dell'attuale stazione di Paduli sulla via Traiana), al<br />
ponte Leproso sul Sabato (attraverso il quale l'Appia entrava in città) ed a quello di S.<br />
Barbara (oggi Santa Maria degli Angeli), ne dovevano esistere almeno altri due: il primo<br />
detto Pons Maior, o Ponte Fratto, alle spalle del tempio della Madonna delle Grazie (al<br />
quale metteva capo la via Latina); il secondo, invece, doveva essere situato fra il vadum<br />
carrarum sancti Marciani e Pons Maior: esso convogliava in città il traffico proveniente<br />
153