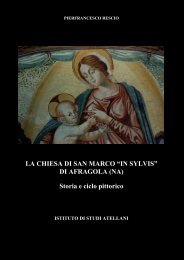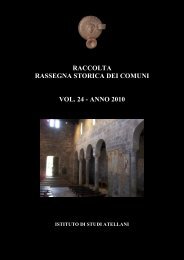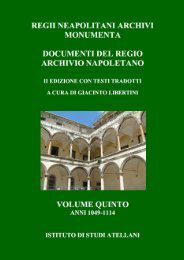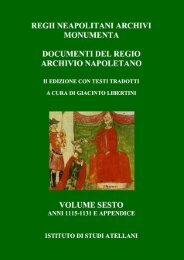raccolta rassegna storica dei comuni vol. 4 - anno 1972
raccolta rassegna storica dei comuni vol. 4 - anno 1972
raccolta rassegna storica dei comuni vol. 4 - anno 1972
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
innovatore. E la formazione di una borghesia agraria, auspicata dal Genovesi e dai suoi<br />
seguaci, che sull'esempio inglese e toscano avrebbe dovuto pacificamente sostituire la<br />
vecchia classe assenteista e sfruttatrice, si rivelava un'utopia.<br />
Ai riformatori del XVIII secolo sfuggiva la natura <strong>dei</strong> rapporti esistenti tra vescovo,<br />
clero nobiltà e massa <strong>dei</strong> fedeli.<br />
C'era, in sostanza, un distacco profondo tra le componenti di una società in cui le<br />
popolazioni erano soffocate dalla prepotenza della classe feudale che si serviva delle<br />
ordinazioni sacerdotali per dissacrare la proprietà ecclesiastica e per manovrarle contro i<br />
vescovi rigoristi. Non mancarono vescovi di grande pietà e di ferma dottrina come<br />
l'Anzani e Campagna e il Feliceo a Policastro, i quali, con la loro efficace azione<br />
pastorale, si presentarono come gli antagonisti di quella torbida realtà e «tentarono di<br />
rompere il blocco della magia, della prepotenza baronale e dell'ignoranza clericale che<br />
aveva immobilizzato in una struttura economica e sociale a caste, la vita del popolo del<br />
Mezzogiorno». I sinodi che si susseguirono nel periodo preso in esame dal De Rosa,<br />
scaturiti dalla preoccupazione di riportare la vita ecclesiastica e religiosa locale nei<br />
limiti delle norme fissate dal Concilio di Trento, erano ostacolati dal clero e dal popolo<br />
che scorgevano in quelle assemblee un attentato all'irrazionale evasione dalla dura realtà<br />
quotidiana.<br />
Dopo la realizzazione dell'unità d'Italia, la borghesia predatoria e scarsamente<br />
imprenditoriale, inseritasi col metodo del trasformismo nel contesto dello Stato italiano,<br />
perfettamente amalgamata con il vecchio blocco magico-clericale-baronale, aveva<br />
mantenuto inalterata l'arretrata struttura economica del Sud. I rimedi proposti da Sturzo<br />
- al quale è dedicato il VI capitolo - per strappare le popolazioni del Mezzogiorno al<br />
fatalismo di una tradizione di miseria, d'ignoranza e di superstizione si rivelano atti di<br />
fede sia quando tratta di una politica regionalistica, sia quando sogna una politica a<br />
sbocco mediterraneo che fosse condivisa dallo Stato unitario.<br />
Col sorgere della «questione meridionale» affiorano via via le varie ipotesi di soluzione<br />
<strong>dei</strong> problemi da essa derivanti da parte degli esponenti delle varie tendenze politiche. I<br />
socialisti anarchici ritenevano la miseria del Sud il mezzo indispensabile per<br />
promuovere insieme con il proletariato della città la «ri<strong>vol</strong>uzione sociale». Per i<br />
socialisti riformisti, invece, il Mezzogiorno costituiva la «palla di piombo» che frenava<br />
la marcia della ri<strong>vol</strong>uzione. Gramsci, staccatosi dall'interpretazione economistica del<br />
riformismo, inserisce in un contesto leninista il nucleo dell'impostazione<br />
anarchico-bakuniana e sostiene che lo avvenire della ri<strong>vol</strong>uzione sarebbe scaturito<br />
dall'alleanza fra il proletariato urbano e i contadini. Con Gramsci si perviene ad un<br />
superamento della tradizione contemplativa del meridionalismo e si esaurisce la<br />
suggestione del fisiocratismo genovesiano ancora presente nelle enunciazioni di<br />
Giustino Fortunato. La fase del «riformismo agrario», dello «spezzettamento agrario»,<br />
della «quotizzazione <strong>dei</strong> demani» appare anacronistica nell'età del capitalismo<br />
industriale. Circa la problematica della natura del clero meridionale e <strong>dei</strong> suoi rapporti<br />
con la Chiesa e i contadini, Gramsci afferma che la funzione spirituale del clero,<br />
appartenente ai vecchi gruppi intellettuali trasformistici, è distorta dalla sua<br />
subordinazione strumentale agli interessi degli agrari, mentre Bakunin sostiene che i<br />
contadini, pur essendo superstiziosi e non religiosi, contribuiscono a rafforzare i preti<br />
nelle campagne con i quali dividono gli affanni e la miseria della vita rurale.<br />
Sturzo, fiducioso nella «convertibilità» del clero meridionale, ne auspica la<br />
trasformazione attraverso un'ordinazione selezionata da parte della Chiesa e il<br />
contributo del laicato cattolico troppo spesso impegnato nella lotta politica in una direzione<br />
contraria allo schieramento clerico-moderato. Egli spera, altresì, che il clero,<br />
inserito in una società di «democrazia rurale», di «comunalismo precapitalistico», possa<br />
contribuire al processo di trasformazione della società in modo che esso si compia al<br />
216