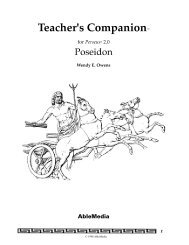THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
voce Lucrezio nel suo De rerum natura, mostrando<br />
quanto essa sia assurda ed assolutamente inadatta<br />
a rispondere a tutte le domande che l’uomo<br />
si pone sul mistero della vita e della morte.<br />
13. Escatologica, nel senso di «pertinente<br />
all’interpretazione dei destini ultimi dell’uomo e dell’universo».<br />
14. Esoterico, vale a dire: «segreto», «riservato<br />
solo agli iniziati».<br />
15. La Scuola filosofica stoica, fondata da<br />
Zenone di Cizio, fu aperta in Atene nel III secolo<br />
a.C. nello Stoa Pecile (ÛÙÔa appleÔÈΛÏË, Stoá poikílë,<br />
«portico dipinto»), nel portico ornato delle pitture<br />
di Polignoto. I principali maestri della Scuola<br />
furono, oltre Zenone, Cleante di Asso e Crisippo<br />
di Soli. Lo stoicismo ebbe cinque secoli di vita e<br />
viene distinto uno stoicismo greco ed uno stoi-<br />
cap. II - Caratteri generali dell’età cesariana 13<br />
giosa si erano preannunciati già nel secolo precedente e, con essi, si era diffusa<br />
in Roma la tendenza ad accogliere quei culti religiosi a carattere misterico<br />
e di provenienza orientale, che meglio rispondevano alle mutate esigenze della<br />
progredita coscienza morale dei cittadini e alle loro più accentuate necessità<br />
spirituali (cfr. vol. I, IX 3, pag. 89).<br />
Ora, in un clima di generale confusione, in una temperie di gravi tensioni, di<br />
delusioni, di incertezze, di angosce e paure, l’homo humanus, che intanto è<br />
venuto a formarsi sostituendosi al vir bonus di catoniana tradizione, sente che<br />
l’arida religione di Stato così vuota, così astratta, così formale, è del tutto inadatta<br />
a soddisfare le profonde istanze della sua anima, comprende che essa non<br />
è assolutamente in grado di dare convincenti risposte ai suoi dubbi, alle sue<br />
ansie, alle sue paure. Perciò, diventa ancora più naturale e accentuato in questi<br />
anni il fenomeno delle frequenti conversioni dei cittadini alle religioni misteriche,<br />
vale a dire a quelle religioni orientali nelle quali molta parte aveva la preoccupazione<br />
escatologica 13 e che, attraverso riti segreti di iniziazione, consentivano<br />
al fedele la comunione mistica col dio, che si mostrava sollecito d’ogni sua necessità<br />
o paura e garante della sua salvezza e sopravvivenza ultraterrena. I culti a<br />
carattere misterico e orgiastico più diffusi in Roma, in questo periodo sono quelli<br />
relativi alla dea Cibele (la Magna Mater), originaria della Frigia, al dio Dioniso (o<br />
Bacco), di provenienza orientale, ed agli dèi egiziani Iside, Osiride e Serapide.<br />
Accanto a questi culti, in questi stessi anni, sono molto seguite in Roma<br />
alcune filosofie, che, per il loro carattere esoterico 14, risultano molto affini alle<br />
religioni misteriche. Di queste filosofie la più diffusa, soprattutto per opera di<br />
Publio Nigidio Fìgulo, è il neopitagorismo, che prometteva agli adepti la salvezza<br />
e la sopravvivenza ultraterrena, dopo la purificazione ottenuta attraverso l’ascetismo.<br />
Alle religioni misteriche si rivolgono, naturalmente, soprattutto le classi<br />
popolari, perché quelle colte ed elevate trovano l’appagamento delle loro necessità<br />
spirituali e della loro sete di conoscenza nello studio delle varie dottrine filosofiche<br />
di provenienza ellenica, che, superati i pregiudizi e le diffidenze precedentemente<br />
incontrati in epoca arcaica e, con essi, le dure reazioni e opposizioni<br />
promosse dalla classe dirigente romana più chiusa e conservatrice, rappresentata<br />
allora in senato da Catone, risultano ora liberamente e comunemente diffuse<br />
in Roma.<br />
Lo stoicismo 15 aveva iniziato ad essere conosciuto in Roma già nel corso del<br />
II secolo a.C., allorché dal filosofo greco Panezio 16 era stato introdotto nel Circolo<br />
degli Scipioni ed era valso a dare un supporto e una giustificazione filosofica e illu-<br />
Le esigenze<br />
spirituali e<br />
religiose<br />
dell’homo<br />
humanus<br />
Le religioni<br />
misteriche<br />
Il<br />
neopitagorismo<br />
Lo stoicismo<br />
cismo romano. Allo stoicismo greco antico, subentrò<br />
in Roma, prima lo stoicismo medio di Panezio<br />
(II a.C.) e di Posidonio (I a.C.), suo discepolo e<br />
successore, poi il neostoicismo di Seneca (I d.C.),<br />
di Epìtteto (I-II d.C.) e di Marco Aurelio (II d.C.).<br />
La dottrina stoica professava il panteismo, secondo<br />
il quale il mondo è animato da una forza im -<br />
manente, la ragione cosmica, della quale l’anima<br />
è una parte. Se condo lo stoicismo il fine supremo<br />
della condotta umana è l’apa tìa, cioè l’«assenza<br />
di passioni», che si raggiunge mediante la virtù e<br />
il rigore morale, obbedendo alle ottime e inflessibili<br />
leg gi con le quali la divinità regge il mondo.<br />
Solo il sapiens riesce a conseguire 1’apatìa e la<br />
felicità, data la sua capacità di saper restare «imperturbabile»<br />
davanti a tutti gli eventi. Lo stoicismo<br />
ammetteva, inoltre, l’immortalità dell’anima, soste-