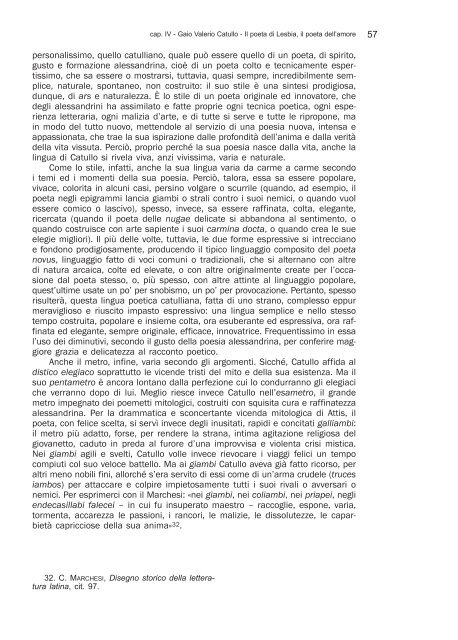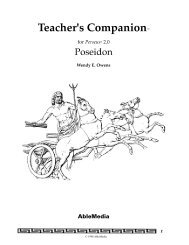THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
32. C. MARChESI, Disegno storico della letteratura<br />
latina, cit. 97.<br />
cap. IV - Gaio Valerio Catullo - Il poeta di Lesbia, il poeta dell’amore 57<br />
personalissimo, quello catulliano, quale può essere quello di un poeta, di spirito,<br />
gusto e formazione alessandrina, cioè di un poeta colto e tecnicamente espertissimo,<br />
che sa essere o mostrarsi, tuttavia, quasi sempre, incredibilmente semplice,<br />
naturale, spontaneo, non costruito: il suo stile è una sintesi prodigiosa,<br />
dunque, di ars e naturalezza. È lo stile di un poeta originale ed innovatore, che<br />
degli alessandrini ha assimilato e fatte proprie ogni tecnica poetica, ogni esperienza<br />
letteraria, ogni malizia d’arte, e di tutte si serve e tutte le ripropone, ma<br />
in modo del tutto nuovo, mettendole al servizio di una poesia nuova, intensa e<br />
appassionata, che trae la sua ispirazione dalle profondità dell’anima e dalla verità<br />
della vita vissuta. Perciò, proprio perché la sua poesia nasce dalla vita, anche la<br />
lingua di Catullo si rivela viva, anzi vivissima, varia e naturale.<br />
Come lo stile, infatti, anche la sua lingua varia da carme a carme secondo<br />
i temi ed i momenti della sua poesia. Perciò, talora, essa sa essere popolare,<br />
vivace, colorita in alcuni casi, persino volgare o scurrile (quando, ad esempio, il<br />
poeta negli epigrammi lancia giambi o strali contro i suoi nemici, o quando vuol<br />
essere comico o lascivo), spesso, invece, sa essere raffinata, colta, elegante,<br />
ricercata (quando il poeta delle nugae delicate si abbandona al sentimento, o<br />
quando costruisce con arte sapiente i suoi carmina docta, o quando crea le sue<br />
elegie migliori). Il più delle volte, tuttavia, le due forme espressive si intrecciano<br />
e fondono prodigiosamente, producendo il tipico linguaggio composito del poeta<br />
novus, linguaggio fatto di voci comuni o tradizionali, che si alternano con altre<br />
di natura arcaica, colte ed elevate, o con altre originalmente create per l’occasione<br />
dal poeta stesso, o, più spesso, con altre attinte al linguaggio popolare,<br />
quest’ultime usate un po’ per snobismo, un po’ per provocazione. Pertanto, spesso<br />
risulterà, questa lingua poetica catulliana, fatta di uno strano, complesso eppur<br />
meraviglioso e riuscito impasto espressivo: una lingua semplice e nello stesso<br />
tempo costruita, popolare e insieme colta, ora esuberante ed espressiva, ora raffinata<br />
ed elegante, sempre originale, efficace, innovatrice. Frequentissimo in essa<br />
l’uso dei diminutivi, secondo il gusto della poesia alessandrina, per conferire maggiore<br />
grazia e delicatezza al racconto poetico.<br />
Anche il metro, infine, varia secondo gli argomenti. Sicché, Catullo affida al<br />
distico elegiaco soprattutto le vicende tristi del mito e della sua esistenza. Ma il<br />
suo pentametro è ancora lontano dalla perfezione cui lo condurranno gli elegiaci<br />
che verranno dopo di lui. Meglio riesce invece Catullo nell’esametro, il grande<br />
metro impegnato dei poemetti mitologici, costruiti con squisita cura e raffinatezza<br />
alessandrina. Per la drammatica e sconcertante vicenda mitologica di Attis, il<br />
poeta, con felice scelta, si servì invece degli inusitati, rapidi e concitati galliambi:<br />
il metro più adatto, forse, per rendere la strana, intima agitazione religiosa del<br />
giovanetto, caduto in preda al furore d’una improvvisa e violenta crisi mistica.<br />
Nei giambi agili e svelti, Catullo volle invece rievocare i viaggi felici un tempo<br />
compiuti col suo veloce battello. Ma ai giambi Catullo aveva già fatto ricorso, per<br />
altri meno nobili fini, allorché s’era servito di essi come di un’arma crudele (truces<br />
iambos) per attaccare e colpire impietosamente tutti i suoi rivali o avversari o<br />
nemici. Per esprimerci con il Marchesi: «nei giambi, nei coliambi, nei priapei, negli<br />
endecasillabi falecei – in cui fu insuperato maestro – raccoglie, espone, varia,<br />
tormenta, accarezza le passioni, i rancori, le malizie, le dissolutezze, le caparbietà<br />
capricciose della sua anima» 32.