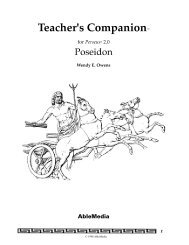THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
THESAURUS LITTERARUM LITTERARUM - AbleMedia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
12. Il Croce, infatti, così si esprimeva: «… quel<br />
Catullo per il quale suol venire sovente alle labbra<br />
di quelli che discorrono di lui come epiteto la parola:<br />
fanciullo». E ancora: «… È questa la bellezza della<br />
poesia catulliana: rendere una condizione elementare<br />
e quasi fanciullesca del sentire…» (B.<br />
CROCE, Poesia antica e moderna, Bari 1941; 1966 4,<br />
68-69).<br />
13. Afferma infatti il Marchesi: «… sfrenato,<br />
appassionato e bambino: caparbio nell’amore,<br />
caparbio nel dolore; … in lui la smania prevale<br />
sulla tristezza e la disperazione sul dolore»; e<br />
cap. IV - Gaio Valerio Catullo - Il poeta di Lesbia, il poeta dell’amore 39<br />
se stesso, rassegnato o dimesso, colmo di ricchezza interiore o di dolente spiritualità.<br />
Uomo di acuta e purissima sensibilità, Catullo rivela spesso, comunque, un’anima<br />
bellissima, che talora oseresti definire «fanciullesca», tanto essa è candida<br />
e schietta e pulita e innocente. Il Croce fu tra i primi a scoprire in Catullo quest’anima<br />
ingenua e fanciullesca 12 e, con lui, il Marchesi 13, il Bione 14 e altri. Ma<br />
non pochi critici, giudicarono invece diversamente 15, ponendo l’accento sulla pensosità,<br />
sulla malinconia, sull’intensità della vita interiore del poeta e sulla sua<br />
tendenza all’introspezione. E, in realtà, bisogna dire che le opposte interpretazioni<br />
espresse dai critici sulla personalità e sull’anima catulliana, in parte si possono<br />
spiegare con la particolare natura del poeta, spesso mutevole e contraddittoria.<br />
Ma tutto ciò non basta.<br />
Infatti, altri critici 16 sostennero la tesi della crescita, evoluzione e maturazione<br />
umana ed artistica di Catullo e questa in verità sembra anche a noi la via<br />
critica migliore da percorrere. Catullo giunge a Roma all’età di soli vent’anni,<br />
quand’è ancora poco più di un ragazzo. È questo il periodo dei suoi primi entusiasmi,<br />
delle sue prime delusioni, dei primi amori o dei primi odi o rancori, è<br />
questo il periodo dei primi, felici e segreti incontri d’amore con Lesbia: nascono<br />
ora le prime nugae. L’anima catulliana si rivela ora davvero candidamente fanciullesca,<br />
nel bene e nel male, nell’arte e nella vita. Esuberante ed egocentrico,<br />
il Catullo di questi primi anni romani sembra vivere solo del, e per il, suo amore:<br />
dei problemi della sua anima, e solo di essi, vorrebbe investire il mondo intero,<br />
perché ora egli sente e crede che solo il suo io sia al centro dell’universo. Poi,<br />
nel breve giro di pochi anni, dieci in tutto, Catullo matura, come uomo e come<br />
poeta: determinanti ed incisive diventano sempre più, ai fini della sua crescita,<br />
le tristi vicende del suo sciagurato amore per Lesbia. Alcuni carmina docta e<br />
molte nugae sicuramente testimoniano questa evoluzione. Ma, più che il dolore<br />
o le amarezze o le disavventure dovute all’infelice amore per Lesbia, la morte<br />
del fratello fu decisiva per la crescita e la maturazione definitiva del poeta. Con<br />
essa, Catullo finalmente scopriva anche gli altri, il loro mondo, la comune, umana<br />
sofferenza e, allora, la sua anima diventerà più ricca, la sua poesia si farà più<br />
profonda, più grande.<br />
L’anima<br />
«fanciullesca»<br />
Le diverse<br />
valutazioni<br />
critiche<br />
La tesi<br />
dell’evoluzione<br />
umana e<br />
poetica<br />
L’egocentrismo<br />
dei primi anni<br />
romani<br />
La<br />
maturazione<br />
dopo la morte<br />
del fratello<br />
altrove (Carmina V) il Marchesi scopre in lui l’allegria<br />
di un fanciullo felice e sospettoso (C.<br />
MARChESI, Storia della letteratura latina, I, Milano<br />
1969 8, 240; 250; 252).<br />
14. C. BIONE, Catullo poeta, Palermo 1946.<br />
15. Tra essi soprattutto il Della Corte (Due studi<br />
catulliani, Genova 1951).<br />
16. Cfr., soprattutto, L. FERRERO, Interpretazione<br />
di Catullo, Torino 1955; e F. ARNALDI, Antologia<br />
della poesia latina I, Napoli, 1957 4, 251-252 (qui<br />
riportate nelle Pagine critiche dedicate a Catullo).