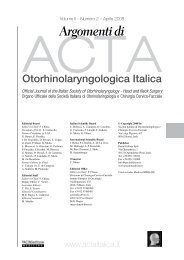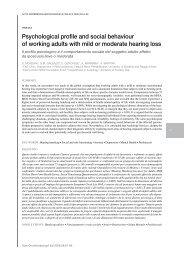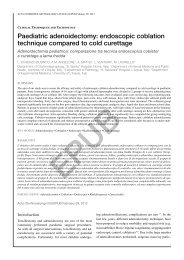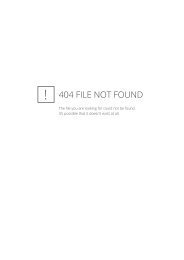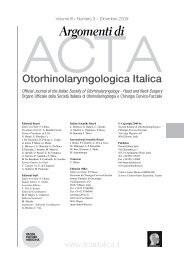argomenti 2.pdf - Acta Otorhinolaryngologica Italica
argomenti 2.pdf - Acta Otorhinolaryngologica Italica
argomenti 2.pdf - Acta Otorhinolaryngologica Italica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’approccio diagnostico e terapeutico delle tumefazioni della ghiandola parotide<br />
microscopica dei margini di resezione chirurgica, si è effettuata<br />
una radioterapia complementare post-operatoria.<br />
La stratificazione dei pazienti in riferimento alla classificazione<br />
TNM, ha consentito di rilevare 9 pT1N0M0 (60%)<br />
e 2 soli N+ (13,2%). Questo ultimo dato che conferma la<br />
bassa incidenza di interessamento linfonodale nel carcinoma<br />
parotideo, sconsiglia di procedere sistematicamente ad<br />
uno svuotamento profilattico dei linfonodi del collo che<br />
deve essere invece riservato ai casi in cui le caratteristiche<br />
tumorali (estensione, istotipo, grading, invasione perineurale,<br />
ecc.) sono suggestive di “aggressività” biologica<br />
del tumore e, quindi, di possibile presenza di adenopatie<br />
metastatiche.<br />
In generale i carcinomi epidermoidi e i carcinomi mucoepidermoidali<br />
ad alta malignità si associano ad una elevata<br />
frequenza di metastasi linfonodale (25-50%); cosi come,<br />
seppure con una minore incidenza, gli adenocarcinomi ad<br />
alto grado di malignità e i tumori misti maligni (25-30%).<br />
Il carcinoma adenoidocistico e il carcinoma a cellule aciniche<br />
metastatizzano per via linfatica nel 13-15%, mentre<br />
il carcinoma mucoepidermoidale a bassa malignità eccezionalmente<br />
invade i linfonodi laterocervicali. Bisogna<br />
rilevare, però, che il carcinoma adenoidocistico per la tendenza<br />
a diffondere per via perineurale può dare metastasi<br />
a distanza (polmone, ossa e cervello) anche a distanza di<br />
10-15 anni.<br />
Il follow-up medio dei pazienti affetti da neoplasia parotidea<br />
è stato di 3,5 anni (range: 10 mesi-7 anni). Si sono<br />
verificati tre casi di recidiva di neoplasia maligna da noi<br />
sottoposta a parotidectomia sovraneurale (1 caso di ca.<br />
adenoidocistico, 1 mucoepidermoide G3, 1 ca. squamocellulare).<br />
Le tre recidive osservate sono state sottoposte a<br />
trattamento di recupero mediante RT, e si trovano attualmente<br />
ancora nel follow-up.<br />
La sopravvivenza libera da malattia dopo 3 anni è risultata<br />
del 94%; mentre quella a 5 anni è del 87%.<br />
La diagnosi differenziale di una tumefazione parotidea<br />
non può prescindere da un corretto inquadramento clinico<br />
e terapeutico della lesione, in particolare relativamente ad<br />
anamnesi ed esame obiettivo. Un ruolo fondamentale è indubbiamente<br />
svolto dalle moderne metodiche di imaging<br />
quali l’ecografia, ecotomografia, la risonanza magnetica<br />
nucleare e la tomografia assiale computerizzata, finalizzate<br />
a stabilire l’esatta localizzazione topografica della lesione,<br />
il volume, i rapporti con le strutture limitrofe e con<br />
il nervo facciale.<br />
In presenza di una tumefazione palpabile della ghiandola<br />
parotide, l’esame ecotomografico rappresenta la metodica<br />
di diagnostica strumentale di prima istanza, in quanto non<br />
invasiva, di basso costo e complementare ad un eventuale<br />
esame agobioptico mirato. Il ricorso ad altre metodiche<br />
(TAC; RMN) è risultato tuttavia indispensabile in caso<br />
di lesioni voluminose (diametro superiore a 3 cm) o per<br />
lesioni di dubbia natura o quando era presumibile un interessamento<br />
del lobo profondo della ghiandola parotide.<br />
La RMN presenta comunque una maggiore sensibilità<br />
(95%) rispetto alla TAC nel riconoscere un’eventuale<br />
diffusione perineurale, evento non infrequente in particolare<br />
nei carcinomi adenoidocistici. Inoltre l’esame RMN<br />
risulta più sensibile rispetto alla TAC nell’identificazione<br />
di recidive post-chirurgiche, grazie alla possibilità di discriminare<br />
con maggiore affidabilità il tessuto fibrotico dal<br />
tessuto patologico neoformato.<br />
Nel nostro studio abbiamo messo a confronto i referti dell’ecografia,<br />
della RMN e della TAC con quelli dell’esame<br />
istologico definitivo dopo intervento di parotidectomia,<br />
per valutare l’attendibilità di queste tecniche di imaging.<br />
Dei nostri 150 pazienti esaminati, 78 hanno eseguito ecografia<br />
della regione parotidea (52%), 42 una RMN (28%)<br />
e 30 una TAC collo e regione parotidea (20%). È da considerare<br />
che in alcuni pazienti è stata praticata sia un’ecografia<br />
che un esame RMN e/o TAC, allo scopo di definire<br />
in maniera ottimale l’estensione della lesione rispetto alle<br />
strutture circostanti.<br />
Abbiamo comparato i referti ecografici, della RMN e della<br />
TAC con l’esame istologico sul pezzo operatorio, valutando<br />
in particolare i casi indicativi di adenoma pleomorfo o<br />
cistoadenolinfoma ed i casi in cui lo specialista radiologo<br />
poneva il sospetto di neoplasia maligna.<br />
Nella nostra casistica l’ecotomografia (ETG) ha fornito<br />
un corretto inquadramento diagnostico nell’85% dei pazienti<br />
affetti da adenoma pleomorfo (34/40), e addirittura<br />
nel 95% dei pazienti (19/20) affetti da tumore di Whartin.<br />
La RMN ha consentito di individuare correttamente la<br />
presenza di adenoma pleomorfo nel 96% dei casi (23/24)<br />
rilevando quindi l’alta specificità di tale esame per questa<br />
lesione, a differenza della TC che ha rivelato una specificità<br />
inferiore (10/15, pari al 67%).<br />
Per quanto concerne la scelta tra TC e RMN quali esami<br />
complementari alla ETG, generalmente la Tomografia<br />
Computerizzata si è dimostrata adeguata per dare risposta<br />
ai quesiti diagnostici non risolti dall’esame ETG, associata<br />
in un numero ristretto di casi alla FNAB. Tuttavia,<br />
laddove sono disponibili entrambi le apparecchiature, è<br />
preferibile l’impiego della risonanza magnetica che, per<br />
multiplanarietà e maggior risoluzione di contrasto, garantisce,<br />
a nostro avviso, un più agevole ed accurato bilancio<br />
dell’estensione dei processi espansivi.<br />
La chirurgia delle neoplasie della parotide è associata a<br />
complicanze costituite soprattutto da lesioni del nervo facciale<br />
e dalla sindrome di Frey. Altre complicanze come<br />
una fistola salivare, lesioni del nervo grande auricolare,<br />
ematomi o lesioni estetiche sono meno frequenti<br />
Il follow-up effettuato sui pazienti sottoposti ad intervento<br />
ha messo in evidenza la bassa incidenza di complicanze<br />
post-operatorie. Il 5% del campione ha presentato un deficit<br />
transitorio del nervo facciale di grado II, il restante<br />
95% ha presentato una normale funzione del facciale in<br />
tutte le aree. La sindrome di Frey è comparsa nel 5% dei<br />
casi; l’1% ha avuto come complicanza la comparsa di una<br />
fistola salivare parotidea. Il 60% dei nostri pazienti ha manifestato<br />
perdita della sensibilità della regione innervata<br />
dal nervo grande auricolare. Di questi il 50% ha però riacquistato<br />
la sensibilità a distanza di un periodo di tempo più<br />
o meno lungo.<br />
In 3 casi si è osservato un ematoma postoperatorio, che ha<br />
reso necessaria una revisione chirurgica immediata, con<br />
risoluzione completa del quadro clinico.<br />
Conclusioni<br />
Il nostro studio conferma l’alta incidenza di neoplasie<br />
benigne nel contesto della patologia tumorale parotidea<br />
e la esigenza di programmare, allo scopo di ottenere un<br />
risultato completo e definitivo, un approccio chirurgico<br />
33