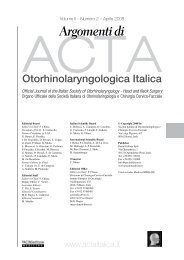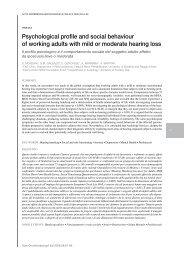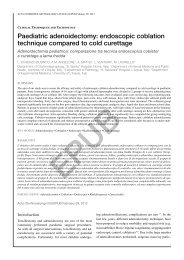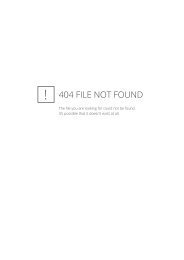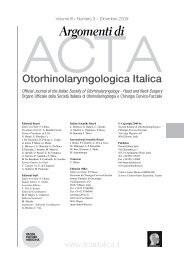argomenti 2.pdf - Acta Otorhinolaryngologica Italica
argomenti 2.pdf - Acta Otorhinolaryngologica Italica
argomenti 2.pdf - Acta Otorhinolaryngologica Italica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Argomenti di ACTA otorhinolaryngologica italica 2009; 3: 47-49<br />
Le ernie meningoencefaliche dell’osso temporale<br />
P. Fois<br />
Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, Università di Parma<br />
Introduzione<br />
L’erniazione di tessuto meningeo e/o encefalico all’interno<br />
dell’osso temporale è una patologia di raro riscontro ma<br />
potenzialmente molto pericolosa in quanto la presenza di una<br />
comunicazione tra l’orecchio medio e lo spazio subaracnoideo<br />
espone al rischio di diffusione endocranica di processi<br />
infettivi con conseguente possibile sviluppo di meningite,<br />
encefalite ed ascesso cerebrale. La disfunzione del tessuto<br />
cerebrale erniato, inoltre, può portare allo sviluppo di foci<br />
epilettogeni. Per questi motivi tale patologia richiede un<br />
trattamento chirurgico tempestivo.<br />
L’ernia meningoencefalica (EME) dell’osso temporale si<br />
sviluppa attraverso un difetto osseo della rocca petrosa<br />
generalmente localizzato a livello del tegmen mastoideo, del<br />
tegmen tympani o del tegmen antri, con conseguente erniazione<br />
di tessuto cerebrale appartenente al lobo temporale<br />
localizzato nella fossa cranica media. Molto più raramente<br />
il difetto osseo è localizzato nella faccia posteriore della<br />
rocca petrosa con erniazione di tessuto cerebellare dalla<br />
fossa cranica posteriore. In alcuni casi le ernie possono<br />
essere multiple e/o bilaterali.<br />
L’intento di questo studio è quello di analizzare gli aspetti<br />
eziopatogenetici di tale patologia, descriverne i segni e<br />
sintomi clinici ed illustrare le tecniche chirurgiche per il suo<br />
trattamento. A questo scopo è stata analizzata la casistica<br />
di gran lunga più ampia presente ad oggi nella letteratura<br />
scientifica internazionale.<br />
Materiali e Metodi<br />
Lo studio si basa sull’analisi retrospettiva dei dati clinici<br />
di 122 pazienti (63 maschi e 59 femmine) affetti da EME<br />
dell’osso temporale. Tra questi, in 11 casi la patologia era<br />
bilaterale, per un totale di 133 casi, tutti trattati chirurgicamente<br />
presso il Gruppo Otologico di Piacenza - Roma<br />
negli anni compresi tra il 1984 ed i 2006.<br />
Di ciascun paziente sono stati raccolti ed analizzati i dati<br />
pre-, intra- e post-operatori. Il follow-up è stato condotto con<br />
controlli periodici ogni 6 mesi il primo anno dopo l’intervento<br />
chirurgico ed ogni anno nel periodo successivo. Sono<br />
stati inoltre eseguiti controlli radiologici periodici, mediante<br />
tomografia computerizzata (TC) e risonanza magnetica<br />
(RM), a distanza di 1, 3 e 5 anni dall’intervento chirurgico.<br />
Risultati<br />
Dati preoperatori<br />
L’età dei pazienti alla diagnosi era compresa tra i 9 e i 78<br />
anni, con una media di 48,8 anni. In base all’eziologia le<br />
EME sono state definite come: secondarie ad otite media<br />
cronica, semplice o colesteatomatosa (29 casi, 21,8%); iatrogene,<br />
in pazienti sottoposti a precedente/i intervento/i<br />
chirurgico/i a carico dell’orecchio medio (61 casi, 45,9%);<br />
post-traumatiche, secondarie ad un trauma cranico con<br />
frattura della rocca petrosa (10 casi, 7,5%); spontanee, in<br />
assenza di dati anamnestici correlabili all’eziologia dell’ernia<br />
(33 casi, 24,8%).<br />
I sintomi presenti alla diagnosi sono riassunti nella Tabella<br />
I: quello riscontrato più frequentemente è stato l’ipoacusia,<br />
trasmissiva o mista, presente nel 87,2% dei casi. Mentre<br />
i sintomi più specifici di una EME, come la liquorrea, la<br />
meningite o l’epilessia, erano presenti soprattutto nelle forme<br />
spontanee, la maggior parte dei casi di EME iatrogena<br />
o legata ad otite media cronica erano caratterizzati dalla<br />
presenza di sintomi dovuti a quest’ultima, come otorrea<br />
mucopurulenta, otalgia ricorrente, vertigini. La liquorrea<br />
era presente al momento della diagnosi in 15 casi (11,3%<br />
del totale). In particolare presentavano liquorrea il 30% dei<br />
casi di EME post-traumatica (3 su 10) ed il 15,1% di EME<br />
spontanee (5 casi su 33). In 14 casi (10,5% del totale) la<br />
presenza della EME aveva determinato l’insorgenza di meningite,<br />
più frequentemente nei casi di EME spontanea (9<br />
su 33, 27,3%). Tre di questi pazienti riportavano anche un<br />
episodio di ascesso cerebrale nell’infanzia e altri 2 pazienti<br />
riferivano un ascesso cerebrale prima della diagnosi senza<br />
alcun segno di meningite. Pregressi episodi di epilessia erano<br />
stati riferiti da 3 pazienti con EME spontanea e in un<br />
caso di EME iatrogena. Altri sintomi presenti alla diagnosi<br />
erano: acufene (pulsante o non), paralisi del VII n.c. (in un<br />
caso di EME iatrogena), nevralgie trigeminali e cefalea.<br />
I pazienti con EME bilaterale appartenevano più frequentemente<br />
al gruppo delle ernie spontanee (6 pazienti), più<br />
47<br />
Tab. I. Presentazione clinica in base all’eziologia.<br />
Eziologia Ipoacusia OMC related Vertigine Liquorrea Meningite Epilessia Altri<br />
OMC 27 21 9 - 1 - 6<br />
Iatrogene 55 31 13 7 3 1 5<br />
Post-traumatiche 9 - - 3 1 - 1<br />
Spontanee 25 - 8 5 9 3 4<br />
TOTALE 116 52 30 15 14 4 16<br />
OMC related: disturbi correlati all’otite media cronica (otorrea purulenta, otalgia ricorrente).