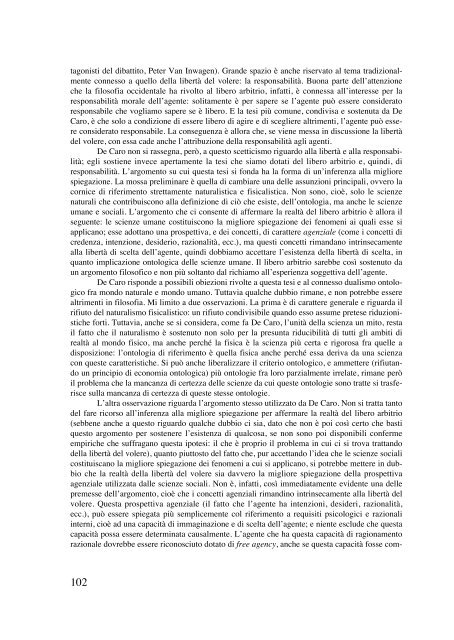Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
tagonisti del dibattito, Peter Van Inwagen). Grande spazio è anche riservato al tema tradizionalmente<br />
connesso a quello della libertà del volere: la responsabilità. Buona parte dell’attenzione<br />
che la filosofia occidentale ha rivolto al libero arbitrio, infatti, è connessa all’interesse per la<br />
responsabilità morale dell’agente: solitamente è per sapere se l’agente può essere considerato<br />
responsabile che vogliamo sapere se è libero. E la tesi più comune, condivisa e sostenuta da De<br />
Caro, è che solo a condizione di essere libero di agire e di scegliere altrimenti, l’agente può essere<br />
considerato responsabile. La conseguenza è allora che, se viene messa in discussione la libertà<br />
del volere, con essa cade anche l’attribuzione della responsabilità agli agenti.<br />
De Caro non si rassegna, però, a questo scetticismo riguardo alla libertà e alla responsabilità;<br />
egli sostiene invece apertamente la tesi che siamo dotati del libero arbitrio e, quindi, di<br />
responsabilità. L’argomento su cui questa tesi si fonda ha la forma di un’inferenza alla migliore<br />
spiegazione. La mossa preliminare è quella di cambiare una delle assunzioni principali, ovvero la<br />
cornice di riferimento strettamente naturalistica e fisicalistica. Non sono, cioè, solo le scienze<br />
naturali che contribuiscono alla definizione di ciò che esiste, dell’ontologia, ma anche le scienze<br />
umane e sociali. L’argomento che ci consente di affermare la realtà del libero arbitrio è allora il<br />
seguente: le scienze umane costituiscono la migliore spiegazione dei fenomeni ai quali esse si<br />
applicano; esse adottano una prospettiva, e dei concetti, di carattere agenziale (come i concetti di<br />
credenza, intenzione, desiderio, razionalità, ecc.), ma questi concetti rimandano intrinsecamente<br />
alla libertà di scelta dell’agente, quindi dobbiamo accettare l’esistenza della libertà di scelta, in<br />
quanto implicazione ontologica delle scienze umane. Il libero arbitrio sarebbe così sostenuto da<br />
un argomento filosofico e non più soltanto dal richiamo all’esperienza soggettiva dell’agente.<br />
De Caro risponde a possibili obiezioni rivolte a questa tesi e al connesso dualismo ontologico<br />
fra mondo naturale e mondo umano. Tuttavia qualche dubbio rimane, e non potrebbe essere<br />
altrimenti in filosofia. Mi limito a due osservazioni. La prima è di carattere generale e riguarda il<br />
rifiuto del naturalismo fisicalistico: un rifiuto condivisibile quando esso assume pretese riduzionistiche<br />
forti. Tuttavia, anche se si considera, come fa De Caro, l’unità della scienza un mito, resta<br />
il fatto che il naturalismo è sostenuto non solo per la presunta riducibilità di tutti gli ambiti di<br />
realtà al mondo fisico, ma anche perché la fisica è la scienza più certa e rigorosa fra quelle a<br />
disposizione: l’ontologia di riferimento è quella fisica anche perché essa deriva da una scienza<br />
con queste caratteristiche. Si può anche liberalizzare il criterio ontologico, e ammettere (rifiutando<br />
un principio di economia ontologica) più ontologie fra loro parzialmente irrelate, rimane però<br />
il problema che la mancanza di certezza delle scienze da cui queste ontologie sono tratte si trasferisce<br />
sulla mancanza di certezza di queste stesse ontologie.<br />
L’altra osservazione riguarda l’argomento stesso utilizzato da De Caro. Non si tratta tanto<br />
del fare ricorso all’inferenza alla migliore spiegazione per affermare la realtà del libero arbitrio<br />
(sebbene anche a questo riguardo qualche dubbio ci sia, dato che non è poi così certo che basti<br />
questo argomento per sostenere l’esistenza di qualcosa, se non sono poi disponibili conferme<br />
empiriche che suffragano questa ipotesi: il che è proprio il problema in cui ci si trova trattando<br />
della libertà del volere), quanto piuttosto del fatto che, pur accettando l’idea che le scienze sociali<br />
costituiscano la migliore spiegazione dei fenomeni a cui si applicano, si potrebbe mettere in dubbio<br />
che la realtà della libertà del volere sia davvero la migliore spiegazione della prospettiva<br />
agenziale utilizzata dalle scienze sociali. Non è, infatti, così immediatamente evidente una delle<br />
premesse dell’argomento, cioè che i concetti agenziali rimandino intrinsecamente alla libertà del<br />
volere. Questa prospettiva agenziale (il fatto che l’agente ha intenzioni, desideri, razionalità,<br />
ecc.), può essere spiegata più semplicemente col riferimento a requisiti psicologici e razionali<br />
interni, cioè ad una capacità di immaginazione e di scelta dell’agente; e niente esclude che questa<br />
capacità possa essere determinata causalmente. L’agente che ha questa capacità di ragionamento<br />
razionale dovrebbe essere riconosciuto dotato di free agency, anche se questa capacità fosse com-<br />
102