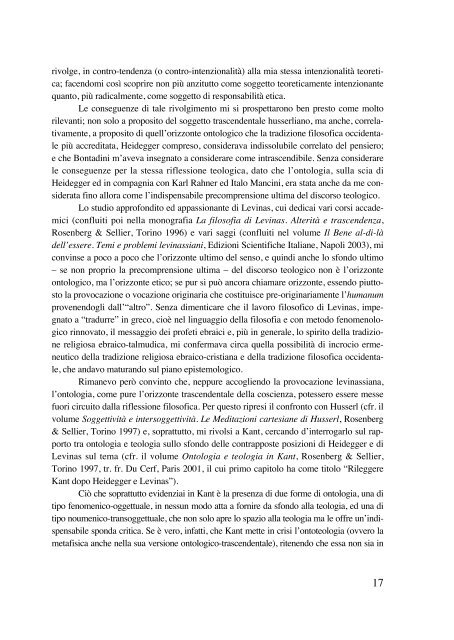Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ivolge, in contro-tendenza (o contro-intenzionalità) alla mia stessa intenzionalità teoretica;<br />
facendomi così scoprire non più anzitutto come soggetto teoreticamente intenzionante<br />
quanto, più radicalmente, come soggetto di responsabilità etica.<br />
Le conseguenze di tale rivolgimento mi si prospettarono ben presto come molto<br />
rilevanti; non solo a proposito del soggetto trascendentale husserliano, ma anche, correlativamente,<br />
a proposito di quell’orizzonte ontologico che la tradizione filosofica occidentale<br />
più accreditata, Heidegger compreso, considerava indissolubile correlato del pensiero;<br />
e che Bontadini m’aveva insegnato a considerare come intrascendibile. Senza considerare<br />
le conseguenze per la stessa riflessione teologica, dato che l’ontologia, sulla scia di<br />
Heidegger ed in compagnia con Karl Rahner ed Italo Mancini, era stata anche da me considerata<br />
fino allora come l’indispensabile precomprensione ultima del discorso teologico.<br />
Lo studio approfondito ed appassionante di Levinas, cui dedicai vari corsi accademici<br />
(confluiti poi nella monografia La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza,<br />
Rosenberg & Sellier, Torino 1996) e vari saggi (confluiti nel volume Il Bene al-di-là<br />
dell’essere. Temi e problemi levinassiani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2003), mi<br />
convinse a poco a poco che l’orizzonte ultimo del senso, e quindi anche lo sfondo ultimo<br />
– se non proprio la precomprensione ultima – del discorso teologico non è l’orizzonte<br />
ontologico, ma l’orizzonte etico; se pur si può ancora chiamare orizzonte, essendo piuttosto<br />
la provocazione o vocazione originaria che costituisce pre-originariamente l’humanum<br />
provenendogli dall’“altro”. Senza dimenticare che il lavoro filosofico di Levinas, impegnato<br />
a “tradurre” in greco, cioè nel linguaggio della filosofia e con metodo fenomenologico<br />
rinnovato, il messaggio dei profeti ebraici e, più in generale, lo spirito della tradizione<br />
religiosa ebraico-talmudica, mi confermava circa quella possibilità di incrocio ermeneutico<br />
della tradizione religiosa ebraico-cristiana e della tradizione filosofica occidentale,<br />
che andavo maturando sul piano epistemologico.<br />
Rimanevo però convinto che, neppure accogliendo la provocazione levinassiana,<br />
l’ontologia, come pure l’orizzonte trascendentale della coscienza, potessero essere messe<br />
fuori circuito dalla riflessione filosofica. Per questo ripresi il confronto con Husserl (cfr. il<br />
volume Soggettività e intersoggettività. Le Meditazioni cartesiane di Husserl, Rosenberg<br />
& Sellier, Torino 1997) e, soprattutto, mi rivolsi a Kant, cercando d’interrogarlo sul rapporto<br />
tra ontologia e teologia sullo sfondo delle contrapposte posizioni di Heidegger e di<br />
Levinas sul tema (cfr. il volume Ontologia e teologia in Kant, Rosenberg & Sellier,<br />
Torino 1997, tr. fr. Du Cerf, Paris 2001, il cui primo capitolo ha come titolo “Rileggere<br />
Kant dopo Heidegger e Levinas”).<br />
Ciò che soprattutto evidenziai in Kant è la presenza di due forme di ontologia, una di<br />
tipo fenomenico-oggettuale, in nessun modo atta a fornire da sfondo alla teologia, ed una di<br />
tipo noumenico-transoggettuale, che non solo apre lo spazio alla teologia ma le offre un’indispensabile<br />
sponda critica. Se è vero, infatti, che Kant mette in crisi l’ontoteologia (ovvero la<br />
metafisica anche nella sua versione ontologico-trascendentale), ritenendo che essa non sia in<br />
17