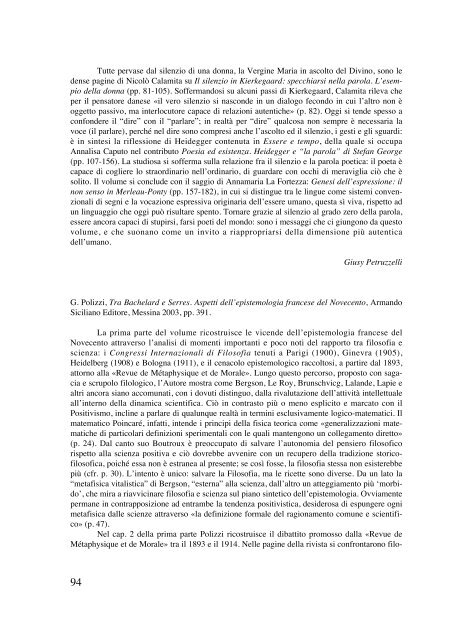Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Bollettino n. 184 - Società Filosofica Italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tutte pervase dal silenzio di una donna, la Vergine Maria in ascolto del Divino, sono le<br />
dense pagine di Nicolò Calamita su Il silenzio in Kierkegaard: specchiarsi nella parola. L’esempio<br />
della donna (pp. 81-105). Soffermandosi su alcuni passi di Kierkegaard, Calamita rileva che<br />
per il pensatore danese «il vero silenzio si nasconde in un dialogo fecondo in cui l’altro non è<br />
oggetto passivo, ma interlocutore capace di relazioni autentiche» (p. 82). Oggi si tende spesso a<br />
confondere il “dire” con il “parlare”; in realtà per “dire” qualcosa non sempre è necessaria la<br />
voce (il parlare), perché nel dire sono compresi anche l’ascolto ed il silenzio, i gesti e gli sguardi:<br />
è in sintesi la riflessione di Heidegger contenuta in Essere e tempo, della quale si occupa<br />
Annalisa Caputo nel contributo Poesia ed esistenza. Heidegger e “la parola” di Stefan George<br />
(pp. 107-156). La studiosa si sofferma sulla relazione fra il silenzio e la parola poetica: il poeta è<br />
capace di cogliere lo straordinario nell’ordinario, di guardare con occhi di meraviglia ciò che è<br />
solito. Il volume si conclude con il saggio di Annamaria La Fortezza: Genesi dell’espressione: il<br />
non senso in Merleau-Ponty (pp. 157-182), in cui si distingue tra le lingue come sistemi convenzionali<br />
di segni e la vocazione espressiva originaria dell’essere umano, questa sì viva, rispetto ad<br />
un linguaggio che oggi può risultare spento. Tornare grazie al silenzio al grado zero della parola,<br />
essere ancora capaci di stupirsi, farsi poeti del mondo: sono i messaggi che ci giungono da questo<br />
volume, e che suonano come un invito a riappropriarsi della dimensione più autentica<br />
dell’umano.<br />
Giusy Petruzzelli<br />
G. Polizzi, Tra Bachelard e Serres. Aspetti dell’epistemologia francese del Novecento, Armando<br />
Siciliano Editore, Messina 2003, pp. 391.<br />
La prima parte del volume ricostruisce le vicende dell’epistemologia francese del<br />
Novecento attraverso l’analisi di momenti importanti e poco noti del rapporto tra filosofia e<br />
scienza: i Congressi Internazionali di Filosofia tenuti a Parigi (1900), Ginevra (1905),<br />
Heidelberg (1908) e Bologna (1911), e il cenacolo epistemologico raccoltosi, a partire dal 1893,<br />
attorno alla «Revue de Métaphysique et de Morale». Lungo questo percorso, proposto con sagacia<br />
e scrupolo filologico, l’Autore mostra come Bergson, Le Roy, Brunschvicg, Lalande, Lapie e<br />
altri ancora siano accomunati, con i dovuti distinguo, dalla rivalutazione dell’attività intellettuale<br />
all’interno della dinamica scientifica. Ciò in contrasto più o meno esplicito e marcato con il<br />
Positivismo, incline a parlare di qualunque realtà in termini esclusivamente logico-matematici. Il<br />
matematico Poincaré, infatti, intende i principi della fisica teorica come «generalizzazioni matematiche<br />
di particolari definizioni sperimentali con le quali mantengono un collegamento diretto»<br />
(p. 24). Dal canto suo Boutroux è preoccupato di salvare l’autonomia del pensiero filosofico<br />
rispetto alla scienza positiva e ciò dovrebbe avvenire con un recupero della tradizione storicofilosofica,<br />
poiché essa non è estranea al presente; se così fosse, la filosofia stessa non esisterebbe<br />
più (cfr. p. 30). L’intento è unico: salvare la Filosofia, ma le ricette sono diverse. Da un lato la<br />
“metafisica vitalistica” di Bergson, “esterna” alla scienza, dall’altro un atteggiamento più ‘morbido’,<br />
che mira a riavvicinare filosofia e scienza sul piano sintetico dell’epistemologia. Ovviamente<br />
permane in contrapposizione ad entrambe la tendenza positivistica, desiderosa di espungere ogni<br />
metafisica dalle scienze attraverso «la definizione formale del ragionamento comune e scientifico»<br />
(p. 47).<br />
Nel cap. 2 della prima parte Polizzi ricostruisce il dibattito promosso dalla «Revue de<br />
Métaphysique et de Morale» tra il 1893 e il 1914. Nelle pagine della rivista si confrontarono filo-<br />
94